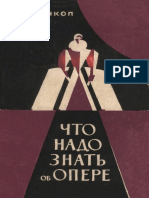Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
274.Итальянский язык «l'arte lirica» PDF
274.Итальянский язык «l'arte lirica» PDF
Загружено:
IvanioОригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
274.Итальянский язык «l'arte lirica» PDF
274.Итальянский язык «l'arte lirica» PDF
Загружено:
IvanioАвторское право:
Доступные форматы
Copyright & A K-C
LARTE LIRICA
12-
070100 ,
2011
Copyright & A K-C
:
. . ,
. . ,
. .
08.11.2010 .,
3.
- 23.11.2010 ., 3.
larte lirica []:
12- 070100
, /
. . . . : , 2011. 124 .
:
. .
. .
Copyright & A K-C
..... 4
.. 5
XVIIXX . ..... 17
... 29
.... 73
....... 82
.... 98
1 ( ) ..... 100
2 () .... 104
3 ( )....... 113
Copyright & A K-C
12- 070100 ,
.
/ .
, ,
.
, , .
, ,
,
, ,
.
( ) (
); ,
. ,
.
.
.
, , -
,
.
4
Copyright & A K-C
LO SVILUPPO DEL TEATRO MUSICALE IN ITALIA
La fioritura madrigalistica in Italia
Nel Quattrocento si nota la fioritura di musiche profane e popolari, dei
canti carnavaleschi. Questi canti erano poesie, cantate al tempo di carnevale, in
cui il popolo partecipava, come attore e spettatore, sui carri che erano
palcoscenici ambulanti. I pi in voga erano i trionfi, di carattere guerresco, e le
canzoni a ballo di vario argomento; ci sono pervenuti pi di 400 canti (celebri
quelli di Lorenzo de' Medici). Affini ai canti carnascialeschi erano altre
forme: la frottola,componimento di soggetto amoroso, in forma di balata con
accompagnamento strumentale (liuto, viola) e la villotta (a quattro voci). Il
compito della musica divenne quello di nterpretare i sentimenti e le passioni
della gente comune. La musica profana, e in particolare quella strumentale,
conquistava posizioni sempre pi elevate. Una nuova epoca nata.
I caratteri propri del Rinascimento trovarono la loro pi pura
espressione nella pittura di Raffaello Sanzio (Santi) e nella musica di Giovanni
Palestrina (15251594). La forma musicale che venne maggiormente
coltivata nel Cinquecento, fu il madrigale, la pi tipica forma della lirica
musicale italiana di questo periodo. Generalmente a cinque voci, era di
argomento amoroso, ma anche satirico e burlesco, accompagnato da ritornelli
strumentali. I madrigale fu prediletto dai compositori veneti e coltivato presso
le corti. Tra i compositori pi insigni il bresciano Luca Marenzio (1553
1599), autore di molti volumi di madrigali a quattro, cinque, sei voci. Una
forma particolare del madrigale che costituisce uno dei precedenti del
melodramma, il madrigale drammatico o dialogato, spesso raffigurante scene
comiche. In questo genere primeggi il modenese Orazio Vecchi (1550
1605); fra le sue composizioni madrigalesche, celebre l'"Amfiparnaso" a
cinque voci, tratto da una commedia dell'arte. Agli inizi del Seicento, vede la
luce il madrigale concertato, in cui si univano una pi voci e strumenti.
Massimo esponente di questa nuova forma il cremonese Claudio Monteverdi
5
Copyright & A K-C
(15671643), i cui otto libri di madrigali rappresentano il apogeo e la sintesi di
tutta la produzione in questo campo.
_______________________________________________________________
1
Lorenzo di Medici
, .
2
Giovanni Palestrina .
3
Luca Morenzo .
Le origini del teatro musicale italiano
Fino al 1594 gli spettacoli, in cui aveva parte la musica, furono sacre
rappresentazioni, drammi sacri e favole pastorali con brani musicali, feste di
corte con musica e comedie con musicali intermedi. Ma encore non cera uno
spettacolo teatrale, composto interamente di unazione drammatica, tutta
accompagnata da musica, e di musica che doveva commentare il soggetto, i
sentimenti e fin le parole.
Un primo esperimento di un tale spettacolo si ebbe nel carnevale del
15941595 quando reppresentata a Firenze in una casa private la Dafne .
Lautore dei versi fu Ottavio Rinuccini , la musica era di Corsi e di Giacomo
Peri, contrapunntista e cantore squisito. Essi facevano parte della famosa
Camerata Fiorentina che sul finir del Cinquecento riuniva letterati, artisti,
dilettanti, nobili fiorentini e intendeva di rinnovare larte musicale, riconduce
alle fonti della tragedia greca. Essi si radunavano in casa di Bardi e di Corsi.
La musica della Dafne perduta, soltanto due brevi frammenti erano
trovati nel Conservatorio di Bruxelles. Nel 1600 a Firenze fu rappresentata
lEuridice dove assist Claudio Monteverdi che con grande interesse ascolt
questopera. La tragedia di Rinuccini non divisa in atti, ma inscene e si
compone quasi tutta di lunghi recitative di una semplicit estrema; non ha
sinfina n preludio.Magnifico fu lapparato scenico. Seguirono poi altre opera
di Caccini e di Galli a Firenze, a Bologna e in alter citt dItalia, a Mantova fu
rappresentato l Orfeo di Monteverdi nel 1607, ma appunto a Firenze, la
sera del 6 ottobre 1600, nacque lopera italiana.
6
Copyright & A K-C
Claudio Monteverdi fece un passo avanti, egli la dot di un linguaggio
musicale pi perfetto per esprimere tutte le passione drammatiche.
1
O. Rinuccini , .
Corsi, Giacomo Peri .
3
La Camerata Fiorentina ,
, 1580 .
2
La nascita del melodrama a Firenze
Fin dagli ultimi anni del Cinquecento a Firenze, in casa di Giovanni
Bardi e poi in quella di Jacopo Corsi si riuniva la cosiddetta Camerata
Fiorentina, un gruppo di intellettuali che intendevano risuscitare la tragedia
greca e creare la forma in cui musica e testo drammatico avrebbero potuto
unirsi. Essi crearono lo stile del "recitar cantando" basato sulla monoda con
accompagnamento strumentale. Questo nuovo stile monodico cre il recitativo
e l'aria. Vincenzo Galilei, umanista, compositore e teorico, accademico della
Crusca fu una delle figure dominanti nel gruppo della Camerata fiorentina.
Unendo la pratica alla teoria, egli music l'episodio di Ugolino dalla "Divina
Commedia" di Dante Alighieri ("Inferno", Canto 33), per voce sola con
accompagnamento di viola.
Jacopo Peri e Giulio Caccini furono i primi esponenti del nuovo stile:
continuando il tentativo del Galilei, il Caccini stabil definitivamente uno stile
di canto recitativo ("quasi in armona favellare"). Jacopo Peri con il poeta
Rinuccini cre il dramma recitativo con la "Dafne" (159495), che fu eseguita
durante il carnevale nel 1598 in casa di Jacopo Corsi, un nobile fiorentino,
amatore di arte e compositore; la sua casa era sempre aperta ai letterati, poeti e
musicisti J. Corsi appartenne alla Camerata Fiorentina e contribu alla "Dafne"
come compositore, con due brani (music ultime due scene). L'entusiasmo per
questa scoperta musicale (il dramma recitativo) fu enorme e venne poi definita
"recitar" o "favellar cantando". (Purtroppo, la "Dafne" perduta e di essa
sappiamo soltanto che fu rappresentata in casa di Corsi dapprima, e poi, fu
ripetuta nel 1599 alla corte dei Medici.) A questo primo esperimento segu
l'"Euridice", rappresentata al Palazzo Pitti il 6 ottobre 1600, perch la data
della nascita dell'opera. Era nato cos il melodramma, quasi interamente
7
Copyright & A K-C
recitativo, con brevi pezzi melodici, pochi cori e tenue accompagnamento
strumentale; ma pur essendo quasi una semplice declamazione del testo, esso
si diffuse subito in tutte le citt italiane, dovunque accolto con entusiasmo. In
breve tempo le conquiste della Camerata Fiorentina e il canto monodico fecero
progressi grandissimi. Spetta a Monteverdi il merito di avere perfezionato e
reso popolare la nuova forma dell'arte, liberandola dallo stile puramente
recitativo e assegnanto alla musica una funzione veramente artistica. La sua
opera principale l Orfeo, rappresentato a Mantova nel 1607. Monteverdi fu
anche un innovatore nel campo della tecnica musicale e della strumentazione.
Giovanni Bardi .
Crusca ( 1583 ), .
2
Usi teatrali del Seicento a Venezia
Nel 1637 con la participazione di Monteverdi fu creato a Venezia il
primo teatre musicale (il San Cassiano ), aperto al pubblico con il
pagamento dun biglietto dingresso. Fra due anni si aprirono altri due teatri
con spettacoli di musica, poi il numero dei teatri lirici a Venezia crebbe fino a
sedici.
I compositori prediletti dei teatri veneziani erano Monteverdi, Cavalli,
Cesti, Caldara, Legrenzi. Il carattere del teatro musicale veneziano si
differenzia dal teatro dei fiorentini, le favole mitologiche cedono a poco poco
il posto ai soggetti storici. Il pubblico nuovo che ora frequentava il teatro,
voleva appassionarsi e commuoversi alle vicende dellazione drammatica, e lo
spettacolo doveva essere presentare la vita reale. Il melodrama continu a
svilupparsi. Accanto al recitative si sviluppa la frase melodica che prende la
forma di aria; i cori non hanno pi una grande importanza e si sostituiscono
dal canto monodico, dagli a soli .
I teatri di Venezia erano di propriet privata, sotto il controllo
dellAutorit Pubblica. I manifesti dovevano affiggersi in due luoghi: sulla
Piazetta e a Rialto, nel centro di Venezia, e gli strillonni annuziavano dello
spettacolo per via.
8
Copyright & A K-C
Non vi era a teatro alcuna distinzioni di posti, n alcuna guardia
sorvegliava la sala. Allingresso del teatro si trovavano numerosi venditori di
mele e pere cotte, di fritelle, liquori. Lilluminazione della sala era scarsa. Un
fanale a olio che la illuminava veniva, appena salzava il sipario. Restavano
accesi soltanto due doppieri di legno ai lati proscenio.
Tutta lattenzione era concentrate al palcoscenico con lo splendore delle
decorazioni e complicatezza dei meccanismi. Le spese delle rappresentazioni
non erano molte: nulla, nei primi tempi, si pagava ai librettisti, ai quali bastava
la gloria. Pochissimo ricevevano i compositori e i cantanti (solo alla fine della
stagione).
A Venezia, oltre ai teatri pubblici e private, cerano molti teatrini di
marionette, nei quali si davano intere opera di musica, eseguite dalle
marionette, ma cantante (internamente) anche da virtuosi eccellenti. Il teatro
musicale divent una passione generale, e la diffusione dellopera musicale fu
enorme.
_______________________________________________________________
1
2
3
Autorit Pubblica .
Piazetta .
Rialto , .
IL TEATRO MUSICALE A VENEZIA E A ROMA NEL SEICENTO
II teatro musicale a Venezia
Un avvenimento importante nel 1637 che doveva avere una grande
influenza sullo sviluppo del melodramma: il primo teatro d'opera, aperto al
pubblico a Venezia,costruito da una famiglia patrizia i Tron. Fu questo il San
Cassiano, inaugurato con opera "Andromeda". II teatro d'opera conosce
subito una fortuna straordinaria, tanto che altre famiglie patrizie si dedicarono
alla stessa impresa; nel 1639 s'inaugurarono ancora due teatri lirici. Prima
della fine del secolo Venezia contava ben sedici teatri d'opera. I "palchetti"
(invenzione veneziana) veniano affittati per una stagione per tutto l'anno, ed
erano frequentati dalla nobilt.
9
Copyright & A K-C
Gli impresari dovettero rivolgersi a Monteverdi per ottenere da lui
opere. La sua prima opera "Orfeo" fu rappresentata con gran successo. Nel
1608 Monteverdi compose la sua seconda opera "Arianna" e nel 1613 egli si
trasfer a Venezia.
La stagione d'autunno del teatro S. Mois a Venezia s'inaugura con una
ripresa trionfale di "Arianna" di Monteverdi; il successo cosi grande che
1'opera si dove ripetere ancora l'anno seguente.
Nel 1641 Monteverdi che ha 74 anni conduce avanti la composizione di
due opere: "Le nozze di Enea con Lavinia" e "Il ritorno di Ulisse in patria" che
sono messe nello stesso anno. L'attivit di Monteverdi in questo periodo e
grandissima, egli presenta al teatro Grimani (S. S. Giovanni e Paolo) suo
ultimo capolavoro: "L'incoronazione di Poppea", ottenendo un tal successo
che l'opera dovette essere ripresa pi volte negli anni seguenti fino al 1646. Il
successore (e forse anche allievo) di Claudio Monteverdi a Venezia fu
Francesco Cavalli (16021676), uno dei maggiori operisti del Seicento. Egli
continu le tendenze dell'opera veneziana con caratteristiche proprie.
Svolgendo un'intensa attivit in campo teatrale, F. Cavalli avra conosciuto le
idee fondamentali della Camerata Fiorentina. Nel 1639 Cavalli scrisse la sua
prima opera scenica "Le nozze di Teti e Peleo" (qui appare per la prima volta
il nome d'opera). Nella prima opera del Cavalli si notano le forme e anche i
difetti dei fiorentini; e opera ricca di brani musicali. Una delle sue migliori
opere e la "Didone", rappresentata sulle scene del teatro a San Cassiano.
Francesco Cavalli cap che la musica nel teatro doveva abbandonare a poco a
poco la polifona per accettare monoda, rinunziare allo stile madrigalesco, e
perfezionare il nuovo stile recitativo. Il Cavalli cre il suo stile recitativo pieno
di vita e di espressione. Nelle sue opere troviamo gi le forme dell'aria
tripartita.
Francesco Cavalli compose 40 opere.
_______________________________________________________________
1
San Cassiano ( XIV ),
e.
2
Santi Giovanni e Paolo Grimani .
10
Copyright & A K-C
La scuola di canto romana
II teatro musicale a Roma fu importato da Firenze e assomigli a quello,
ma vi si notano saggi di genere comico e popolare, e dall'altro lato, hanno
luogo i drammi di soggetto semisacro, ma di tipo teatrale. II teatro romano era
protetto dai patrizi romani Barberini ed altri, grande influsso ebbero i
pontefici. I due papi Innocenzo XI e XII proibirono le rappresentazioni, e un
teatro era dietro I'ordine del Papa demolito. Gli spettacoli dei teatri romani
dovettero i loro successi non al valore musicale, ma alla sontuosit
dell'addobbo scenico alla esaltazione di tutti per il nuovo genere d'arte.
In gran voga a Roma erano i cantanti.
Fin dall'inizio del teatro musicale rinomatissima fu la scuola di canto
romana, fu scritto a Roma il primo "Metodo di canto", e a Giulio Caccini
spettano le "Nuove musiche".
Tra le cantanti romane pi celebri del Seicento erano Vittoria
Archilei,Anna Renzi, Cecca dal Padule, Maria la Pia e molte altre, ma due
sopra tutte hanno raggiunto una grande fama ed hanno lasciato maggior
ricordo di s nella storia: Leonora Baroni e Adriana Basile. II poeta inglese
Milton celebr la Baroni con tre epigrammi latini "Ad Leonoram Romae
canentem".
Anche fra uomini vi erano cantanti splendidi. Le donne furono ammesse
al teatro pi tardi e varie furono allontanate. I sopranisti romani erano spesso
grandi artisti e interpretavano benissimo le parti di donne. Molti eccellenti
cantanti vantavano i teatri romani nel Seicento. Come dovevano essere le
scuole di canto che preparavano tali cantanti? Le notizie sono scarse. Era
celebre la scuola di canto di Roma, diretta da V. Mazzochi, professore e
maestro di capella di San Pietro. Gli allievi vi imparavano a cantare sotto
ludito del maestro e davanti a uno specchio per non fare inconveniente,
studiavano le lettere, suonavano il clavicembalo, si esercitavano nella
composizione di qualche salmo, canzonetta o motteto.
Il melodrama teatrale pass da Venezia non solo a Roma ma anche a
Napoli nella seconda met del Seicento, e il teatro lirico napoletano fu linizio
di una nuova fase.
_______________________________________________________________
1
Giulio Caccini , .
11
Copyright & A K-C
2
3
Leonora Baroni , IX.
Adriana Basile ( ).
LOPERA ITALIANA NEL SETTOCENTO
La Scala nel Settecento e Ottocento
II teatro alla Scala cominci a vivere, come noto, il 3 aprile 1778.
Negli anni 17781790 alla Scala erano rappresentate 70 opere di diversi autori
(25 composte appositamente per la Scala) fra cui "Il matrimonio segreto" di
Cimarosa "II Barbiere di Siviglia" di Paisiello. In quei tempi i cittadini
andavano al teatro d'opera per divertirsi. La Scala del Settecento, e in parte
anche dell'Ottocento, fu un centro di ritrovo dei milanesi, funzionava da
salotto per la societ aristocratica, da ristorante, sala da gioco e da ballo. I
palchi della Scala erano di propriet privata, e ogni proprietario ci si sentiva
come a casa sua, anzi, ci aveva la chiave del palco. La padrona del palco
teneva conversazione, offriva la cena. La tenda del palco s'alzava spesso
soltanto per ascoltare 1aria preferita o per giudicare della bellezza di una
nuova ballerina. Poi ad una certa ora i servitori bussavano timidamente alla
porta per annunciare che lo spettacolo era finito e che bisognava andarsene.
Nel ridotto del teatro fino a notte tarda si giocava a carte.
Nei primi anni la Scala rimaneva aperta tutto l'anno, alternando l'opera
seria e buffa con balli, commedie e feste. Ci venivano anche i saltimbanchi e i
funamboli. Una compagna comica, per attirare il pubblico, aveva dato alla
Scala una caccia al toro. Le ultime bizzarie del Settecento galante...
Alla Scala si gioca alle carte e gi si parla delle idee nuove. Nello stesso
salotto sono seduti insieme il celebre poeta Giuseppe Parini, un pensatore
rivoluzionario come Cesare Beccaria e gli avventurieri internazionali. II
teatro era un po' simbolo di questo mondo.
L'Ottocento non ha cambiato quasi niente. Per affermarsi come artisti, i
musicisti italiani vanno all'estero. Rossini e Bellini vanno a Parigi e a Vienna,
Verdi a Parigi, a Londra, a Pietroburgo. Solamente dopo le grandi prime
verdiane dell'"Otello'' (1887) e del "Falstaff" (1893) il centro musicale europeo
si sposta alla Scala. II nuovo periodo della vita del teatro apre Arturo
Toscanini con le sue riforme. II teatro era ancora propriet dei palchettisti,
12
Copyright & A K-C
come cento anni fa; agli spettacoli si chiacchierava liberamente. Il
sovrintendente era rappresentante di una delle famiglie nobili, Guido Visconti.
Toscanini impone i nuovi ordini.Tutta laristocrazia costretta ad arrivare in
orario, a stare al buio, a rinunciare ai bis, a sentire opera nuove e
difficili:Wagner, e i compositori della Giovane Scuole verista Mascagni,
Puccini ed altri. Con Toscanini inizia la rinascita democratica del teatro.
_______________________________________________________________
1
2
Cesare Beccaria , , .
Arturo Toscanini XIX .
L'opera seria e la fioritura del l'opera buffa a Napoli
La scuola musicale napoletana rappresenta la terza fase (dopo quella
fiorentina e veneziiana) e nel Settecento ha la posizione dominante. L'opera
napoletana si presenta sotto il duplice aspetto di "opera seria" e di "opera
buffa". L'opera seria si riduce a una successione di arie inframezzate da
recitativi, con qualche coro e pezzo d'insieme.
La musica diventa lo scopo e il dramma un pretesto. II concetto
convenzionale e
stereotipato, l'aria notevolmente sviluppata sotto molteplici aspetti (aria di
carattere, di sentimento, di bravura, arietta, cavatina, cabaletta), e grande
importanza assume il virtuosismo canoro.
Gli spettatori napoletani nel Settecento s'interessavano soltanto dell'aria,
il recitativo and perdendo d'importanza e divenne insignificante. Le altre
parti del melodramma passarono in seconda linea, rari divennero i cori e pi
che altro a scopo puramente decorativo, i pezzi d'insieme, quasi limitati ai
duetti, pochissimi essendo i terzetti, meno ancora i quartetti, semplice la
strumentazione, spesso di soli archi, destinata quasi esclusivamente
all'accompagnamento del canto. Questi erano gli elementi di un'opera seria,
che bastavano ad allettare un pubblico per tutta la sera e per una intera
stagione.
Nacque cos un particolare stile vocale virtuosistico, consistente nel
cantare lunghi passaggi musicali su una sola sillaba (vocalizzare) con trilli e
abbellimenti. Di solito tali passaggi non venivano scritti dal compositore, ma
improvvisati dallo stesso cantante. Nel melodramma fiorentino domina il
13
Copyright & A K-C
poeta e in quello veneziano il musicista: il melodramma napoletano fa
primeggiare il cantante, e il periodo del bel canto. L'azione nell'opera seria
preferisce gli eroi della storia antica: Enea, Romolo, Attilio e Alessandro di
Macedonia sono riprodotti in centinaia di opere. Al soggetto il pubblico
badava cos poco che era contento, se lo stesso libretto gli ricompariva pi
volte dinanzi, purch accompagnato di musica nuova. Una cosa per
interessava: cio che l'azione, a dispetto della verit e della storia, avesse lieto
fine. Certo vi erano dei libretti seri come quelli del Metastasio, ma non erano
molti.
Mentre il pubblico del Seicento aveva dimostrato un grande
interessamento per l'apparato scenico, per i meccanismi, per tutto ci che
appariva d'effetto, il pubblico del Settecento non lo apprezzava affatto e
questo fu eliminato quasi del tutto. Tra i compositori pi eminenti ricoderemo
Alessandro Scarlatti, Nicola Piccinni, Giovanni Pergolesi.
_______________________________________________________________
1
Pietro Metastasio XVII .
Lopera buffa
Il Settecento e il secolo che conobbe la grandiosa fioritura dell'opera
buffa, la quale si distacco dall'opera seria e fiori prima a Napoli e poi in
Europa. L'opera buffa corrispose allora e per molto tempo anche poi, ad un
bisogno di un po' di buon umore, di un po' di gaiezza. I teatri l'accolsero
subito, e i compositori della scuola napoletana, crearono veri capolavori
dell'opera buffa. Il 28 agosto del 1733 si rappresentava in un teatro napoletano
1'opera seria di Pergolesi "Il prigionier superbo", ma secondo l'uso si
intromise un intermezzo comico dello stesso autore, che era intitolato "La
serva padrona". Questo piccolo intermezzo fu accolto con trionfo ed ebbe una
grande importanza nell'evoluzione del teatro musicale; 1'intermezzo si elev a
opera buffa. Nella seconda met del Settecento 1'opera buffa raggiunge
l'apogeo della sua evoluzione. Giovanni Paisiello la rende pi fine, pi
semplice e pura, le sue melodie sono pi vivaci e brillanti. Fra molte opere
buffe, scritte da lui, il primo posto tiene il "Matrimonio Segreto" che finora
non ha perduto il suo valore musicale, la sua freschezza.
14
Copyright & A K-C
Nicola Piccinni coadiuv lo sviluppo dell'opera buffa con le sue opere
"La Cecchina". "La molinara", "II mondo di luna", ecc. Il Settecento termina
con il trionfo dell'opera buffa su quella seria, era il periodo classico dell'opera
buffa italiana.
L'opera buffa continu per buona parte nel secolo XIX a dilettare i
pubblici dei teatri italiani, finch da un lato il mutamento dei tempi e del
gusto, d'altro lato l'invasione dell'operetta francese la fece sparire quasi del
tutto. Si deve fare eccezione per il sempre vivo "Barbiere di Siviglia" di G.
Rossini, il "Don Pasquale" di Donizetti e qualch'altra ancora.
_______________________________________________________________
1
Santa Croce .
LOPERA ITALAIANA NELLOTTOCENTO A NEL NOVECENTO
La riforma di Rossini nel teatro lirico
Gioacchino Rossini partecip con 1'opera italiana ai progressi dell'arte
musicale; il cantante, conservando sempre una importantissima parte, fu
costretto a sottomettersi alle leggi d'una verit drammatica pi seria.
L'espressione del sentimento per mezzo della meloda fu completata dalla
variazione degli accompagnamenti dellorchestra che pi attivamente
intervenne alla descrizione delle passioni e limit la libert e la fantasa del
cantante. A differenza dei suoi predecessori, Rossini diede molta importanza
all'orchestra, che, secondo lui, non doveva limitarsi al puro accompagnamento,
ma svolgere una propria funzione indipendente, cre per essa i suoi famosi
"crescendo". Combatt sempre contro il dominio dei cantanti, obbligandoli a
cantare solo le cadenze e le fioriture da lui prescritte. Il cantante si senti
obbligato a rispettare meglio il pensiero del compositore, seguirlo nelle sue
melode, ma nello stesso tempo la meloda non cessava di fluire limpida e
luminosa, ella lasciava al cantante il tempo di respirare, di dare sfogo alla sua
immaginazione. Questa rivoluzione musicale ed altri ragioni fecero sparire i
sopranisti dall'opera italiana.
Rossini li aveva rimpiazzati per le sue opere con i contralti femminili. E
come nel secolo XVIII fioriva una schiera di mirabili virtuose che
15
Copyright & A K-C
propagavano le creazioni dei maestri italiani, cosi nel secolo XIX si formo un
gruppo di cantanti celebri che eseguivano le opere della nuova scuola
musicale.
La rivoluzione di Rossini sta nella sua stessa musica. Con questo mezzo
egli liber il palcoscenico dalle parrucche incipriatee vi port la vita stessa.
Prendete qualsiasi dei suoi personaggi pi famosi, come Figaro, Don Basilio,
Guglielmo Tell, ecc; sono personaggi vivi, reali e realisticamente ritratti... La
rivoluzione musicale, iniziata da Rossini, seguiva il suo corso per opera di
Bellini, di Donizetti e soprattutto di Verdi.
L'opera romantica italiana
Il movimento del romanticismo sviluppato sotto l'influsso della lotta
liberatrice delle masse popolari, legata alla Grande Rivoluzione Francese,
contro il feudalesimo e contro il giogo nazionale.
Nella musica del romanticismo prevaleva la tendenza progressista.
Nelle opere dei compositori romantici (di questa tendenza) si esprimevano le
idee patriottiche e democratiche, la protesta contro il giogo nazionale e
sociale. La fioritura dell'opera romantica eroica e dell'opera popolare suscit
l'interesse alla vita del popolo, alla cultura nazionale, al passato storico, alle
leggende e ai canti popolari.
Accanto ai temi della patetica eroica e passione rivoluzionaria
risuonavano i temi della solitudine e della nostalga di cose e persone lontane
nel tempo e nello spazio. Il legame con le aspirazioni progressiste sociali,
l'interesse alla vita della gente semplice, all'arte popolare definirono il
realismo dell'arte dei migliori esponenti della music
romantica.
Le ricerche dell'espressione pittoresca, la soluzione dei compiti nuovi
nell'espressione psicologica determinarono grandi successi innovatori del
romanticismo nel campo del'armona, della strumentazione, della forma
musicale, ecc. Ancora nel Settecento apparirono le tendenze che
preannunciavano il romanticismo. Come tendenza musicale il romanticismo si
form nell'inizio dell'Ottocento, nel primo decennio e si svillupp nella prima
met di questo secolo. Nella prima met dell'Ottocento il romanticismo
dominava in Italia. Riflettendo l'entusiasmo eroico, il romanticismo italiano si
16
Copyright & A K-C
realizz nell 'opera, genere musicale di una grandissima forza emotiva. I
compositori pi celebri di questo periodo erano Gioacchino Rossini, Gaetano
Donizetti e Vincenzo Bellini.
Gioacchino Rossini con il suo ingegno inventivo e la variet di forma
diede un'ondata vivificatrice all'opera italiana, dandole un nuovo impulso e
destando stupore nel mondo per la sua audacia. La sua orchestra possiede una
vivacit inesauribile, un bel colorito strumentale e fa uso di conosciutissimi
effetti di crescendo. II teatro musicale si ispira spesso a testi di origine
romantica, ma spesso li risolve attraverso una musica di classica compostezza.
Un caso tipico quello di "Gulglielmo Tell" di G. Rossini, dove tutto
romantico tranne la chiara compostezza della musica.
Tratti romantici sono notevoli nei "Puritani" di V. Bellini, e soprattutto
nella "Lucia di Lammermoor" di G. Donizetti, un'opera tipica del
romanticismo italiano. Le opere di V. Bellini sono piene di pure, soavi e
bellissime melode con una grande potenza emotiva; la sua opera "Norma" e la
pi forte opera tragica della prima met dell'Ottocento. Le opere serie di G.
Donizetti offrono pagirle mirabili per la forza melodica ed espressivit
drammatica.
L'opera italiana del Risorgimento, soprattuto le opere di Rossini, Bellini,
Donizetti, e le opere del giovane Verdi, portarono un grandissimo contributo
alla cultura mondiale.
I COMPOSITORI ITALIANI DALLSETTECENTO AL NOVECENTO
Alessandro Scarlatti
(16601725)
Alessandro Scarlatti e il pi grande compositore italiano del Settecento e
rappresentante della scuola musicale napoletana, cominci i suoi studi
musicali a Roma sotto Giacomo Carissimi, celebre maestro di musica. Inizio
l'attivit di compositore nel 1679 e fra cinque anni si stabil a Napoli come
maestro di cappella reale.
Alessandro Scarlatti domin il melodramma e la cantata da camera. Egli
una grande figura del melodramma italiano. A. Scarlatti compose 65
17
Copyright & A K-C
melodrammi, creando quel tipo d'opera che sar poi definito "napoletano". Tra
le sue opere le pi importanti sono: "Rosaura", "Tigrane", "Telemaco", "Il
trionfo dell'onore" (commedia semicomica), "Marco Attilio Regolo", "La
clemenza di Tito", ma soprattutto "Griselda" (1721), ultima sua opera teatrale.
L'aria col da capo, il recitativo secco, la sinfona d'apertura in tre parti
(allegro adagio allegro conclusivo in ritmo di danza) sono caratteristici per
le sue opere. Oltre a ci A. Scarlatti compose circa 600 cantate da camera,
circa 20 oratori, messe, motteti, ecc. lasciando una profonda traccia anche
nella musica strumentale.
Nella cantata Scarlatti fu autore insuperabile; sotto il suo influsso
Hndel scrisse cantate italiane (nello stile di A. Scarlatti) e Bach compose
spesso l'aria scarlattiana.
La numerosa famiglia degli Scarlatti, una delle pi famose nella storia
della musica, diede al mondo accanto ad Alessandro e Domenico vari altri
musicisti famosi.
Giovanni Paisiello
(17401816)
Paisiello pu essere considerato il vero iniziatore dell'opera buffa
itliana. Studi al Conservatorio a Capuana, giovanissimo, compose messe,
mottetti, ecc. Appena uscito dal Conservatorio, in due anni Paisiello compose
undici opere, tra serie e buffe tutte trionfalmente accolte sulle scene di
Bologna, Parma, Venezia e Napoli.
Nel 1776 fu invitato alla corte di Russia. E questo il suo periodo pi
felice e il pi notevole per la sua attivit artistica. In Russia Paisiello compose
"II Barbiere di Siviglia" (1782), "La serva padrona" su libretto gi musicato
dal Pergolese, con qualche aggiunta. "Il barbiere di Siviglia, ovvero La
precauzione inutile," opera giocosa in due atti fu rappresentata con successo
per la prima volta a Pietroburgo nel Teatro Imperiale nel 1782.
La malatta della moglie forz tornare Paisiello in Italia. A Napoli
Paisiello scrisse due opere pi rinomate "La bella molinara" (1788) e la
commedia musicale "Nina o la pazza per amore" (1789). Quest'ultima opera
ebbe un successo enorme, pi tardi chiamata "La Sonnambula" del XVIII
secolo, e si disse che la Nina era pazza per amore e il pubblico pazzo per la
"Nina".
18
Copyright & A K-C
Nel 1802 Paisiello fu invitato a Parigi. Qui scrisse l'opera "Proserpina"
che ebbe successo mediocre. Tornato a Napoli, Paisiello fu abbandonato da
tutti e mor in indigenza nel 1816.
Domenico Cimarosa
(17491801)
Domenico Cimarosa di Aversa (nato nel 1749), ingegno originale e
versatile, fu anche disegnatore e poeta, patriota ardente, partecip alla
rivoluzione napoletana nel 1799. Fu arrestato e condannato alla morte, ma fu
salvato, grazie all'aiuto dei marinai russi che si trovarono in quel tempo nel
porto di Napoli. Dovette emigrare. Esord coll'opera "Le stravaganze del
conte". Nel 1775 la fama di Cimarosa si era gi sparsa dappertutto. Con lui la
struttura dell' opera buffa si perfezion, e le sue forme divennero pi snelle,
egli vi introdusse i cosiddetti "parlanti", la arricch di terzetti e quartetti. Nel
1787 Cimarosa fu chiamato alla Corte di Russia.Nel suo viaggio di ritorno
dalla Russia Cimarosa scrisse "Il matrimonio segreto", il quale alla prima
esecuzione in Vienna nel 1792 si dov ripetere una seconda volta da capo al
fine.L'opera fu ridata subito dopo a Napoli per centodieci serenello spazio di
cinque mesi. A proposito del "Matrimonio segreto" Giuseppe Verdi cos si
esprimeva: "Essa vera commedia musicale e li c' tutto quello che un'opera
buffa deve avere". Nel "Matrimonio segreto", un capolavoro di Cimarosa, vi
tale freschezza di ispirazione, tale squisita eleganza di forme che pu
considerarsi un vero gioiello. Il "Matrimonio segreto" ebbe subito trionfali
successi a Vienna, a Parigi, Napoli. Quest'opera continua a meravigliare anche
i pubblici moderni per la sua immutata freschezza.
E una delle pi riuscite opere buffe del repertorio italiano, sia per il
libretto brioso, sia per la musica, piena di grazia settecentesca. I personaggi e
le situazioni hanno un loro palpito di vita, un loro carattere semplice, che
interessa e diverte lo spettatore. Tra le arie pi note ricorderemo quella di
Paolino e quella di Carolina (soprano), piena di contrasti e di vivace arguzia.
Fra le opere posteriori al suo capolavoro sono da ricordare le "Astuzie
femminili". Domenico Cimarosa scrisse moltissime altre opere buffe e serie,
eccellendo in quelle buffe.
19
Copyright & A K-C
Di questo melodista rimasero circa cento opere buffe e serie, oltre molti
oratori, cantate, composizioni di musica sacra, sinfonica e da camera. Il suo
stile facile, semplice, vivace. Domenico Cimarosa fu tra i primi ad adoperare
nell'opera buffa i terzetti e i quartetti e a migliorarne l'armonizzazione e la
strumentazione; scrisse anche musica strumentale.
Nel 1801 trovandosi a Venezia per l'esecuzione della sua ultima opera
"Artemisia", mor improvvisamente a cinquanta due anni.
Nicola Piccinni
(17281800)
Nicola Piccinni era nato a Bari nel 1728. Egli studi al Conservatorio di
Napoli, e nel 1754 fece rappresentare il suo primo lavoro "Le donne
dispettose" nel teatro dei Fiorentini che ebbe un gran successo. Seguirono
subito altre opere: "Le gelose", "Zenobia". Egli cooper allo sviluppo
dell'opera buffa, ne miglior le forme, vi introdusse il rondo, ne rese pi varia
la strumentazione. Ma il successo pi notevole nel genere buffo fu quello della
"Cecchina" (1760). Nell'opera seria il capolavoro di Piccini fu l'"Olimpiade",
la quale segn un passo notevole. La famosa aria di Megacle "Se cerca se
dice" e il duetto "Nei giorni tuoi felici" ebbero quasi un secolo di popolarit.
Passato da Napoli a Parigi, chiamato dalla Corte di Francia, prese parte
nella famosa lotta artistica con Glck. Si costituirono due partiti accaniti l'uno
contro l'altro: i glckisti ed i piccinnisti. E il conflitto occup la societ
parigina per parecchi anni. Artisticamente la contesa aveva questa base: nel
melodramma fin dove si deve concedere la prevalenza alla poesia? Fin dove
alla musica? Il Piccinni, alla meloda pura, confideva massimamente in essa
per rendere con intensa rapidit passioni e situazioni, il Glick sentiva il
bisogno di forme pi analitiche, spezzando spesso la fluente andatura
melodica per rispetto alla espressione drammatica. II sistema di Glck trionf
allora e continu poi sempre a dominare nel melodramma. L'opera pi famosa,
composta dal Piccinni, durante la sua permanenza a Parigi fu "Didone" (1773).
Tornato a Napoli nel 1791, ebbe dapprima onori alla corte del re Ferdinando,
ma poi cadde in disgrazia della Corte perch sospettato di giacobinismo e fini
miseramente la vita a 74 anni.
20
Copyright & A K-C
Luigi Cherubini
(17601842)
Luigi Cherubini nacque a Firenze nel 1760. II padre, suonatore di
cembalo, fu il suo primo maestro. A tredici anni Cherubini scriveva una
"Messa solenne" a quattri voci e orchestra. Nel 1778 egli si trasfer a Bologna.
Dal 1780 al 1788 compose fra le altre opere "Quinto Fabio", "Armida", "La
finta principessa", "Ifigenia in Aulide" che fu l ultima sua opera, eseguita in
Italia. Nel 1788 si stabil definitivamente a Parigi, dove present le opere:
la"Lodoiska" che ebbe gran successo, "Medee" ("Medea") che Brahms defini
"la vetta suprema della musica drammatica", "Pigmalione", ecc. "Le due
giornate" sono state rappresentate nel 1800 a Parigi. Con i suoi capolavori
(specialmente "Medee") Cherubini si colloca tra Glck e Beethoven,
ricollegandosi al primo per la severit dello stile e per la rinuncia alla
melodiosa aria italiana a favore di un declamato-arioso, al secondo per
l'accentuato sinfonismo. Come direttore d'orchestra cooper alla diffusione
della musica italiana all'estero. Ma la sua celebrit la deve come teorico e
sinfonista, scrisse pure molta musica sacra: messe, requiem, cantate, ecc. Luigi
Cherubini fu invitato a Vienna, dove furono eseguite le sue due opere la
"Fanisca" e la "Lodoisca" che riportarono anche l'approvazione di Beethoven.
Cherubini divenne popolare come autore di molti canti rivoluzionari all'epoca
del la Grande Rivoluzione francese.
Cherubini fu nominato professore di composizione al Conservatorio di
Parigi.Nel 1821 gli venne affidata la direzione del nuovo conservatorio che
mantenne fino al febbraio 1842, poche settimane prima della sua morte. A 75
anni scrisse le mille pagine di musica dell' "Ali-Baba" che suscitarono
entusiasmo. Le opere di Cherubini si distinguono per una pi ricca
strumentazione. Cherubini trasform l'opera mitologica nell'opera classica
eroica, scrisse inni rivoluzionari per il coro con orchestra e fu uno dei pi
grandi compositori nell'epoca della Grande Rivoluzione francese. Mor nel
1842, e nel 1869 gli fu eretto un monumento a Santa Croce di Firenze.
Santa Croce .
21
Copyright & A K-C
Gioacchino Rossini
(17921868)
Nacque a Pesaro da famiglia povera. Suo padre era suonatore du corno e
di tromba in orchestra; sua madre era cantante. Gioacchino rimase sette anni a
Pesaro, poi pass a Bologna in compagna di sua madre Anna Rossini che
aveva una bella voce, cantava al teatro e volle che anche Gioacchino studiasse
musica. Nel 1792, Gioacchino Rossini entr al Conservatorio di Bologna
all'et di quattordic anni. Nel 1810 debutt a Venezia con "La cambiale di
matrimonio", farsa in un atto accolta con successo, cui segu il trionfo alla
Scala di Milano nel 1812 con "La pietra del paragone", opera giocosa in due
atti su: forma, questa, in cui espresse pienamente il proprio talento, nonostante
l'esordio, ancora da studente nel 1806, fosse stato "Demetrio e Polibio", opera
di genere serio, messa in scena a Roma solo nel 1812. E proprio con un'opera
seria, il "Tancredi", rappresentata nel 1813, Rossini appena ventenne e gi
famoso in Italia conquist le platee di Vienna. Nello stesso anno compose
anche una delle sue pi grandi opere comiche, "L'italiana in Algeri", messa in
scena a Venezia.
Con "Elisabetta, regina d'Inghilterra", presentata a Napoli nel 1815,
inizia il periodo napoletano del compositore, alla guida dei teatri reali della
citt fino al 1817. Nel 1816, in meno di tre settimane, Rossini scrisse "Il
barbiere di Siviglia" per il teatro Argentina di Roma,, ispirato a quello gi
musicato da Paisiello, tratto dall'omonima commedia del 1775 di Pierre
Augustin Beaumarchais. I tempi stretti portarono inevitabilmente ad un fiasco
della prima, ma le rappresentazioni successive confermarono il valore della
composizione, che otterr il plauso di Verdi: " Non posso che credere'Il
Barbiere di Siviglia, per abbondanza di idee, per verve comica e per verit di
declamazione, la pi bella opera buffa che esista".
Nel 1817 il compositore torna all'opera comica con "La Cenerentola",
presentata a Roma, e, nello stesso anno, compone la semiseria "La gazza
ladra", messa in scena a Milano. Intanto a Napoli Rossini aveva presentato
l'"Otello", tratto dal modello shakespeariano. Pi gradita al pubblico
conservatore napoletano, l'opera seria fu il genere che in quegli anni Rossini
rinnov con il "Mos in Egitto" (1818), "La donna del lago", ancora su libretto
di Tottola, "Maometto II" (1820). Nel 1822, invece, alla conclusione della sua
22
Copyright & A K-C
attivit in Italia, il compositore torn alla tradizione settecentesca con
"Semiramide", rappresentata a Venezia nel 1823. Trasferitos a Parigi nel
1824, Rossini inizi con il rielaborare in francese il "Maometto II" e il
"Mois" e, dopo qualche anno di silenzio, compose, direttamente in lingua, il
"Comte Ory" messe in scena all'Opra nel 1828.
All'apice del successo, il musicista dette il proprio addio al teatro con
un'ultima opera, il "Guglielmo Tell", ispirato alla tragedia "Wilhelm Tell",
rappresentata all'Acadmie Royale de Musique di Parigi nel 1829, capolavoro
di perfezione, destinato ad influenzare il teatro francese e quello italiano, di
cui Donizetti scrisse "Rossini ha composto il primo ed il terzo atto, Dio il
secondo....".Il silenzio compositivo di Rossini fu interrotto da lavori sporadici,
tra cui lo "Stabat Mater" del 1841, la "Petite messe solennelle" del 1863 e un
gruppo di pezzi da camera, per pianoforte, e per voce e pianoforte, raccolti
sotto il nome di "Pchs de vieillesse" (Peccati di vecchiaia). Gioacchino
Rossini mor a Parigi nel 1868.
Vincenzo Bellini
(18011835)
Vincenzo Bellini, il cigno catanese, nacque a Catania nel 1801 in una
famiglia di musicisti. Vincenzo a cinque anni suonava il cembalo e a sette anni
componeva. Diciotenne amesso al Conservatorio di Napoli, dove ebbe per
maestro lo Zingarelli, creatore di opera teatrali. Studiando al Conservatorio,
Bellini music un vecchio libretto Adelson e Salvini ; lopera venne
eseguita con sucesso nel carnevale del 1825 al teatro del Conservatorio. Nel
1826 esord al Teatro San-Carlo di Napoli con lopera Bianca e Fernando ,
avendo fra gli interpreti cantanti illustri come Rubini e Lablanche. Lopera fu
applaudita e fece buona impressione al Donizetti.
La sua prima opera matura Il pirata ebbe strepitoso sucesso al Teatro
alla Scala, e il clbre tenore Rubini esegu la parte principale. Ora la fortuna e
il genio di Bellini seguono insieme. Le sue opera La straniera , I Capuleti
e I Montecchi , la deliziosa Sonnambula sono accolte trionfalmente.
La Norma invece, il perfetto capolavoro, fu un vero fiasco; quella
sera, il 26 dicembre 1831 il pubblico della Scala ascolt mal volotieri la
23
Copyright & A K-C
solenne e tenera musica dellopera. Ben presto per lopera conquist e
affascin il pubblico dItalia, di Londra e di Parigi. Vi sono episode
imeravigliosi nello spartito: il coro dei Druidi nella foresta di Irminsul, la
commovente scena dei fanciulli nel second atto. Il finale della Norma
cos drammatico, cos patetico che ispir Wagner a comporre il finale del suo
Tristano. Ma tutto e vinto dalla bellissima romanza: Casta diva che
inargenti queste sacre antiche piante .
Il compositore continuava il suo cammino di gloria; dal febbraio
allagosto 1833 fu a Londra,poi a Patigi. La sua opera I puritani ebbe pure
un grande sucesso nel 1835. Ma nello stesso anno, al culmine della sua fama il
compositori mor in una villa presso a Parigi (a Puteaux). La triste notizia
addolor musicisti e amatori di musica; quell giorno tutti i teatri a Parigi
furono chiusi. Quaranta anni dopo, le ceneri di Bellini furono riportate a
Catania. Nel 1924 la casa a Catania, dove nacque Bellini, venne dichiarata
monumento nazionale.
Legato alla tradizione italiana del bel canto, Bellini seppe farne una
trasfigurazione romantica. Lirico per il carattere del suo talento e romantico
per la sua concezione del mondo,Bellini, esprimeva nella sua musica le
speranza del popolo italiano che soffriva sotto il giogo austriaco e lottava per
la liberazione della sua patria. Nelle opera di Bellini, nellinno dei Puritani ,
come nel coro Guerra, guerra! della Norma ritroviamo linflusso delle
idee di libert. La cabaletta Suoni la tromba da I puritani fu definite la
marsigliese italiana.
Le opere di Bellini portarono ad una fioritura interpreti famosi, come la
Malibran, la Pasta, le due Grisi e il grande Rubini, il cantante belliani per
eccelenza. Le difficolt del canto belliano esigono degli interpreti di
eccezione: quali Maria Callas, Montcerrat Caballe.
I druidi (
, ).
2
Irminsul ( ).
3
M. Callas, M. Caballe ().
24
Copyright & A K-C
Giuseppe Verdi
(18131901)
Nato a Le Roncole di Busseto, in provincia di Parma, il 10 ottobre 1813
da una famiglia umile, Giuseppe Verdi apprese le prime nozioni sulla musica
dall'organista della chiesa locale. Trasferitosi a Milano, non fu ammesso al
Conservatorio perch aveva superato i limiti di et e si form alla scuola di
Vincenzo Lavigna, maestro del Teatro alla Scala.
A contatto con l'ambiente culturale milanese, Verdi scelse la strada del
teatro in musica e present la sua prima opera "Oberto, conte di San
Bonifacio" al pubblico scaligero nel 1839, con un discreto successo. Nel 1840
segu l'opera buffa "Un giorno di regno" che si rivel un fiasco, ma, su
insistenza dell'impresario Bartolomeo Merelli chi aveva gi firmato due
contratti con il compositore, Verdi scrisse il "Nabucco", con cui trionf alla
Scala nel 1842. Il talento verdiano fu confermato dalla successiva opera "I
lombardi alla prima crociata", rappresentata nel 1843 ed animata dalla stessa
tensione alla potenza dello spettacolo, grandioso e a toni forti. Una novit
giunse con "Ernani", l'opera presentata a La Fenice di Venezia l'anno
successivo, in cui il compositore introdusse motivi dedicati
all'approfondimento psicologico dei personaggi, dal carattere appassionato,
che ben si adattava al clima dello slancio patriottico destinato a culminare nei
moti del 1848. L' attivit prolifica di Verdi, che poi defin quel primo periodo
di creazione, che lo impose sulle scene delle principali citt italiane e ne
costru la fama internazionale, come "anni di galera", produsse "I due
Foscari", rappresentati a Roma nel 1844; "Alzira", inaugurata al San Carlo di
Napoli nel 1845; "Giovanna d'Arco", presentata alla Scala lo stesso anno;
"Attila", proposta a Venezia nel 1846; "Macbeth", la prima opera del
compositore su modello shakespeariano, rappresentata al teatro La Pergola di
Firenze nel 1847.
Il prestigio del musicista fu consolidato dalla situazione politica che ne
fece il portavoce del fervore patriottico: la vetta pi alta di quello spirito si
concretizza ne "La battaglia di Legnano", eseguita a Roma nel 1849 in pieno
clima repubblicano. Segu "Luisa Miller", rappresentata a Napoli l'anno
successivo e "Stiffelio", presentata nel 1850. La capacit di Verdi di
padroneggiare le possibilit del melodramma, di raccontare con la musica gli
25
Copyright & A K-C
snodi della vicenda e le sfumature dei personaggi, si svilupp nella "trilogia
popolare" dei capolavori: "Rigoletto", rappresentato a Venezia nel 1851, tra le
massime opere verdiane per equilibrio della composizione; "Il trovatore", in
scena a Roma nel 1853, in cui il gesto musicale esalta l'azione drammatica;
"La traviata", presentata lo stesso anno a Venezia,, incentrata sull'individualit
e scandita dall'intensit del ritmo.
_______________________________________________________________
1
2
La Fenice diVenezia .
San Carlo (. ).
GIACOMO PUCCINI
(18581924)
Nato a Lucca nel 1858 da una famiglia di musicisti, Giacomo Puccini
frequent il conservatorio di Milano dal 1880 al 1883 sotto la guida
d'Amilcare Ponchielli. Nella citt lombarda ottenne la fama di "sinfonista"
prima per sue proprie composizioni, secondo la moda diffusa tra i giovani
dell'epoca, ed ebbe modo, grazie all'attivit del Teatro alla Scala
d'intraprendere la carriera di operista. Le prime due opere, "Le Willis" (1884)
e "Edgar" (1889), su libretto di Franco Fontana, non ebbero particolare
fortuna. "Le Willis", rivista dopo una prima rappresentazione al teatro Dal
Verme di Milano, e messa in scena alla Scala nel 1885 in due atti con il titolo
"Le Villi"; "Edgar", invece, venne ritirata.
Il capolavoro arriv alla terza opera, "Manon Lescaut" (1893), in cui i
caratteri essenziali della composizione di Puccini, che fondeva intensit lirica
ed emotiva con una ricca orchestrazione, erano gi chiari. In questi anni, il
compositore spost la propria residenza ed inizi a collaborare con Luigi Illica
e Giuseppe Giacosa, i librettisti che interpretarono con maggior finezza la sua
sensibilit. Nel 1896 "La Bohme", opera di taglio verista, con personaggi
tratti dalla realt quotidiana, lontani dall'eroismo, fu presentata al Teatro Regio
di Torino con la direzione d'Arturo Toscanini ed apr a Puccini la strada per la
notoriet in Europa. Nel 1900, con "Tosca", il compositore speriment il
dramma verista a tinte fosche, con scene violente e ritmo sostenuto, mentre nel
1904 con "Madama Butterfly" ancora su libretto di Giuseppe Giacosa
torn al personaggio della fanciulla innamorata ed infelice, destinata ad una
26
Copyright & A K-C
triste sorte per la propria ingenuit, nell'ambientazione esotica del Giappone.
La prima scaligera fu fischiata, ma la successiva rappresentazione a Brescia
segn il trionfo del compositore. Con "La fanciulla del West", rappresentata a
New York nel 1910, la cui ambientazione americana determin la scelta di
ritmi sperimentali, Puccini raggiunse l'apogeo della propria fama
internazionale. Seguirono l'operetta "La rondine" e gli atti unici "Il tabarro",
"Suor Angelica", "Gianni Schicchi", chi ha il titolo di "Trittico" nel 1918.
Negli ultimi anni di vita, il compositore si dedic alla "Turandot", rimasta
incompiuta per la morte sopraggiunta nel 1924 a causa di un tumore alla gola,
in seguito, terminata da Franco Alfano sulla base degli appunti di Puccini. La
prima rappresentazione dell'opera d'ambientazione cinese tratta su favola che
segnava il rinnovamento del linguaggio pucciniano, ebbe luogo a Milano nel
1926.
______________________________________________________________
1
A. Ponchielli XIX ,
.
2
L. Illica e G. Giacosa , . .
Ruggero Leoncavallo
Ruggero Leoncavallo compositore italiano, nato a Napoli nel 1857,
figlio di un magistrato, inizia privatamente a studiare il pianoforte, per poi
entrare nel 1866 al Conservatorio di San Pietro di Napoli, dove si diploma nel
1874. Contemporaneamente si iscrive alla facolt di lettere dell'universit di
Bologna; si laurea all'et di 20 anni, dopo aver anche finito la partitura
dell'opera storica "Chatterton", che verr rappresentata solo nel 1896 e
raggiuse la fama. Si mantiene insegnando privatamente il pianoforte e
suonando nei caff concerto in Francia e in Inghilterra, quando suo zio,
direttore della Stampa al Ministero degli Esteri, lo invita in Egitto dove dal
1882 attivo per qualche anno presso la corte. Ma la guerra anglo-egiziana
costringe Leoncavallo a lasciare l'Egitto e a trasferirsi in Francia: qui, grazie al
baritono Maurel, entra in contatto con l'editore Ricordi, da cui ottiene la
commissione per una trilogia, il "Crepusculum", che nelle intenzioni del
compositore deve comprendere "I Medici", "Savonarola" e "Cesare Borgia".
Leoncavallo riuscir solo a comporre "I Medici", che andr in scena senza
troppo successo nel 1893.
27
Copyright & A K-C
Nel frattempo, stimolato dal successo di "Cavalleria rusticana" di
Mascagni, Leoncavallo si dedica febbrilmente alla stesura di una nuova
opera. In 5 mesi di lavoro a Vacallo, in Svizzera, mette a punto musica e testo
dei "Pagliacci".Il libretto tratto da un processo tenuto dal padre durante
l'infanzia del musicista: i "Pagliacci" si presenta cos non come una vicenda
verosimile, ma vera.Inoltre si presta a far rivivere il vecchio trucco del teatro
nel teatro: Leoncavallo, non ancora soddisfatto, fa precedere l'opera da un
prologo dove si enuncia un vero e proprio manifesto del verismo musicale;
l'opera, presentata nel 1892 al Teatro Dal Verme di Milano, un clamoroso
successo.
Da quel momento in poi il nome del compositore si diffonde anche
all'estero e questo nonostante il fatto che il musicista non riesca a replicare
quella fortunata combinazione. Prova anche a scrivere una sua "Bohme",
diversa da quella di Puccininella sua conduzione verista e nell'attenzione
maggiore posta sui personaggi di Marcello e Musetta: il risultato ottimo, ma
la fortuna della "Bohme" di Puccini mette in ombra quella di Leoncavallo. Il
compositore ritrova il consenso con "Zaz" del 1900, un'opera che racconta
dall'interno l'ambiente teatrale e che verr portata su tutti i palcoscenici del
mondo dalla sua affezionata sostenitrice Emma Carelli. l'ultima opera in cui
il compositore provvede in prima persona alla stesura del libretto: subito dopo
il musicista decide di conquistare palcoscenici europei e, sempre nel 1900,
manda in scena a Parigi "Maja".
Ma la Germania il paese in cui pubblico e critica sembrano meglio
disposti verso il musicista: nel 1904 va in scena "Der Roland von Berlin", che
gli conquista i favori di Guglielmo II e alcune altissime onorificenze. Dopo un
periodo dedicato allo studio dell'operetta, Leoncavallo torna all'opera nel 1916
con "Goffredo Mameli", un lavoro di intento patriottico scritto per avvalorare
la sua conversione all'interventismo, accompagnata dal gesto dannunziano
della restituzione delle onorificenze ricevute da Guglielmo II. Negli ultimi
anni di vita si dedica ad altre opere minori o, addirittura come nel caso di
"Prometeo", mai rappresentate: la morte lo coglie a Montecatini mentre al
lavoro su un libretto desunto dalla cronaca nera sarda, "Tormenta" nel 1919._
_______________________________________________________________
1
Pietro Mascagni XIX .
Emma Carrelli (),
XIX .
2
28
Copyright & A K-C
LARTE LIRICO IN ITALIA
VOCE E CANTO
L'estensione della voce umana e suddivisa in sei categorie: basso,
baritono, tenore per le voci di uomo; contralto, mezzosoprano, soprano per le
voci di donna. Ciascuna categoria comprende circa due ottave.
Ogni uomo ha un timbro individuale, per mezzo del quale possiamo
riconoscere la persona senza vederla. Nelle voci esistono due registri
principali: registro di petto e registro di testa. Si distinguono alcune specie di t
e n o r i:
Tenore drammatico (o potente) espressivo, forte e sonoro nei toni
medi del suo volume, e nei toni alti brillante (Raul in Ugonotti di
Mayerbeer).. Tenore lirico, con timbro morbido dolce (Lenskij). Primo
tenore ha lo stesso volume del tenore drammatico, ma il suo timbro pi dolce
e la sua voce pi agile (Don Jos in Carmen di Bizet, Rodolfo nella
Boheme di Puccini).
Primo tenore nell'opera buffa o tenore leggiero ha volume pi piccolo,
un timbro pi dolce, meno virile, capace di esprimere sentimenti delicati,
anzich forti passioni (Almaviva).
Tenorino canta i pi alti toni di falsetto.
Ci sono due specie di b a r i t o n i: baritono alto (drammatico e lirico);
baritono ordinario o comune. II baritono drammatico (che si chiama anche
baritono verdiano) potente, grave ed espressivo nei toni alti (Rigoletto).
II baritono lirico ha un timbro pi dolce, leggiero e soave. II baritono
comune o ordinario ha un tono pi basso e un tono pi alto del baritono
drammatico. I suoi toni alti sono brillanti e virili.
Le voci basse possono essere: basso cantante, basso nobile o basso
profondo e basso baritono. Il basso cantante ha un timbro morbido, leggiero e
brillante (Leporello nel Don Giovanni di Mozart). Il basso profondo o
basso nobile una voce grave, robusta e potente (Boris Godunov). Il basso
baritono un basso cantante con altezza di baritono. Le voci femminili possono
essere: soprano, mezzosoprano, contralto.
II soprano, oppure soprano lirico ha una voce soave, dolce, espressiva e
leggiera, pi forte del soprano leggiero Margherita in Faust di Gounod).
29
Copyright & A K-C
II soprano leggiero ha una tecnica virtuosa nell'esecuzione di passaggi rapidi,
scale, trilli,ecc (Rosina). Certe cantanti sono soprano lirico leggiero con le
qualit dei due soprani (Violetta). II soprano drammatico nel suo volume ha
uno o due toni pi bassi degli altri soprani. II soprano drammatico potente,
decisivo (Aida, Tosca). II soprano lirico-drammatico unisce le qualit dei due
soprani.
II mezzosoprano tiene il mezzo fra il soprano e il contralto. In tutto il
suo registro pieno e capace di esprimere vari sentimenti (Carmen).
II contralto la voce pi bassa di donna con volume di due ottave, e il
suo registro basso e grave (Azucena).
Cantanti famosi dellOttocento
Nell'inizio dell'Ottocento dopo la riforma di Rossini nel teatro lirico, i
sopranisti furono sostituiti dai contralti femminili che si esibivano nelle opere
di Rossini, Bellini e Donizetti. Tali sono:Melanotte, la Colbran, la Pasta, la
Malibran, ecc.
La Cafferini Elisabeta (Veneta) fu celebre nell'opera buffa. Ella brill
in Italia e nei principali centri d'Europa dal 1796 al 1815. La sua voce di
contralto limpida e pieghevolissima saliva al fa e discendeva in fino al la.
Adelaide Melanotte, dotata di una splendida voce di contralto e mezzosoprano, canto con grande successo su tutte le principali scene d'Italia. Per la
sua arte perfetta, per il canto affascinante e pieno di profonda espressione fu
una delle cantanti pi ricercate dell'epoca sua. Aveva un contralto potente,
facile e puro. La Malanotte fu interprete prediletta di molte opere di Rossini
che scrisse per lei il "Tancredi" (1813); della celebre cavatina "Di tanti palpiti"
essa fece una creazione indimenticabile.
La Grassini apparve sulle scene della Scala nel carnevale del 179394
e divenne ben presto la pi celebre cantante. Nella "Gazzetta Musicale" di
Milano nel 1892 un critico musicale scriveva che nella soave aria di Orazia
(dell'opera "Orazi e Curiazi" di Cimarosa) "Quelle pupille tenere" e nella
famosa ultima cantilena di Romeo nessun'altra virtuosa poteva mai uguagliarla
per la deliziosa emissione dei suoni, per l'accento espressivo, per l'imponente
suo fraseggiare. I famosi compositori della fine del Settecento e dell'inizio
30
Copyright & A K-C
dell'Ottocento scrivevano per lei diverse opere, fra cui "Giulietta e Romeo"
(1796) di N. Zingarelli. Contralto perfetto, la Grassini poteva cantare anche le
parti di soprano leggero. Dotata di una bellissima voce, entusiasmo il pubblico
di tutti i principali teatri con il suo possesso di scena e l'incomparabile accento
drammatico.
La Marcolini poss edeva la voce di contralto, estesa al fa diesis, e un
talento comico impareggiabile. Rossini le affid molte parti delle sue opere
("Tancredi", ecc.) e scrisse per lei "La pietra del paragone" (1812), "L'Italiana
in Algeri" e altre. Le arie di bravura che ella aveva cantato ai finali di quelle
opere restano a testimonianza della rara agilit della sua voce, del suo brio.
Giuseppina Fodor brill sulle scene dal 1815 al 1830. Debutt a
Pietrburgo, si esib a Parigi, Londra, Vienna, Stoccolma, ecc. A Parigi trionf
al Teatro italiano (1816) (gestito allora da Angelica Catalani) come Rosina del
"Barbiere di Siviglia" di G. Rossini. Una volta si esib in quel teatro nella
"Semiramide" di G. Rossini. Assistevano molti compositori: Rossini,
Cherubini, Paer. Ad un tratto, alla fine del secondo atto, la sua voce si arresta,
e l'attrice non pot articolare una sillaba. Si abbassa il sipario. Tutti i suoi
amici erano desolati. Rossini piangeva come un fanciullo. Ma ben presto la
voce riapparve e risuono pi bella e pi soave che mai. Ella condusse a
termine la sua parte, ma aveva abusato delle sue forze e da quella sera non
cant pi. Dovette rinunciare alle scene e si dedic all'insegnamento del canto.
Angelica Catalani, contralto anch'essa, fu rinomatissima in quell'epoca.
Studi il canto a Roma e fra due anni esord alla Fenice di Venezia (1796)
nella "Lodoiska" di Mayr. A diciassette anni la Catalani era gi l'idolo della
corte di Potrogallo. Cant poi a Parigi, Londra e in altre citt. A Parigi assunse
la direzione del Teatro italiano. Era famosa per la facilit, con cui eseguiva le
scale cromatiche, ponendo su ciascuna nota un trillo. Le piaceva pure
picchiettare la nota, un martellato grazioso. Aveva una voce limpida di una
estensione meravigliosa, si da arrivare al sol sopracuto . La sua respirazione
ben condotta le permetteva di dare alla frase melodica il necessario accento
con un suono sempre vivo e pastoso, era impareggiabile negli effetti di
contrasto. Fu per sempre pi a posto come cantante di concerto che sulle
scene.
Isabella Colbran (spagnola) moglie di Rossini, Sthendal diceva nel suo
libro La vita di Rossini che mai vi fu cantante celebre, altrettanto belle.Ella
31
Copyright & A K-C
era primadonna dei teatri napoletani San Carlo e Fondo, cantava anche a
Roma, Milano, Venezia e Torino. Rossini scrisse per lei le parti di Desdemona
nell'"Otello" (1816), Armida nella "Semiramide", Elisabetta nell'opera
"Elisabetta, regina d'Inghilterra". In quest'ultima parte Colbran ebbe un vero
trionfo. Stendhal scrive a proposito: "Ella apparve a Napoli nel 1815 nella
parte di Elisabetta dall'opera di Rossini dello stesso nome, e l'immaginazione
piu esaltata... non avrebbe potuto figurarsi una Elisabetta piu bella e
maestosa".
_______________________________________________________________
1
Nicola Zingarelli XVIII .
Frederic de Sthendal XIX , .
2
Lina Cavalieri
Lina Cavalieri, il cui vero nome era Natalina Cavalieri (Onano, 24
dicembre 1874 Firenze, 7 febbraio 1944), stata un soprano e attrice
cinematografica italiana.Dal 1887 alla fine del XIX secolo, si afferm
clamorosamente prima a Roma, poi nel resto d'Italia ed in Europa, come
canzonettista di caff-concerto, rivaleggiando perfino con La Bella Otero.La
Bella Otero fu affascinata dalla sua bellezza e dalla sua grazia. Nonostante le
sue origini modeste (era stata fioraia e piegatrice di giornali), aveva il
portamento ed i modi della gran dama.Gabriele d'Annunzio le dedic il
romanzo Il piacere (1899) definendola la massima testimonianza di Venere
in Terra.Giunta al culmine della popolarit, la Cavalieri si trasform in
cantante lirica, debuttando nel 1900 ne La Bohmedi Giacomo Puccini al
Teatro San Carlo di Napoli. Ebbe ancora enorme successo e da allora si dedic
alla nuova carriera.
Cant in quasi tutti i maggiori teatri d'opera del mondo. I suoi mezzi
canori come soprano lirico erano piuttosto limitati, ma al pubblico interessava
pi vederla che udirla, per la splendida bellezza, l'eleganza del portamento, le
acconciature sontuose. Nel puritanesimo della scena lirica, la Cavalieri portava
una eccitante atmosfera di raffinata sensualit.Famoso per audacia rest il
bacio appassionato che diede ad Enrico Caruso sul palcoscenico del
Metropolitan Opera di New York, al termine del gran duetto d'amore della
32
Copyright & A K-C
Fedora .Da allora la Cavalieri fu soprannominata negli Stati Uniti the
kissing primadonna (la primadonna che bacia). Nel 1914 esord anche nel
cinema con Manon Lescaut e fino al 1920 interpret altri sette film; ma sullo
schermo era deludente.Nel 1920 diede il suo addio alle scene dicendo: mi
ritiro dall'arte senza chiasso dopo una carriera forse troppo clamorosa . Negli
ultimi anni si ritir con Arnaldo Pavone nella villa Cappucina presso Rieti.
Mor sotto un bombardamento aereo.La sua vita fu rievocata da Gina
Lollobrigida nel film La donna pi bella del mondo (1955).
______________________________________________________________
1
Bella Otero (Belle poque) XX .
Gabriele Annunzio ,
XIX .
Maria Garcia Malibran
(18081836)
Ella fu d'origine andalusa, figlia d'arte, nacque a Parigi. Studio il canto
con il padre Manuel Garcia. Alla scuola di Manuel Garcia, che fiori a Parigi ai
primi dell'Ottocento, sommi cantanti e compositori appresero l'arte di dire
cantando e le norme dell'articolazione, del fraseggio, dei suoni legati, filati,
staccati, martellati; delle fioriture, dei trilli, delle cadenzee degli stili. E vi
conobbero le regole del ben respirare, vocalizzare ed eseguire musica.
Maria Malibran esord a sedici anni, per caso, come prima donna in
sostituzione di Giuditta Pasta, eseguendo la parte di Rosina nell'opera "II
barbiere di Siviglia" all'Opera di Londra. Poi (a diciassette anni) part con il
padre e la famiglia in Nord America, a New York, dove estese il suo
repertorio alle opere di G. Rossini: "Otello", "Cenerentola", "Semiramide". In
soli sei giorni sotto l'implacabile ferula paterna aveva imparato la parte di
Desdemona. In questa occasione si stacc dal padre e nel 1826 sposo il
commerciante francese Malibran per liberarsi dalla ferrea disciplina paterna.
Ma proprio a tale padre e tale disciplina la Malibran deve la sua
eccelenza artistica, il fuoco sacro della sua arte. Maria Malibran rest sempre
una fiera Garcia, andalusa: innamorata dellavventura e del rischio; fucile in
spalla, scorrazzava sul suo destiero per i campi.
33
Copyright & A K-C
G. Lauri-Volpi nel suo libro "Voci parallele" definisce la voce di
Malibran "trivalente", che si estendeva dal contralto al mezzosoprano e al
soprano. E questa trivalenza di registri non alterava la omogeneit, l'intensit,
l'agilit dei suoni. Quindi non gi tre voci, ma una sola voce su tre registri.
M. Malibran am la musica di Bellini e divenne una delle interpreti pi
originali di "Sonnambula" e "Norma". Ritorn a Parigi nel 1828 e gli
esponenti del romanticismo con a capo Victor Hugo videro in quell 'ardente
cantante ci che ancora mancava al giovane romanticismo: il canto. La
Malibran fu veramente per loro la musa melodrammatica. Il suo passaggio dal
repertorio rossiniano a quello belliniano (dopo il 1830) rese inevitabile il
confronto con Giuditta Pasta, la sua grande rivale. Nella "Sonnambula" tutto
fa pensare che avesse partita vinta. Il Herv Florimond disse: "E stata la pi
sublime interprete della "Sonnambula". La Malibran seppe immedesimarsi in
quel carattere della pastorella Amina, da tradurre perfettamente sulla scena i
teneri affetti che l'agitavano con una voce temperata dalla passione pi pura e
dalla verit.... L'entusiasmo del pubblico fu indicibile. Ferita gravemente in
un incidente di equitazione, continu a cantare pur con un presentimento della
fine; mori giovanissima nel 1836, a soli 28 anni. La Malibran fu pure valente
pianista e distinta compositrice; compose arie, romanze, canzonette.
Ferita gravemente in un incidente di equitazione, continuo a cantare pur
con un preseniamento della fine; mor giovanissima nel 1836, a soli 28 anni.
_______________________________________________________________
1
2
3
Giuditta Pasta () XIX .
Giacomo Lauri-Volpi XX .
Herv Florimond XIX .
Giuditta Pasta
(17971865)
Giuditta Pasta fu artista classica per elevatezza di stile, per potenza ed
estensione di voce, per eificacia di azione drammatica.
Nacque a Como nel 1797 e studi al Conservatorio di Milano.
L'estensione della voce di Giuditta Pasta come quella di Malibran era
straordinaria. Da un la sotto le righe esse potevano salire fino a do diesis
34
Copyright & A K-C
e magari a un re acuto, estensione che permetteva loro di cantare con eguale
facilit la musica di soprano e quella di contralto. Pasta poteva unire con
facilit la voce di petto alla voce di testa,per ravvivare il colore d'una frase
adoperava il falsetto.
Un giornale di quel tempo scriveva: "Corde basse un po'soffocate,
corde medie leggermente velate, corde acute che vanno all'anima, abilit
sorprendente, drammaticita sublime... Nel suo insieme un fenomeno
assolutamente portentoso". Bellini scriveva al suo librettista Romani:
"La nostra "Norma" fece un furore vero. Giuditta in voce e canta e
declama in modo da strappare le lagrime... fa piangere anche me! E piansi
infatti per tante emozioni che provai". Come noto, V. Bellini scrisse la
"Norma" e "La Sonnambula" per la Pasta: Donizetti scrisse per lei la sua opera
"Anna Bolena"; Pacini "Niobe". Un critico musicale descrive l'effetto che
produsse l'esecuzione di Pasta sul celebre attore francese, Talma: "Una sera
Talma si trovava in un palco di prima fila (alla rappresentazione del
"Tancredi" di Rossini a Parigi). Egli che aveva recitato "Tancredi", che
conosceva tutte le difficolt dell'arte tragica, rimase colpito fin dai primi passi,
che fece sulla scena questa donna cos fiera e leggiadra. Egli ne segu
attentamente i gesti, i piccoli movimenti del viso, le diverse tonalit della
voce. Quando la signora Pasta pronuncio le parole: "O, patria! dolce ed ingrata
patria! vi era nella sua voce, nel suo sguardo una tale potenza, un sentimento
cos serio e cos vero che era impossibile resistere alla commozione. La Pasta,
come la Malibran, aveva creato attorno a s un'atmosfera d'entusiasmo in Italia
e fuori; stata anche in Russia a Pietroburgo e a Mosca ove canto "Norma",
"Semiramide" e "Anna Bolena".
Giuditta Pasta aveva un dono che la natura concede molto raramente,
cio una profonda sensibilit che sapeva realizzare nella parte da
rappresentare. Fu sublime nelle opere di Rossini e di Donizetti e in molte altre
opere di quel tempo.
Le voci maschili nelle opere di Rossini, Bellini, Donizetti
Prima di Rossini non si solevano mai affidare parti importanti di opera
seria alle voci di basso, delle quali si teneva pochissimo conto. Per questo
35
Copyright & A K-C
motivo Rossini fu obbligato a scrivere in chiave di tenore le parti nell'
"Elisabetta".
Siccome le parti di basso nei melodrammi (di quei tempi) erano
insignificanti, man-cavano le voci di basso. Rossini sent il bisogno di scrivere
per questo genere di voci alcune parti importanti e difficili come nelle opere:
"La cenerentola", "Mos", "L'ltaliana in Algeri", "II barbiere di Siviglia", ecc.
E apparve una schiera di bassi insigni ad eseguire le opere rossiniane
come L. Lablanche D. Donzelli, R. Mirate, G.Mario, E. Tamberlick e tanti
altri.
Luigi Leblanche (17941858), uno dei bassi pi famosi, riform lo
stile interpretativo nellopera lirica. Lablanche nato a Napoli nel 1794 e
continu a cantare fino alla tarda et. Nel 1845 il Verdi lo chiamo a Londra
per creare la parte di Massimiliano nellopera I Masnadieri . Il nome di
questo cantante stato ripetuto per oltre mezzo secolo con venerazione ed
entusiasmo.
Un critico di quell tempo scriveva che la voce di Lablanche non
oltrpassa lestensione normale di basso dal sol al mi. Le note suonano
tutte ugualmente con la stessa intensit metallica, ugualmente robuste per
forza di naturale vibrazione. Il suono sprigiona dal suo petto con la stessa
facilit con cui uscirebbe da una grossa canna dorgano: una intonazione
perfetta, una messa di voce sempre certa, una accentuazione musicale piena di
buon gusto lunione perfetta della capacita di cantante a quella di attore
Illustre maestro di canto, violinista e compositore tedesco H.Panofka
che visse a Parigi e vi fondo unAcademia di canto, cosi descrive la sua
impressione del canto di Leblanche: Di Lablanche vi dir soltanto una mia
impressione: egli canta con tale facilit, sicurezza e disinvoltura, la sua voce
ha tale musicalit naturale, che a me sembra che canti, quando parla. Il canto
per lui cosi famigliare, come a noi la parola. La storia di Lablanche ormai
nota a tutti: egli divenne cantante sensa saperlo. Infatti egli non ebbe mai
bisogno di nessun maestro per disciplinare il suo poderoso volume di voce.
D. Donzelli interpretava le parti delle opere di Bellini, Donizetti e di
Verdi. La robustezza e telasticit delle corde vocali gli davano l'ampiezza
sonora di un baritono, e 1'estensione massima di un tenore. Bellini scrisse per
lui la parte di Pollione nella "Norma"; Rossini, Donizetti, e altri celebri
36
Copyright & A K-C
maestri composero per lui alcune opere. Heinrich Panofka in "Voci e cantanti"
dice che la voce di Domenico Donzelli era di una rara forza drammatica. La
sua estensione era dal si basso al la sopra le righe (chiave di sol ). E la
vera estensione del tenore di forza.
N. Moriani
Il tenore N. Moriani sorprendeva l'uditorio con la dolcezza e la fluidit
della sua voce, con il bel modo di canto. Fu impareggiabile interprete nelle
opere di Rossini ("Otello", "Semiramide", "La gazza ladra"), Bellini ("La
Sonnambula", "I Puritani"), Verdi ("I Lombardi" e "Un ballo in maschera"),
ecc. Donizetti scrisse per lui la sua opera "Maria di Rudenz" (1838). Giuseppe
Verdi disse di Napoleone Moriani: "Dei tanti artisti che ho sentito, quelli, di
cui serbo il culto pi devoto e la memoria pi cara, sono la Frezzolini e il
Moriani".
R a f f a e l e M i r a t e era un altro celebre tenore del tempo. La sua
voce era soave, sicura, flessibile, potente e gli permetteva di cantare
ugualmente e senza il minimo sforzo tanto nella "Cenerentola" di Rossini
quanto nel "Rigoletto" di Verdi. Dotato di una bellissima voce di tenore,
esord a Napoli nel 1837 coll'opera "Torquato Tasso" di G. Donizetti,
ottenendo splendido successo. Al teatro italiano a Parigi ebbe un completo
trionfo nelle opere di Rossini ("Otello", "La gazza ladra"), Donizetti ("Lucia di
Lammermoor", cantata per 182 rappresentazioni) e altre. G. Verdi scrisse per
lui la parte del duca nel "Rigoletto" (cantato per 193 volte)
Giovanni Mario (18101883), tenore, essord nel 1840 sulle scene del
Teatro Italiano a Parigi nel'"Elisir d'amore" insieme con la Persiani ,
Tamburini e Lablache. Da quella sera in poi l'arte di Mario penetr nella
coscienza del mondo musicale parigino e il suo nome cominci ad esser
ripetuto con rispetto e ammirazione. Ogni nuova interpretazione segn per lui
un nuovo successo e gli procur proposte e contratti per tutti i principali teatri
d'Europa e d'America. Il suo modo di dire e di cantare si distaccava talmente
da quello degli altri artisti, che l'impressione, che si provava udendolo la prima
volta, era sfavorevole. Egli aveva suoni chiari e aperti, uno fraseggiare
scandito, una sillabazione martellata che pareva smanierata, ma man mano che
la sua voce penetrava nell'animo, si provava una dolcezza infinita. La sua arte
consisteva specialmente nel dare alla parola cantata la sua perfetta espressione,
37
Copyright & A K-C
senza alterare la limpidezza del disegno melodico. La nobilt del gesto e
dell'atteggiamento bastavano per attirare sopra di lui l'attenzione ammirativa
del pubblico.
Enrico Tamberlick (18201889) un altro tenore celebre. Egli era
famoso per la declamazione cantata dei recitativi. Nelle opere di Rossini, in
cui il recitativo ha una somma importanza, il Tamberlick non aveva rivali.
Un'altra particolarit che dette a lui una celebrit quasi universale, fu il famoso
do diesis di petto, nota strana e formidabile che il pubblico aspettava da lui
con frenetica impazienza (egli fu il primo ad eseguire il do diesis acuto di
petto).
Ma Rossini, udendo una sera il Tamberlick nel'"Otello", dove
quest'ultimo sostitu al la naturale, scritto nella partitura, il famoso do
diesis nel duetto fra Otello e Jago "Morro ma vendicato", fugg dal teatro
esclamando: "Questo un urlo che io non ho scritto e che fuori dell'umano!"
Nel 1862, a Pietroburgo, prese parte alla prima esecuzione dell'opera
verdiana "La forza del destino". Il Tamberlick fu 1'ultimo dei tenori del teatro
italiano a Parigi.
1
2
Fanni Persiani XIX ().
Antonio Tamburini XIX ().
LE VOCI VERDIANE
Soprani nelle opere di G. Verdi
Nella met dell 'Ottocento, con la torrente delle opere verdiane, il
periodo storico di canto di Bellini e Donizetti cambia indole e forma. Dal
1842, quando fu messo in scena il "Nabucco" al 1855 apparvero "I Lombardi";
"Ernani", "I due Foscari"; "Attila"; "Giovanna d'Arco", "I Masnadieri", "Luisa
Miller", "Rigoletto","Il Trovatore", "La Traviata", "I Vespri Siciliani", ecc.
Per eseguire queste opere occorrevano cantanti meritevoli, prodigiosi,
perche le parti erano molto difficili, specialmente "I Lombardi" e "Il
Trovatore". Fra le donne, interpreti delle opere di Verdi erano soprani: la
Frezzolini, la Strepponi, la Brambilla, la Barbieri-Nini, la Patti, ecc:
38
Copyright & A K-C
Erminia Frezzolini (18181884) stata la prima a portare alla ribalta
due opere di G. Verdi, scritte per lei, "I Lombardi" e "Giovanna d'Arco",
ambedue con gran successo alla Scala di Milano. Cant in tutti i principali
teatri d'Italia e all'estero, si sofferm lungamente a Parigi, dove Paganini la
scritturo nella stagione del 1853 per il Teatro Italiano. Essa brill per purezza
di voce, per canto soave, per efficacissima espressione e per la sua grande arte
musicale e drammatica. Felice Romani scriveva a proposito dell 'esecuzione
della "Beatrice di Tenda" di Bellini al Regio di Torino nel 1841 che nessuna al
pari di lei, dopo la Malibran, era dotata di voce pi estesa, pi flessibile, pi
melodiosa.
G. Verdi mostrava una illimitata ammirazione per la Frezzolini e,
nominandola, o sentendola nominare egli soleva portare la mano al cappello e
scoprirsi leggermente il capo.
Giuseppina Strepponi (18151897) studi al Conservatorio di Milano
ed esord con tal successo che fu subito scritturata all'Opera italiana di Vienna.
Cant in seguito a Roma, Firenze, Bologna, Venezia. Nel 1839 alla Scala di
Milano interpret "Lucia di Lammermoor" e l"'Elisir d'amore" di Donizetti e
"I Puritani" di Bellini. Con enorme successo cre la parte di Abigaille nel
"Nabucco" di Verdi. Morta la Malibran, declinanti la Pasta i, appena agli inizi
la Frezzolini, Giuseppina Strepponi divenne prima-donna. Milano ammiro in
lei la purezza cristallina del timbro e l'impeccabile musicalita. Nel 1849 si
ritir dalle scene, diventando la signora Verdi. Giuseppina Strepponi aveva
voce limpida, penetrante, soave, azione efficace; a questi doti aggiungasi la
virtuosit del canto, in cui si mostrata eccellente.
La Barbieri-Nini, Marianna (18201887) celebre soprano italiano.
Allieva di G. Pasta, fu la prima interprete delle opere di Verdi "I due Foscari",
"Il Corsaro", "Macbeth". Brill nel genere drammatico, dove ella trovava degli
slanci appassionati che trasportavano l'uditorio. Fu impareggiabile nella
"Lucrezia Borgia" di Donizetti, ove la sua potenza tragica era impressionante.
Con quest'opera la Barbieri-Nini soleva comparire per la prima volta innanzi
ai nuovi pubblici, perche ci le permetteva di cantare coperta dalla maschera
la sua aria di sortita "Come e bello" e nascondere cos la bruttezza del volto.
Quando alla fine dell'atto essa era obbligata a rivelare al pubblico le sue
sembianze, questo ga vinto dalla virt straordinaria della cantante, non
avvertiva pi, o quasi, la bruttezza della donna.
39
Copyright & A K-C
La Barbieri-Nini, scelta da Verdi per la parte difficilissima di lady
Macbeth, ricorda, come lavorava il maestro cogli interpreti per ottener
maggior effetto. Le prove del "Macbeth", fra pianoforte e orchestra salirono a
pi di cento, poich il Verdi non mostravasi mai contento della esecuzione e
richiedeva una migliore interpretazione dagli artisti. Erano due, per Verdi, i
punti culminanti dell'opera: la scena del sonnambulismo e il duetto di lady
Macbeth con Mister Macbeth (baritono). La sola scena del sonnambulismo
assorb tre mesi di studio. Per tre mesi, mattina e sera, la Barbieri-Nini cerc
d'imitare quelli che parlavano dormendo, che articolavano parole, come diceva
il maestro, senza quasi muovere le labbra, lasciando immobili le altre parti del
volto, gli occhi compresi... E il duetto col baritono, che comincia "Fatal mia
donna", fu provato pi di centocinquanta volte per ottenere, come diceva
Verdi, che fosse pi discorso che cantato. Il duetto ebbe un successo trionfale.
Dappertutto, dove la Barbieri-Nini ha cantato alla Pergola (di Firenze), quel
duetto bisogno ripeterlo due, tre volte, perfino quattro.
Adelina Patti (18431919) nata da genitori italiani a Madrid. A soli
sei anni cantava con relative perfezione i pezzi pi difficili delle opere da lei
udite dalle maggiori cantatrici dell 'epoca L'anima della piccola Adelina, nata
istintivamente alla musica,assorbiva al'atmosfera benefica delle grandi
virtuose. Nel 1850 nella sua prima comparsa, innanzi al pubblico di NewYork,aveva allora otto anni appena, essa meravigli l'uditorio cantando il
rondo della "Sonnambula" e la famosa canzone LEco . Dagli otto ai sedici
anni la piccola virtuosa studi assiduamente, ma era costretta di tanto in tanto
a fare del le trionfali apparizioni in qualche concerto per conto dei suoi ingordi
impresari. Il suo vero primo debutto, come primadonna, essa lo fece nella
"Lucia di Lammermoor" il 24 novembre 1859 a New-York al Teatro
del1'Opera italiana. Durante quella grandiosa stagione essa cant nelle opere
"La Sonnambula", "Don Pasquale", "I Puritani", lElisir d'amore", "Marta",
"Don Giovanni", "La Traviata', "Il Trovatore", "Rigoletto", "Ernani", "Mose",
"Linda di Chamounix", ecc. Adelina Patti possedeva la voce pi perfetta come
suono. Essa era veramente nata per cantare e per deliziare il mondo, e lo
faceva per l'abitudine, con mediocre entusiasmo. Il suo intelletto bastava a
tutto nell'esercizio dell'arte sua: il cuore non vi entrava per nulla. Eppure nella
"Traviata" riusciva anche a commuovere: "Addio del passato" cantato dalla
Patti, vi scendeva nell'anima come il pianto melodioso d'una fata; quelle sue
40
Copyright & A K-C
mirabili note sembravano dolorose ed erano carezzose. Nel "Barbiere di
Siviglia" la voce di Patti diveniva di una festivit e d'una gaiezza incantevole.
I suoi gorgheggi, d'impareggiabile purezza, sembravano il tintinno di un
campanello d'argento.
Adelina Patti ha avuto il dono della voce pi bella che forse sia mai
esistita al mondo, ed stata, senza dubbio, la cantante lirica, che ha toccato
pi da vicino le cime della perfezione assoluta.
Il grande e primo viaggio artistico di Adelina Patti in Italia sollev
entusiasmi fantastici. Nelle citt dove cantava la Patti, gli alberghi erano pieni
di forestieri: vi furono sere, in cui molti, arrivati cogli ultimi treni, dovettero
dormire per le strade e nelle piazze.
Verdi in una lettera (27 dicembre 1877) scriveva: "Qui nulla di nuovo se non
che vi furono tre recite della Patti con entusiasmo incredibile. Meritamente,
per tura d'artista cos completa, che forse non vi stata mai uguale... Voce
meravigliosa, stile di canto, purissimo. Artista stupenda con un charme e un
naturale che nessuna ha".
_______________________________________________________________
1
2
Felice Romani XIX , .
La Pergola .
Tenori nelle opere di G. Verdi
Fra gli uomini, interpreti delle opere di G. Verdi, erano tenori famosi
Fraschini, Tamagno, Stagno, Masini, ecc.
Gaetano Fraschini (18161887) fu uno dei pi grandi esecutori del
repertorio verdiano. G. Fraschini studi lettere, filosofa e volle dedicarsi alla
medicina quando scopr una bella voce di tenore, e si diede all'arte lirica.
Interpret a Bergamo il Rodrigo nel'"Otello" di G. Rossini; si esib al San
Carlo di Napoli (18421848) dove incontr il favore del pubblico. Cant alla
Scala e all'estero, specialmente a Londra dove fu dichiarato "il re dei tenori"
del suo tempo. Fraschini eccelse nelle opere di Verdi ("Luisa Miller", "Il
Trovatore", "Rigoletto"; "Oberto conte di S. Bonifazio", "I Lombardi", ecc.) e
di altri compositori di quel felice periodo del melodramma italiano. Per lui
41
Copyright & A K-C
scrissero G. Donizetti ("Caterina Cornaro"), G. Verdi ("Alzira" e "Un ballo in
maschera") e molti altri dei maggiori maestri. Dotato di una voce potente, di
timbro delizioso e di straordinaria estensione, poteva cantare per circa
trent'anni.
Francesco Tamagno (18511905), celebre tenore italiano, nacque a
Torino, in Piemonte. Suo padre era oste della Trattoria del Centauro, dove il
canto era in onore quasi quanto il vino o il pesce fritto. Al liceo musicale il
professore Pedrocchi vide in Francesco un possibile buon corista e nulla pi.
Tuttavia si ricord di lui durante la stagione del Regio di Torino nel 1870,
quando venne a mancare il secondo tenore del "Poliuto" di G. Donizetti e
Tamagno esord in questopera a diciannove anni con gran successo. Un
impresario di Milano, certo Rosani, lo fece studiare seriamente e lo sorresse
nei primi passi, dopo il servizio militore, con un assegno mensile, ma la
preparazione fu scarsa e mal condotta. Pero gi nel corso dei lunghi lavori tra
il 1873 e 1887 la lucentezza dei suoni aveva conquistato il pubblico, sebbene
in quegli anni fossero celebri i tenori Masini e Stagno, Gayarre, Campanini e
Marconi.
F. Tamagno esord a Palermo come primo tenore nel 1874 in "Un ballo
in maschera" con successo enorme.
Un pomeriggio d'ottobre del 1877, il Rosani vede passare in Galleria di
Milano Giulio Ricordi e lo domanda: Vuoi sentire una meraviglia? Ci ho un
tenore piemontese con una voce da sbalordire!
Ricordi acconsente, e Tamagno canta per lui con voce di una potenza
straordinaria, rafforzata dalla dizione chiarissima, talch tutte le parole
spiccavano sillaba per sillaba. E Ricordi subito s'arrende: E vero, signor
Rosani, vero; una voce che sbalordisce, ma credo che manchi un po' di
studio. Tamagno fu scritturato alla Scala (nel 1877), dove cant in molti
spettacoli. Dotato di acuti di formidabile squillo e potenza, Tamagno
predilesse subito il repertorio verdiano ("Ernani," Simon Boccanegra", "La
forza del destino", ecc.) Emerse ancora nel "Trovatore", "Don Carlos", "Aida".
II celebre direttore d'orchestra Franco Faccio scrisse a Verdi a proposito
dell'"Ernani": "Benissimo il Tamagno, dalla voce eccezionale". Cos comincia
la leggenda di Tamagno, la sua collaborazione con Giuseppe Verdi che invit
Tamagno a eseguire la parte di Otello nella sua nuova opera nel 1887. Verdi
42
Copyright & A K-C
scriveva a Faccio e a Boito: "Ed ora, mio caro Faccio, vi prego caldamente di
far studiare a Tamagno la sua parte... Anche imparata la musica, vi sara molto
da dire nell'interpretazione e nell'espressione".
Appena cominciate le prove, si cap che l'insegnamento pi sicuro
sarebbe venuto proprio da Verdi, il quale s'improvvis attore di singolare
potenza ed esegu la scena della morte.
Tamagno ascoltava e taceva. Sentiva che questa era la sua grande ora,
l'attimo, in cui nel tenore poteva svegliarsi un grande artista. Il trionfo del 5
febbraio 1887 ebbe per lui un significato grandissimo.
Con l'Otello Tamagno entrato nella storia del teatro. Ci che colp in
lui, era ci che gli veniva negato: il talento d'attore. Nella seconda met del
secolo XIX due tenori Roberto Stagno a Angelo Masini si contendecano il
primate sulle scene italiane e straniere.
Roberto Stagno (Vincenzo Andreoli) (18361897), celebre tenore
drammatico. Esord a Lisbona nel 1865 nell'opera "Roberto il Diavolo" di
Meyerbeer, sostituendo il grande tenore Tamberlick che ammalo. La voce
bellissima di Stagno e la sua arte scenica vinsero il pubblico. Il trionfo fu
straordinario. Da quella sera cominci la sua celebrit, e da quel momento egli
adott il nome di Roberto. R. Stagno cant sulle scene primarie del mondo e
fu ammirato non solo per le splendide qualit canore, ma anche per la squisit
arte scenica, versatilit e la scrupolosa cura d'ogni minimo particolare
riguardante il personaggio, ci che rendeva le sue interpretazioni storicamente
ed esteticamente perfette. Eccelse nelle opere di Verdi ("Otello", "La
Traviata"), Rossini ("II barbiere di Siviglia"), Bellini ("I Puritani"), Meyerbeer
("Africana"), ecc.
Insieme a Gemma Bellincioni fu il primo interprete della "Cavalleria
rusticana" di Mascagni e contribu al grandissimo successo dell'opera.
La sua abilit vocale gli permetteva di andare dal "Barbiere" agli
"Ugonotti", dai "Puritani" al "Roberto il Diavolo", dal "Lohengrin"
all'"Otello".
Angelo Masini (18441926) invece possedeva una voce dolce, soave,
cristallina nella vocalizzazione. Esord nel 1868 nella "Norma" con un
successo grandissimo. Cant nei principali teatri d'ltalia e dell'estero, fu al
Cairo, a Lisbona, Londra, Vienna, per sei anni a Pietroburgo, in America, ecc,
43
Copyright & A K-C
ovunque trionfalmente accolto, per la finezza del suo canto e l'arte perfetta,
specialmente per la sua voce d'un timbro soavissimo. La sua voce vi si
insinuava fin dentro l'anima e portava il pubblico al delirio.
Masini fu il cantante preferito di Verdi che lo apprezzava assai e lo voile
interprete della sua "Messa da requiem" in tourne a Parigi, Londra e Vienna
nel 1875. Masini eseguiva il repertorio lirico di tutte le scuole dai "Pescatori di
perle" di Bizet al "Lohengrin" di Wagner; eccelse nelle opere di G. Verdi
("Rigoletto", "La Traviata", "Aida"), ecc. Ultima grande figura del tenore
virtuoso, gli si attribuiscono sette variazioni diverse per concludere "La donna
mobile" (la canzonetta del duca dal "Rigoletto").
1
Giulio Ricordi , .
2
Gemma Bellincioni XIX ().
Baritoni nelle opere di Verdi
Le voci di baritono e basso furono valorizzate al pari delle tenorili,
nell'Ottocento romantico. Solo nelle opere di Donizetti e di Verdi il baritono
trov la sua fortuna, incarnando nel mondo dei suoni la voce affettuosa del
padre, o quella adirata del marito oltraggiato, o la parola ammonitrice del
saggio, talvolta, la frivolit di un Don Giovanni o la perfidia di uno Scarpia
E la voce pi commune nel canto. Fra gli interpreti delle opera di Verdi, vi
erano baritone famosi Ronconi, Coletti, Varesi, Maurel, Cotogno, Battistini e
altri.
Giorgio Ronconi
II famoso baritono Giorgio Ronconi (18101890) aveva una voce d'una
forza e nello stesso tempo d'una malleabilit straordinaria. Egli poteva ridurla
alle pi sottile gradazioni del suono poteva distenderla con un falsetto
meraviglioso, sino al naturale acuto. Eccelse nel repertorio verdiano
(Rigoletto) e fu anche un acclamato interprete di opere donizettiane. Gli altri
baritoni del tempo non potevano emulare Ronconi.
Filippo Coletti (18111894), rinomato baritono e basso cantante esord
al San Carlo di Napoli nel 1835. Cant nei principali teatri e d'Europa. Il
Coletti fu magnifico nelle opere di Verdi e in alcune parti, come ad esempio,
44
Copyright & A K-C
nel "Trovatore", nei "Masnadieri" e nei "Due Foscari" lasci ricordi insuperati.
Verdi, udendolo cantare la famosa aria "La sua lampada vitale", dichiar che
nessun altro a potuto darle interpretazione vocale pi vigorosa ed efficace.
Quella romanza fu chiamata per molti anni di Coletti e venne anche stampata
con questo titolo. Eccelse anche nelle opere di Rossini Turco in Italia" e
"Mois") e di Bellini ("Beatrice di Tenda"), ecc.
Con meravigliosa agilit eseguiva le parti pi difficili, sia drammatiche
che d'agi-lit; aveva una fenomenale estensione di voce e sapeva
maestrevolmente colorire tutti i caratteri. Grazie alla facilit, con cui
vocalizzava, conserv sempre un'intonazione perfetta,
ed il timbro della sua voce rest sempre uguale e sonoro. Coletti autore
dell'opuscolo "La scuola di canto in Italia. Pensieri".
Felice Varesi (18131889), celebre baritono, dotato di talento
eccezionale e di una splendida voce, esord a Varese nel "Torquato Tasso" di
G. Donizetti (1834), poi in breve si esib con plauso sulle maggiori scene di
Europa. Ebbe la voce vibrante, sonora e pastosa del Ronconi, lo stesso modo
ampio e bello di fraseggiare, lo stesso fuoco sacro, la stessa passione, lo stesso
impeto nella interpretazione del dramma.
Nel "Rigoletto", scritto per lui dal Verdi, Varesi raggiunse tale potenza
di colore che il ricordo di quel suo quadro scenico e rimasto, sino ad oggi,
insuperato. Qui, la sua figura bassa, tarchiata, era di vantaggio come anche
nella parte di Macbeth. Eccelse anche nella parte di Germont dell'opera "La
Traviata" di Verdi.
Victor Maurel (18481923), celebre baritono francese esord nel 1868
negli "Ugonotti" di J. Meyerbeer, cant in Italia, Spagna, America, ovunque
con grandissimo successo.
Egli possedeva una figura proporzionata e ben fatta, un ingegno
vivacissimo, una voce piena di colore e di calore, robusta e flessibile, una voce
di baritono vero, con tendenza allo scuro, ma da cui egli traeva fuori delle
mezze tinte e anche dei chiari per mezzo delle modulazioni, che davano al suo
canto un'espressione efficacissima. Il suo nome legato soprattutto alle prime
rappresentazioni di "Otello" (1887) e "Falstaff" (1893) di G. Verdi che lo
stim molto e lo volle il primo interprete dei ruoli di Jago e di Falstaff.
Quando Victor Maurel venne a cantare il Jago nell'"Otello" egli era gi
notissimo in Italia. La parte di Jago quasi tutto un recitative melodioso, fine,
45
Copyright & A K-C
che richiede unaccuratezza squisita di frase e di accento, che sottolinei, per
cos dire, la frase musicale. E Maurel ruisc a superare le intenzioni artistiche e
musicali dell'autore.
Maurel aveva molto lavorato e indagato intorno ai personaggi da lui
interpretati, cos fece anche col Falstaff,e Verdi gli scriveva nel 1892, alla
vigilia di "Falstaff":
"Mio caro Maurel! Ammiro in generale lo studio e ammiro in
particolare quello che voi farete sul personaggio di Falstaff..."
II personaggio di Falstaff riusc bello, libero, sincero e completo.
Maurel fu anche interprete del "Don Giovanni di" Mozart, del'"Amleto" di
Tomas, del "Simon Boccanegra" e "Rigoletto" di Verdi. A proposito di lui nel
"Simon Bocanegra" Verdi scriveva a un amico in data di 8 agosto 1881:
"Peccato! Se foste venuto a Milano, avreste visto un attore e un cantante come
se ne vede ben di rado. Maurel un Simone Boccanegra ch'io non vedr pi
uguagliato". R. Leoncavallo scrisse per V. Maurel il celebre prologo dei
"Pagliacci". Nel 1904 Maurel si ritir dalle scene e si dedic all'insegnamento
di canto.
Antonio Cotogni (18311918), celebre baritone, nella sua lunga
carriera interpret oltre centacinquanta opere, eccellendo soprattutto in quelle
verdiane.
Impareggiabile interprete delle opere "Don Carlos", "Macbeth" e
"Rigoletto" di Verdi, "Africana" e "Ugonotti" di Meyerbeer, "Lohengrin" e
"Tannhauser" di Wagner e di molte altre, fu applaudito in tutti i primari teatri
del mondo.
La sua voce piena, fluida, uguale, dal timbro pi simpatico, commoveva
l'uditorio, specialmente nel canto a fior di labbra.
Fra le tante e tante opere cantate dal Cotogni, e si tratta di una cifra
favolosa, nessuna rimasta attaccata alla sua persona, quanto il "Don Carlos".
Dopo il 1868 la fama di Cotogni crebbe talmente che la Russia, lInghilterra e
la Spagna se lo disputarono continuamente, lasciandogli ben rare volte
occasione di cantare in Italia. Ritiratosi dalle scene tardi, il Cotogni si dedic
all'insegnamento e form al liceo musicale di S. Cecilia a Roma numerosi
cantanti, fra cui G. Lauri Volpi, M. Basiola, B. Franci, M. Stabile.
1
M. Basiola, B. Franci, M. Stabile
XVIII XIX . ().
46
Copyright & A K-C
Mattia Battistini
(18561928)
Egli era considerato re dei baritoni italiani, avendo conquistato le corti e
il pubblico di tutta l'Europa tra il 1878 e il 1928. Esord trionfalmente
all'Argentina di Roma nella "Favorita" di Gaetano Donizetti nel 1878.
Battistini aveva nel repertorio 82 parti, dal "Roberto Devereux" di
Donizetti alla "Tosca" di Puccini, dal "Faust" di Gounod al "Rigoletto" e
aH'"Otello" di Verdi, e le eseguiva tutte in modo vocalmente perfetto e da
attore brillante. Sono da ricordare anche "Un ballo in maschera" (la parte di
Renato) e "Falstaff" di Verdi, delle quali il Battistini fu interprete eminente.
Per educazione e natura la voce di Battistini era verdiana e ottocentesca,
e faceva meraviglie nella esecuzione delle opere di G. Verdi rivaleggiando con
la voce di Giuseppe De Luca (pero Battistini non eccelleva nelle opere
veriste).
Si ritir dalle scene nel 1927, dopo aver cantato nei massimi teatri lirici
d'Europa (specialemente in Russia) e nell'America del Sud.
I numerosissimi dischi di Battistini (opere, arie da camera, romanze,
canzoni) rappresentano le pi importanti documentazioni di arte di canto:
il suo timbro chiaro, soave, brillante, pianissimi incantevoli, fioriture.
E considerato con Antonio Cotogni il pi grande baritono italiano
dell'Ottocento.
CANTANTI FAMOSI ITALIANI DEL NOVECENTO
Soprani e mezzosoprani
Nel Novecento emergono bellissime voci di soprano e di mezzosoprano.
Fra le voci femminili del Novecento basta nominare Maria Callas, Renata
Tebaldi, Monserrat Caball.
Maria Calias possedeva una voce stupenda di soprano drammatico fino
al mi bemolle della terza ottava, un'ottima tecnica vocale, un timbro unico
della voce, ed era una grande musicista e artista.
47
Copyright & A K-C
La Callas rinnov una tecnica che il verismo aveva praticamente
distrutto: il canto sul fiato , i passaggi di registro, ecc. Maria Callas torn
alla fondazione della scuola italiana prima dell'avvento del dramma musicale e
del verismo, e fu questo che le permise di rompere le barriere che dalla fine
dell 'Ottocento separavano i soprani drammatici dai lirici e i lirici dai leggeri.
Il ritorno alla tecnica antica fu anche il ritorno a un repertorio che consentiva a
un soprano di essere Luci, Norma. La Callas sollecit raffronti con
primadonne come la Malibran o la Pasta; il suo modo di cantare e di
interpretare era legato a un repertorio in gran parte scomparso. La Callas diede
un decisivo impulso alla rivalutazione di opere dimenticate. Lo fece non solo
con le riprese della "Medea", della "Vestale", del "Turco in Italia",
dell"Armida", dell'"Anna Bolena", ma con una maniera nuova di cantare la
"Lucia", la "Sonnambula", la "Norma", "I Puritani", il "Macbeth", "I Vespri
Siciliani".
La Callas dimostr che cosa veramente avesse rappresentato, per
Rossini, per Donizetti, per Bellini, per il primo Verdi, la coloratura: proprio un
modo di esprimersi, sia pure per allegora.
Maria Callas aveva il dono di immedesimarsi con i suoi personaggi;
l'andatura, l'at-teggiamento, l'espressione del viso, la truccatura, il modo di
indossare il costume erano elementi della sua recitazione, della sua presenza
magnetica. La sua recitazione si basava sul gesto melodrammatico
tradizionale, a volte anche molto enfatico.
Maria Callas resta il modello interpretativo di personaggi eccezionali.
Eccezionali o per la particolare versione che la Callas pot dare della loro
vocalit, o per il loro rango e la loro indole aggressiva e tragica: Medea,
Armida, Lady Macbeth.
Solo due tenori sarebbero stati, vocalmente, i partner ideali della Callas:
il Lauri-Volpi e il Pertile degli anni venti e dei primi degli anni trenta. La
Callas aveva una gamma di colori inesauribile, dalle inflessioni del
mezzosoprano a quella del soprano di coloratura.
I suo momento migliore fu breve: dai 1947 al 1955. Poi la voce
cominci a stridere nei sopracuti, ad oscillare negli acuti, a perdere duttilit
nelle smorzature e nei piani. Ma Maria Callas, vocalmente, non mai
scomparsa.
48
Copyright & A K-C
Lauri-Volpi nei suo libro "Voci parallele" definisce cos la voce della
Callas: "Voce leggera, lirica, drammatica, abbraccia il repertorio,
rappresentato da tre secoli e mezzo di musica melodica: voce multipla, metodo
personalissimo".
_______________________________________________________________
1
Aureliano Pertile (), 1916
.
Licia Albanese (1909), celebre soprano italiano, nata a Bari nei 1909.
Dall'infanzia aveva una bellissima voce, studi sotto la direzione dell'excantante Giuseppina Baldassarre Tedeschi, che le insegno canto e arte scenica,
portando la formazione della sua allieva a un livello notevole.
II suo debutto scenico avvenne quasi per puro caso. Ella era andata a
Milano per assistere con un amico ad una recita di "Madame Butterfly" alla
Scala. Per volere del destino accadde che la primadonna, dopo il primo atto, si
senti male. Il direttore del Teatro, preoccupato, cerc di trovare una sostituta, e
si calm solo quando gli fu detto che in sala c'era una giovanissima cantante
che conosceva la parte e che si chiamava Albanese. "Che venga questa
Albanese", grid il direttore. Lopera aveva un grande sucesso, da allora
Madame Butterfly divenne la pi grande fortunata interpretazione
dellAlbanese.
Circa un anno dopo, nel 1935, Licia partecip ad un concorso nazionale
per La pi bella voce , indetto dal governo italiano, e dopo quattro lunghe
giornate di selezioni, fra 300 candidate venute da tutte le regioni, ella fu la
prescelta, ricevendo una medaglia d'oro.
Da allora fu richiesta per recite in tutta Italia. Ella fece il suo debuttto
ufficiale al Teatro Reale di Parma con Butterfly, quindi cant alla Scala di
Milano. La pronuncia non e sempre perfetta, l'emissione delle note acute non
tutte impeccabili, ma specialmente nel registro centrale la voce e dolce, calda,
ardente, ricca di smalto.
Essa possiede, inoltre, ci che non si insegna: il cuore, il temperamento
e una calda sensibilit musicale e drammatica.
In seguito l'Albanese cant alla Scala nella parte di Lauretta del "Gianni
Schicchi". Poi pass a cantare al Covent Garden di Londra sostenendo la parte
49
Copyright & A K-C
di Li nella "Turandot" e quella di Alice nel "Falstaff"; si esib a Parigi, in
Spagna, in America. Licia Albanese si afferm in particolare al Metropolitan
di New York sotto la direzione di Arturo Toscanini quale interprete del
repertorio pucciniano e della Traviata verdiana.
Mirella Freni nata nel 1935 a Modena. Nel 1958 conquist primo
premio al concorso internazionale Viotti a Vercelli . Da questo momento
ha inizo la intense attivit artistica della cantante, che l'ha portata al successo
in Italia e all'estero. Il debutto milanese della cantante avvenne nel gennaio del
62 sul palcoscenico della Piccola Scala nella opera di Hndel "Serse". Da quel
momento Mirella Freni canta sul palcoscenico della Scala e va in tourne nei
pi grandi teatri musicali d'Europa e d'America. Nel suo repertorio le parti
migliori sono quelle di Mimi e Li ("Boheme" e "Turandot" di Puccini) che ha
interpretato con successo al tempo della tourne del Teatro alla Scala a Mosca.
Deliziosa e patetica Mimi e scintillante Adina nell' "Elisir d'amore", la Freni
ha dato ammirevole dimostrazione della sua virt canora e interpretativa.
_______________________________________________________________
1
Viotti , .
.
2
Vercelli .
Renata Scotto nata a Savona nel 1936. Cominci a studiare canto
sotto la direzione della esperta maestra Mercedes Slopart. Nell'estate del 1953
avvenne il debutto della giovane artista nel teatro Nuovo, sulla scena del quale
interpret la parte di Violetta nell'opera di Verdi "La Traviata". Nella stagione
seguente Renata Scotto fu invitata al Teatro alla Scala di Milano, dove cant
nella parte di Valtera nella "Wally" di Catalani; i suoi partners nello
spettacolo furono i famosissimi cantanti italiani Renata Tebaldi, Mario Del
Monaco e il baritono Giangiacomo Guelfi .
Nel'57 al festival di Edinburgo la giovane artista sostitu con successo
Maria Callas nell'opera di Bellini "La Sonnambula". La partecipazione a
questo spettacolo porto alla giovane cantante ampia fama. In ogni
interpretazione si perfeziona l'arte di Renata Scotto. Adina nell' "Elisir
50
Copyright & A K-C
d'amore" e Lucia nella "Lucia di Lammermoor" di Donizetti, Antonida
nell'"Ivan Susanin" di Glinka, Micaela nella "Carmen" di Bizet, Margherita
nel "Faust" di Gounod, Gilda nel "Rigoletto" e Mannetta nel "Falstaff" di
Verdi, Butterfly in "Madame Buterfly" di Puccini, ecco l'elenco di gran lunga
incompleto delle parti, interpretate dalla cantante. Renata Scotto oltre che
bravissima cantante, anche una magnifica attrice. Con la sua arte hanno fatto
conoscenza gli amanti dell'opera di molti paesi d'Europa e d'America. Si
esibita a Mosca nel 1974 con il Teatro alla Scala nell'opera "Simon
Boccanegra" di Verdi.
Wally
(
XIX ).
2
Renata Tebaldi XX ().
3
Festival di Edinburgo .
Katia Ricciarelli (1947), soprano, ha vinto i concorsi di canto: Voci
nuove a Parma, Nuove voci verdiane in TV e altri ancora. E ammirata
nelle mezze voci e nelle note filate (cio nel bel canto della Callas). IL
repertorio della Ricciarelli comprende una quindicina di opere; si orienta su
Verdi, Donizetti, Bellini. La sua maestra di canto era Iris Adami Corradetti
celebro maestro di canto che aveva cantato alla Scala dodici anni di seguito.
Katia si present alla signora Corradetti, avendo solo quattordici anni, con i
tacchi a spillo, per sembrare pi adulta. Torna, quando avrai diciotto, le
disse la signora Corradetti.
Katia abitava a Rovigo con la mamma e la sorella. Le servivano soldi
per andare a studiare al Conservatorio di Venezia, e allora and a fare la
commessa. Finalmente, i diciotto anni, gli esami al Conservatorio. E fu
ammessa! E Katia and ad abitare a Venezia, ma lo studio e l'affetto per la
maestra non le bastavano.
51
Copyright & A K-C
Venezia non una citt per chi e solo. E allora la mamma lasci Rovigo
e and a vivere con lei a Venezia. Nel 1974 avendo 26 anni Katia Ricciarelli
venuta a Mosca (con la Scala), ed ha cantato con successo nella "Messa da
requiem" di Verdi nella Sala Grande del Colservatorio. La celebre cantante
Mafalda Favero disse di lei: "Ormai non pi una promessa, e una
rivelazione".
1
Iris Adami Corradetti .
Rovigo .
Fiorenza Cossotto, celebre mezzosoprano, nata vicino a Vercelli nel
1935. Ha studiato al Conservatorio di Torino e dopo una serie di vittorie in
concorsi di canto fu invitata alla Scala nel 1956. Esord alla Scala il 26
gennaio 1957, prendendo parte alla prima dei "Dialoghi delle Carmelitane" di
Poulenc; poi segu una lunga serie di ruoli. Si affermata poi in campo
internazionale, cantando nella "Medea" accanto alla Callas al Covent Garden
di Londra (1959). Rapidamente attir su di s l'attenzione come splendida
interprete di parti dal repertorio classico e moderno, nelle opere: "Orfeo" di
Monteverdi, "La sposa venduta" di Smetana, "Ivan Susanin" di Glinka,
"Manon Lescaut" di Massenet, "L'angelo di fuoco" di Prokof'ev. Grande fama
acquist la cantante nel 1962, dopo l'in-terpretazione del ruolo principale nella
"Favorita" di Donizetti, della parte di Azucena nel "Trovatore", di Amneris
nell"Aida", di Eboli nel Don Carlos di Verdi Fiorenza Cossotto ha fatto
tournes in molti teatri europei, fu inclusa nel gruppo della Scala al Festival di
Edinburgo; stata a Mosca in tourne con la Scala, dove ha eseguito la parte
di Rosina nel "Barbiere di Siviglia" di Rossini. Fiorenza Cossotto ha la voce di
naturale bellezza di suono, timbricamente lucente e squillante, possiede la
facilit di emissione, l'intensit del fraseggio, il vigore espressivo e l'abilit
della tecnica vocale.
_______________________________________________________________
1
Covent Garden .
J. Massenet XX .
, .
52
Copyright & A K-C
Montserrat Caball
Montserrat Caball, il cui nome completo Maria de Montserrat
Viviana Concepcin Caball i Folc (Barcellona, 12 aprile 1933), un soprano
spagnolo. la pi famosa cantante lirica spagnola. La sua voce di soprano
universalmente ammirata per la purezza, il controllo dell'emissione (sono
celebri i suoi filati), la potenza e la duttilit.Dopo aver studiato 12 anni presso
il Conservatorio di Musica del Liceo di Barcellona, nel 1956 entr nella
compagnia dell'Opera di Basilea , dove debutt nel 1957 come Mim ne La
Bohme , in seguito interpretando numerose opera.
Specializzatasi in seguito nel repertorio italiano del primo Ottocento, nel
1962 fece ritorno a Barcellona, debuttando al Teatro del Liceu. Nel 1964 ha
sposato il tenore Bernab Mart dal quale ha avuto 2 figli: Bernab Mart Jr.
(1966) e Montserrat Mart, detta Monsita (1971).
La fortuna internazionale della Caball inizi nel 1965. Quando sostutui
una attrice in Lucrezia Borgia di G. Donizetti. La sua interpretazione dest
sensazione. Lo stesso anno, debutt al Festival di Glyndebourne e al
Metropolitan. Il 2 agosto 1969 debutt all'Arena di Verona 4 e il 24 febbraio
1970 al Teatro alla Scala. Nel 1972 lavor alla Scala. Il suo repertorio
operistico conta pi di ottanta personaggi e spazia dall'Opera barocca a Verdi,
Wagner, Puccini, Bellini e Richard Strauss.
Grande interprete di canzoni popolari spagnole, fece un'incursione nel
Rock Opera nel 1988, registrando con Freddie Mercury 5 l'album intitolato
Barcelona. La canzone omonimo divent l'inno dei Giochi Olimpici del
1992.
Negli ultimi anni, si dedicata a varie attivit benefiche ed
ambasciatrice dell'UNESCO. Ha creato una fondazione in favore dei bambini
bisognosi di Barcellona.
Nel 2004, accanto alla figlia Montserrat Mart, ha interpretato la
Cleopatra di Massenet in forma di concerto, al Teatro Real di Madrid.
Nel 2007, a Vienna, comparsa come attrice nella Figlia del reggimento di
Donizetti, nel ruolo della Duchessa di Crackentropp.
_______________________________________________________________
1
2
Opera di Basilea ().
Teatro di Liceu (. ).
53
Copyright & A K-C
3
4
5
6
Glydenbourne ().
Arena di Verona , .
Rock Opera ().
Freddi Mercury -.
Renata Tebaldi
Renata Tebaldi, una delle pi grandi artiste liriche, nacque a Pesaro il 1
febbraio 1922. In famiglia c'era una forte tradizione musicale: suo padre era
professore di violoncello, la nonna aveva una bellissima voce; anche sua
madre aveva una voce splendida, ma non aveva potuto studiare.
Renata Tebaldi studi il pianoforte, ma avendo una voce di bellissimo
timbro, decise di diventare cantante lirica e studio il canto al Conservatorio di
Parma con il professore Ettore Campogalliani.
Progrediva, ma niente faceva pensare che sarebbe diventata un'artista
famosa. Il cambiamento miracoloso avvenne in seguito a un incontro casuale:
a Pesaro, mentre era in vacanze, fu presentata a Carmen Melis che era una
delle pi grandi interpreti nelle opere di Puccini. La cantante si era
entusiasmata della voce di Tebaldi e cominci a studiare con lei; le insegnava
la respirazione, le posizioni delle labbra, della gola, ecc. per evitare toni
sgradevoli. In breve tempo il canto di Renata Tebaldi fu trasformato, ed essa si
trasfer al Conservatorio di Pesaro per studiare sotto la guida di Carmen Melis.
Esord a Rovigo nella parte di Elena nel "Mefistofele" con gran
successo. La sua voce conquist subito il pubblico: voce di bellissimo timbro,
estensione illimitata, tecnica raffinata, temperamento incline al canto piano e
calmo, fraseggio ricco di legature e portamenti, di smorzature delicatissime.
Nel 1945 Renata Tebaldi si trasfer a Milano; cant in diverse citt,
interpret la parte di Desdemona a Trieste.
Nella primavera 1946 era tornato a Milano il grande Toscanini, che ogni
giorno ascoltava dei cantanti per la riapertura della Scala. Anche Renata
Tebaldi ricevette l'invit all'audizione davanti al grande maestro nel maggio
1946. Un giudizio di Toscanini, come dice la Tebaldi, era una laurea
riconosciuta in tutto il mondo, una sua bocciatura era un fallimento, forse
definitive Canto tutta la "Canzone del salice" e l "Ave Maria" dal terzo atto di
"Otello" di Verdi, terminando con il famoso "la bemolle", pianissimo.
54
Copyright & A K-C
Toscanini era contento, gli piacque il suo canto, e Renata Tebaldi fu inclusa
nel cast del concerto per l'inaugurazione della Scala ricostruita.
Nel concerto Tebaldi cant nella "Preghiera del Mos" di Rossini una
piccola parte nel " Deum"di Verdi con grandissimo successo. Fu una serata
indimenticabile.
La Scala era zeppa. Cera gente in piedi, per i corridoi, dappertutto.
Quando entr Toscanini, ci fu un applauso interminabile.
Da allora Renata Tebaldi svolse un'intensa attivit operistica, con una
predilezione per il repertorio verista: "Madame Butterfly" e "Manon" di
Puccini, "Andrea Chenier" di Giordano, "Adriana Lecouvreur" di Cilea, ma
cant anche nelle opere la "Norma" di Bellini, e "Il Trovatore" di Verdi, nelle
quali manifest la profondit del sentimento e il canto purissimo. Ha eseguito
anche "Aida" e "La Traviata", nonch "Guglielmo Tell" di Rossini.
Angelo Sguerzi (autore del libro sui cantanti italiani) dice che i due
nomi Callas, Tebaldi raggiunsero una celebrit che, a trovarne di maggiori,
dobbiamo riandare ai tempi di Caruso e di Scialiapin: non si poteva quasi
tollerare una Norma che no si chiamasse Maria Callas, e il personaggio di
Desdemona era indiscindibile dal nome di Renata Tebaldi.
La sua "Canzone del salice" e la "Ave Maria" documentano quale
altezza abbia raggiunto la cantante nell'arte vocale.
1
Ettore Campogalliani XX .
Carmen Melis (18851967) (), .
2
Tenori del Novecento
"Nel primo ventennio del Novecento si esibisce con successo trionfale il
celebre Enrico Caruso non solo in Italia ma anche fuori.
Al tempo di Caruso erano nel pieno del loro fulgore Alessandro Bonci
che univa ad una grazia insuperabile un'educazione da grande virtuoso;
Fernando De Lucia, il grande interprete napoletano; Cesare Borgatti, famoso
tenore wagneriano dalla dizione perfetta e voce sonora; Angelo Masini,
perfettissimo tenore verdiano; G a y a r r e, il tenore lirico spinto con la voce
dolcissima ed estesa nel registro acuto.
55
Copyright & A K-C
Grazie a Verdi, Wagner e a Puccini la voce tenorile divenuta la regina
della scena lirica. Si pensi, ad esempio, ai tenori del Novecento quali Pertile,
Schipa, Lauri-Volpi, Pavarotti, Domingo, Carreras nelle vesti di Rodolfo,
Cavaradossi, Pinkerton o Des Grieux... In epoca della rinascita del bel canto
nessuno nega che il fattore principale e la voce con le sue naturali potenze e
con i suoi liberi squilli. Nel secondo Novecento apparsa una pliade di
esecutori di alta classe. Basta indicare tali tenori diversi come Giuseppe Di
Steiano e Mario Del Monaco; il primo pi lirico soave, il secondo pi virile,
ma ambedue con talento e temperamento originali.
Fra i tenori spiccano Franco Corelli, con la sua maniera drammatica di
canto, Gianni Raimondi con gli acuti sorprendenti, Carlo Bergonzi con il suo
gusto fine, Luciano Pavarotti, Placido Domingo con la tecnica perfetta e la
voce piena di passione.
Enrico Caruso
Nacque in una povera famiglia (originaria di Piedimonte d'Alife oggi
Piedimonte Matese, un piccolo centro dell'alto casertano). Il padre,
Marcellino, era un operaio metalmeccanico e la madre, Anna Baldini, faceva
la donna delle pulizie. Le prime arie d'opera e le prime nozioni di canto gli
vennero insegnate dai maestri Schiardi e De Lutrio. Ma oltre a cantare nel
coro della chiesa, Enrico fece qualche apparizione in spettacoli teatrali; la sua
voce nel frattempo si era irrobustita e le piccole rappresentazioni
cominciarono a non bastargli pi. La sua fortuna inizi quando il baritono
Eduardo Missino sentendolo cantare.
Nel 1894 Caruso venne chiamato alle armi, ma dopo solo un mese e
mezzo, grazie alle leggi in vigore a quel tempo e ad un maggiore che era
amante della musica, venne congedato e mandato a casa per permettergli di
continuare a cantare e a studiare. Dopo le lezioni con il maestro Vergine,
Caruso si sentiva ormai pronto all'esordio, ma alle prove non venne accettato.
Esordir il 16 novembre 1894.
Inizi cos ad esibirsi nei teatri di Caserta, Napoli e Salerno e fece la sua
prima esibizione. Nel 1897, a Salerno, Caruso conobbe il direttore d'orchestra
Vincenzo Lombardi che gli propose di effettuare con lui la stagione estiva a
Livorno; qui Caruso conobbe il soprano Ada Giacchetti, sposata e madre di un
56
Copyright & A K-C
bambino. Con lei avr una relazione che durer undici anni e da cui
nasceranno due figli: Rodolfo ed Enrico junior.
Nel 1898 Caruso esordisce al Teatro Lirico di Milano nel ruolo di Loris
in Fedora ; seguirono poi tourne in Russia, a Lisbona, Roma, Montecarlo e
al Covent Garden di Londra dove interpret il Rigoletto di Giuseppe Verdi;
l'anno dopo sar a Buenos Aires.
Nel 1900 Caruso cant nuovamente alla Scala nella Boheme e nel
1901 a Napoli al Teatro San Carlo qui, durante l'interpretazione de LElesir
damore ebbe la sua pi grande delusione: la sua emozione e un'insicurezza
malcelata non lo fecero cantare al meglio. Fortemente deluso dalla reazione
dei suoi concittadini e dalle critiche che gli vennero rivolte, (centrate sul fatto
se la sua voce fosse portata maggiormente al registro di baritono piuttosto che
su quello di tenore), decise di partire e di non cantare mai pi nella sua citt
natale.
A Milano incise il 11 aprile del 1902 dieci dischi con arie d'opera. Il
cantante napoletano fu il primo a cimentarsi nella nuova technologia, fino ad
allora snobbata da molti altri cantanti, e questo determin il suo successo e
quello della casa discografica. A novembre del 1903 in America e il suo
esordio avvenne il 23 novembre con il Rigoletto. Ebbe un tale successo con le
successive rappresentazioni tanto da diventare l'idolo dei melomani dell'epoca.
Nel 1909 incise una serie di ventidue canzoni napoletane che
comprendevano anche Core ingrato che era una dei megliore canzoni.
Sposata il 28 agosto del 1918 Dorothy Benjamin, ragazza di buona famiglia
pi giovane di lui di venti anni (dalla quale avr una figlia, Gloria), Caruso
inizi verso il 1920 a soffrire d'insonnia. Venne operato il 30 dicembre al
polmone sinistro. Il male lo ferm in una delle stanze dell'albergo Vesuvio a
Napoli dove mor a soli 48 anni.
sepolto a Napoli, in una cappella privata nel cimitero di Santa Maria
del Pianto nel quartiere Doganella.
Caruso interpret due film come protagonista, Il mio cugino, Il
romanzo splendido .
Alessandro Bonci (18701940) nato a Cesena (Romagna) da genitori
poveri. Coll'aiuto di un mecenate egli entr nel Liceo musicale di Pesaro, dove
rimase quattro anni, poi cant come primo tenore alla Cappella di Loreto. Cos
Bonci ha aspettato sette anni prima di presentarsi sulle scene, ed ha potuto
57
Copyright & A K-C
studiare e imparare bene la musica. Le opere predilette del Bonci sono "La
Traviata", "L'elisir d'amore" e "I Puritani". La sua voce argentea come
coperta di un leggerissimo velo, che la fa vellutata ed ha una intonazione
inappuntabile. Una particolarit del Bonci sono le cadenze che egli sa variare
ad ogni richiesta di bis. Si dedic alle parti di tenore leggero, ottenendo
successi grandiosi. Con trionfo si esib in "Un ballo in maschera" di Verdi con
quella risata argentina nel quintetto "Scherzo od e folia" a cui Verdi non aveva
mai pensato. E infatti, Verdi scrisse una lettera al Bonci da Milano, il 21
maggio 1898: "Caro Bonci,nel mio vecchio "Ballo in maschera" che il
pubblico fiorentino predilige, la vostra interpretazione mi stata graditissima e
mi ha fatto ridere, riandando al tempo lontano in cui lo scrissi. "E scherzo od
folla"... va detto quasi parlato e sfiorato col canto, e l'aggiunta della risata e
una vostra unica privativa e specialit che Vi riconosco e che mi riconferma la
vostra perizia..." II pubblico diceva allora: "Andiamo a sentire non "Un ballo
in maschera", ma l'irresistibile risata di Bonci". Bonci mor a Viserba, il 9
agosto 1940.
Giacomo Lauri-Volpi (18941979), celebre tenore italiano, segu per
un breve periodo un corso di canto all'Accademia di S. Cecilia a Roma, tenuto
da Antonio Cotogni, esordendo a Viterbo con "I Puritani" di V. Bellini. (Dopo
trent'anni da quel debutto cant ancora quest'opera, avendo a fianco la
incomparabile Maria Callas.)
Interpret il "Rigoletto" e canto a Roma nella "Manon" di Massenet, nel
1920. Due anni dopo, a Milano si esib ancora in Rogoletto con la
direzione di Arturo Toscanini.
Da Milano gir tutto il mondo, estendendo il suo repertorio, ma
scegliendo sempre con accoratezza i suoi cavalli di battaglia compositori del
primo Novecento pensarono a Lauri-Volpi come interprete di opere
particolari. G. Puccini ebbe in testa la voce di Lauri-Volpi quando scriveva
"Turandot". Mascagni gli affid la prima del "Nerone "nel 1928. Il centenario
del "Guglielmo Tell" di Rossini (1929) rivel il tenore, capace di superare
tessitura impossibili. Fu una voce "chiara", intensa, timbrata, virile; fu tenore
drammatico e tenore lirico, e anche tenore eroico. Gli bast una sola sera per
diventare una delle pi discusse e quotate voci del teatro lirico; passeranno
ancora degli anni, prima che questa voce possa esser dimenticata.
58
Copyright & A K-C
G. Lauri-Volpi trionf nelle opere pi impegnative come per esempio
"Il Trovatore", "Ugonotti", "I Puritani", "Guglielmo Tell", "Turandot", ecc. Lo
avevano ascoltato per l'ultima volta al Teatro dell'Opera di Roma quale
protagonista del "Trovatore" di Verdi. Una interpretazione stupenda,
invidiabile, che scaten in teatro il finimondo. Giacomo Lauri-Volpi era gi
allora vicino alla settantina. Nelle repliche dello spettacolo si ammal, e la sua
assenza quasi scaten una rivoluzione. Era Lauri-Volpi uno di quei tenori
1'ultimo forse -capace di fare ondeggiare intorno alla sua voce entusiasmi e
collera. Non era pero un "fanatico". Al contrario, era anche uno di quei
rarissimi tenori nei quali il canto costituiva il risultato di una profonda
consapevolezza artistica. La sua voce era uno strumento continuamente tenuto
in esercizio e continuamente perfezionato. Giacomo Lauri-Volpi lasci
numerosi libri (memorie, note di costume, ecc), tra i quali il pi importante,
"Voci parallele". Mor a Valencia in Spagna, dove viveva da anni, nel 1979.
Mario Lanza
Lanza chiamato familiarmente Freddy nasce da una famiglia di
emigranti italiani: il padre Antonio, emigrato negli Stati Uniti in giovane et,
era originario di Filignano, in provincia di Isernia, mentre la madre Maria
Lanza era originaria di Tocco da Casauria, in provincia di Pescara (Abruzzo).
Freddy cresce nella casa del nonno materno, proprietario di una
drogheria, il quale coltiva la passione per la pittura e possiede una ricca
raccolta di dischi di Enrico Caruso; Freddy diventa presto un grande
ammiratore del cantante e ascolta spesso tutti i dischi del nonno, divertendosi
a cantare le romanze con la sua naturale voce tenorile.
La madre, che possiede una bella voce da soprano, non intraprende
l'attivit di cantante perch il padre non glielo permette, ma visto il naturale
talento del figlio pur di riuscire a fargli studiare canto, non si risparmia di
lavorare per diverse ore al giorno. Freddy pu cos studiare con la ex cantante
lirica Irene Williams, che nel 1940 gli procura un'audizione all'Academy of
Music di Filadelfia e fa in modo che il maestro Serge Koussevitzky, arrivato
in quella citt per dirigere un concerto, riesca ad ascoltare la voce del ragazzo.
Freddy canta l'aria che ha rimasto profonda il maestro, disse: Questa
davvero una voce eccezionale: devi venire con me nel Berkshire. Con
59
Copyright & A K-C
l'espressione "nel Berkshire" egli intende alludere ai corsi di perfezionamento
annualmente tenuti al Festival di Tanglewood (Massachussets) presso il
Berkshire Music Center, ove si ritrovano musicisti e cantanti
semiprofessionisti per studiare, perfezionarsi e riposarsi insieme.
Freddy studi con seriet per migliorare e raffinare le sue doti naturali,
distinguendosi come miglior allievo e riuscendo cos esordire il 7 agosto 1942
riscuotendo unanimi consensi. Fra gli altri, il critico del New York Times loda
in particolar modo la superba potenza della sua voce.In questo periodo
assume il nome d'arte di Mario Lanza, in onore della madre, e poco tempo
dopo parte per il servizio militare. Terminato il servizio militare nel 1945,
poco tempo dopo si sposa a Beverly Hills con Elizabeth "Betty" Hicks.
Lanza si trasferisce a New York e continua a perfezionarsi nel canto
grazie al sostegno economico del suo agente Sam Weiler, che lo fa studiare
pianoforte e canto con Enrico Rosati nel 1942 grazie alle sue doti canore
vince una borsa di studio.Partecipa ad una tourne che lo porter negli Usa, in
Messico e in Canada. Nel 1947 viene chiamato dalla per interpretare una serie
di sette film musicali che lo impegneranno per altrettanti anni; nel frattempo
continua a tenere concerti, a incidere dischi e a partecipare a programmi
televisivi. Inizia anche una serie di tours di concerti.
Nel 1949 interpreta il suo primo film musicale, Il bacio di mezzanotte,
dove recita la parte di un autotrasportatore di pianoforti. Al termine delle
riprese, Lanza riesce a coronare quello che sempre stato il suo sogno:
interpretare un'opera lirica. Cant nella Madama Butterfly di Puccini,
cantando insieme al soprano Tomiko Kanazawa: nelle uniche due
rappresentazioni, ottiene i favori della critica.
La sua popolarit e gli impegni sempre pi pressanti non gli permettono
di interpretare altre opere liriche e i critici riterranno che questa sar una vera
perdita per il mondo del bel canto.
Nel 1950 gira il film Il pescatore della Louisiana , interpretando la
sua pi famosa canzone: Be my Love .
_______________________________________________________________
1
2
3
Serge Koussevitzky XX .
Festival Tanglewood ().
Enrico Rosati XX .
60
Copyright & A K-C
Mario Lanza Show
Il 26 giugno 1951 firma un contratto con la Coca Cola per interpretare
uno spettacolo televisivo con cadenza settimanale, Il Mario Lanza Show, di
cui vengono realizzate 59 puntate, trasmesse dalle reti CBC ed NBC.
In questo show Lanza, oltre ad ospitare personaggi famosi, mostra al
suo pubblico talmente entusiasta da non permettere l'effettuazione di riprese
in diretta e da costringere la produzione a mandare in onda le puntate in
differita di essere in grado di interpretare canzoni di tutti i generi, da brani di
Verdi alle canzoni popolari, da Cole Porter ai canti religiosi.
Il mondo della lirica sembra non voler rinunciare al talento di Lanza e
gli propone alcune esibizioni: la Scala di Milano lo vuole per il Rigoletto,
mentre il Teatro San Carlo di Napoli gli d l'opportunit di interpretare
un'opera a sua scelta. Lanza sceglie I pagliacci ma il destino non gli
concede di coronare il suo sogno: gi reduce da un attacco cardiaco alcuni
mesi prima, il cantante viene infatti ricoverato d'urgenza per un malore presso
la clinica romana Valle Giulia, dove muore il 7 ottobre 1959 per un'embolia
polmonare.
_______________________________________________________________
1
CBC (Canadian Broadcasting Corporation) - .
2
NBC (National Broadcasting Company)
, 1926 .
3
Cole Porter XX .
Giuseppe di Stefano
Giuseppe Di Stefano ebbe celebre tenore italiano. Ha studiato a Milano.
Esord nella "Manon" di Massenet. II successo lo condusse subito nei
maggiori teatri. Possedeva una voce chiara di magnifico smalto che gli
assicur una rapida carriera e popolarit internazionale.
Di Stefano cant con successo nelle opere di Verdi, Bellini, Donizetti.
Nella parte di Edgar ("Lucia di Lammermoor"), secondo i critici musicali, egli
era un degno erede del grande Rubini. Nel suo repertorio c'erano quasi
cinquanta parti. Negli anni 50 Di Stefano si esib spesso alla Scala nelle sue
61
Copyright & A K-C
parti migliori: duca nel "Rigoletto", Edgar nella "Lucia di Lammermoor",
Cavaradossi nella "Tosca", Lenskij nell'"Eugenio Oneghin", Nemorino
nell'"Elisir d'amore", don Alvaro nella "Forza del destino", Rodolfo nella
"Boheme", Werther ecc. Di Stefano e stato fra i primi e pi versatili tenori del
nostro tempo, e la sua popolarit era larghissima; il pubblico e la critica lo
chiamarono "il primo tenore dell'Italia".
G. Di Stefano cominci a cantare anche le parti drammatiche. Nel 1955
si esib nella parte di Jose ("Carmen"), pi tardi Radames ("Aida") e fra un
anno nella parte di Riccardo ("Un ballo in maschera"). Per l'esecuzione delle
parti del tenore drammatico influi negativamente sulla sua voce che cominci
a offuscarsi e perdere 1'elasticit.
Lauri-Volpi cos descrive la voce di questo cantante: "... II siciliano Di
Stefano incominci baldamente con i "Pescatori di perle" all'Opera di Roma, a
far parlare di s. Cantava allora con naturalezza, semplicit, buon gusto e
disciplina. Mi par d'udire ancora, nel tono originale e con uguaglianza di
gamma. Alla distanza di poco pi di un lustro, dedicatosi alla "Tosca" e alla
"Gioconda", ha cambiato tecnica; e l'abuso di suoni acuti, verticali, tra faringe
e polmoni, minaccerebbbe un precoce dissolvimento).
Franco Corelli
(Ancona, 8 aprile 1921 Milano, 29 ottobre 2003) stato un tenore
italiano di fama internazionale; cant nei maggiori teatri di tutto il mondo.
Dapprima incerto sulla scelta di tentare una carriera professionale nella
lirica, consegu il diploma di geometra, e nellimmediato dopoguerra si
impieg per alcuni anni presso lufficio tecnico del comune di Ancona,
proseguendo sporadicamente gli studi di canto.
Dotato di una voce tenorile di rara estensione, nel 1950 fu ammesso a
un corso di perfezionamento presso il Teatro Comunale di Firenze, e lanno
successivo vinse il concorso del Centro Lirico Sperimentale di Spoleto,
debuttando il 26 agosto 1951 nella Carmen di Bizet nel ruolo di Don Jos.
Nel 1954 ci fu lesordio alla Scala di Milano.
Al Teatro Metropolitan di New York, debutt il 27 gennaio 1961 nel
ruolo di Manrico ne Il trovatore di Giuseppe Verdi. Quel debutto fu linizio
della sua grande carriera americana. Linizio duna carriera tanto prestigiosa
62
Copyright & A K-C
non interruppe gli studi di perfezionamento vocale, condotti sotto la guida
dellamico tenore G.L.Volpi.
Al Metropolitan rimase per sedici stagioni consecutive, dal 1961 al
1975, cant tutte le opere del grande repertorio verdiano, pucciniano e verista,
e due importanti opere del repertorio francese: Romo et Juliette e
Werther ).
La sua ultima recita fu una Bohme di Puccini a Torre del Lago, il 13
agosto 1976 a soli 55 anni.
Laddio al canto avvenne nel novembre del 1981 a Stoccolma in
occasione di un concerto.
Corelli cant con molti fra i pi grandi direttori dorchestra del suo
tempo. Herbert Von Karajan lo volle nel 1962 a Salisburgo per interpretare
Il trovatore nel ruolo di
Manrico. Tenore dotato di un innegabile fascino e presenza scenica
venne pi volte invitato a partecipare a lungometraggi su opere (fra cui, negli
anni sessanta e settanta, anche ad alcune grandi realizzazioni della RAI
filmate sia in studio che in diretta a teatro).
Centro Lirico Sperimentale di Spoleto . ().
Herbert Von Karajan ,
XX .
2
Luciano Pavarotti
(1935)
Celebre tenore italiano nato il 12 ottobre a Modena. Egli esord nel
1961 a Reggio Emilia, interpetando l'opera, con la quale pi tardi avrebbe
avuto grandissimo successo nei maggiori teatri del mondo: "La Boheme",
messa in scena da Mafalda Favero.
Pavarotti si fece subito notare, la sua voce a quel tempo si imponeva per
la bellezza del colore e per la nettezza dell'emissione. Solo pi tardi il cantante
raggiunse la raffinatezza di stile e l'ammirevole esecuzione delle opere
dell'Ottocento che costi-tuiscono oggi la fama internazionale di questo tenore.
Includere nel proprio repertorio opere come "I Puritani", "La figlia del
63
Copyright & A K-C
reggimento", "La favorita" ed "I Capuleti e I Montecchi" e il segno di una
maturazione tecnica e stilistica. La sicurezza del registro acuto di Pavarotti, la
facilit, con la quale egli raggiunge (senza diminuzione di volume) le vette del
do e del re bemolle, la tecnica, con la quale egli esegue gli abbellimenti,
tutto ci gli permette di cantare il repertorio ottocentesco. Allo stesso modo, la
calda bellezza del timbro, la rotondit dei centri, la chiarezza del fraseggio
consentono al tenore di eseguire con successo il repertorio verista. Arnoldo e
Rodolfo, Manrico e Enzo Grimaldo, Fernando e Federico non creano mai
equivoci interpretativi o stilistici. Angelo Sguerzi, autore del libro "Le stirpi
canore", dice: "Credo che non ci sia amatore della lirica che non conosca il
nome di Luciano Pavarotti, perch il tenore emiliano e davvero uno dei
protagonisti delle nostre scene melodrammatiche e non solo delle nostre....
Si tratta infatti della voce tenorile (tenore lirico per la precisione) pi
argentina, pi omogenea e pi estesa, apparsa negli ultimi anni; una voce che
si espande libera nelle sale dei teatri, ed una voce ricca di calore e colore
melodrammatico che costituiscono uno dei vanti del canto italiano.
La ricchezza timbrica gli consente di cantare sia nel genere del tenore di
grazia che in quello del lirico spinto".
Un successo trionfale era Pavarotti nella parte di Enzo Grimaldo
nell'opera "La Gioconda" di Ponchielli, eseguita all'inaugurazione della
stagione all'Arena di Verona. Nel 1980 "L'Unita" scriveva: "La Gioconda"
all'Arena Luciano Pavarotti. L'opera, s'intende. Perch la Gioconda e anche
qui una bella ragazza. Ma per il pubblico c'era lui al centro dello spettacolo: il
Luciano nazionale, il divino, capace di bissare "Cielo e mar" come nessun
altro".
1
M. Favero- , , .
Carlo Bergonzi
(1924)
conosciuto dagli amatori di lirica come tenore verdiano, tanto egli
svolse la sua attivit in questo campo. Studi al conservatorio di Parma, esord
a Lecce nel 1948 quale baritono nelle vesti di Figaro nel "Barbiere di Siviglia"
64
Copyright & A K-C
di G. Rossini. Dopo aver cantato sempre come baritono, in altri teatri, passo
nel 1951 al registro di tenore, eseguendo l'Andrea Chenier di Giordano. Cosi,
da Figaro seppe diventare Riccardo, Alfredo, Don Alvaro, e persino Radames,
Manrico, Ernani. Cant anche il repertorio verista e pucciniano ("Pagliacci",
"Cavalleria rusticana", "Manon", "Boheme", "Tosca"), di Donizetti: "Lucia di
Lammermoor" e perfino l'"Elisir d'amore", dove si esib nel ruolo del tenore
lirico leggero.
C. Bergonzi un ottimo esecutore, possiede la tecnica perfetta, la
dizione eccellente ed dotato di una musicalit istintiva e di una sensibilit
interpretativa che lo porta quasi sempre al giusto accento e all'espressione
convincente specialmente nel repertorio verdiano. Lauri-Volpi dice che la
voce di Carlo Bergonzi ha per centro di gravit il settore medio della gamma,
con note pastose e cordiali, ch'egli riesce,. in modo sorprendente, ad
amalgamare con il registro acuto. Il che gli permette di affrontare il repertorio
verdiano con risultati ammirevoli.
II suo stile, nelle legature, e nei portamenti, si rifa alle tradizioni
belcantistiche; e, forse, l'unico tenore, capace di cantare "Un ballo in
maschera", attenendosi a tutte le indicazioni della partitura di Giuseppe Verdi
in materia di smorzature, filature e rinforzamenti.
Mario del Monaco
Nacque da distinta famiglia, padre napoletano e madre fiorentina.
Dopo aver studiato violino inizialmente come autodidatta, si rese conto che
la sua reale passione era il canto. Successivamente fu allievo della scuola di
perfezionamento, dove per il metodo di insegnamento inadatto alle sue
caratteristiche vocali gli procur problemi, che il suo precedente maestro
contribu in seguito a risolvere.
Appassionato di pittura e scultura, si diplom anche alla Scuola d'Arte
della stessa citt di Pesaro. Spos Rina Fedora Filippini, conosciuta alla
scuola del Teatro dell'Opera di Roma, nel 1941.
La sua carriera ebbe inizio nel 1939. Il primo successo risale al 31
dicembre 1940 al Teatro Puccini di Milano. Dopo un periodo di attivit
irregolare a causa della guerra, la sua carriera decoll dal 1945 in poi. Il
65
Copyright & A K-C
debutto internazionale avvenne nel 1946 a Londra. La vera svolta della sua
carriera avvenne nel 1950, il debutto nel ruolo del protagonista nellOtello
di Verdi. Da qui in poi gli si aprirono le porte dei teatri pi prestigiosi del
mondo, in spettacoli passati alla storia dell'opera, collaborando con i pi
grandi artisti della sua epoca. Fu il primo cantante italiano nel dopoguerra ad
esibirsi al Teatro Bol'oj di Mosca, dove il fanatismo suscitato dalle sue
interpretazioni di Carmen e Pagliacci indusse le autorit sovietiche a
conferirgli l'Ordine di Lenin, massima onorificenza dello Stato.
Nel 1964, un grave incidente automobilistico lo costrinse ad
interrompere la sua attivit, che riprese comunque entro la fine di quell'anno,
per proseguire poi fino agli anni Settanta.
Lasci le scene nel 1975 con alcune recite di Pagliacci . Ritiratosi
nella sua villa si dedic all'insegnamento fino alla morte, avvenuta per un
infarto conseguente ad un lungo periodo di dialisi renale.
Voce e stile di canto
Dotato di voce scura ed estremamente potente, da tenore drammatico
(con inflessioni quasi baritonali), ma con una grande padronanza anche del
registro superiore. Voce estremamente dotata per volume, colore ed
estensione, ha saputo mantenersi nel complesso abbastanza integra sino a
tarda et malgrado una tecnica assolutamente "personale" ed apparentemente
approssimativa ed un uso smodato della voce.
Interpret in almeno 218 recite l'Otello verdiano (alcune fonti
indicano ben 427 recite). Nel ruolo del Moro di Venezia, Del Monaco
stato uno dei maggiori interpreti del XX secolo. La sua voce tratteggia un
Otello scuro e violento, ricco di una drammaticit impetuosa che prende
letteralmente alla gola.
Del Monaco fu sepolto nei panni di Otello, col costume da lui stesso
disegnato.
L'attivit artistica di Del Monaco vede un erede nel figlio Giancarlo
Del Monaco, affermato regista teatrale e anche nella nipote, la cantante
Donella Del Monaco.
Mario Del Monaco si spesso dedicato alla musica leggera: il suo
successo pi grande stato, nel 1976, Un amore cos grande , brano
66
Copyright & A K-C
scritto da Guido Maria Ferilli, ed in seguito inciso anche da moltissimi altri
artisti, tra cui Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli.
1
Guido Maria Ferilli XX ,
, . , . ,
. .
Andrea Bocelli
E senza dubbio la voce italiana pi amata del momento, sopratutto a
livello internazionale dove la gente fa a gara per comprare i suoi dischi e dove
tutti apprezzato, i prodotti veramente e genuimente italiano.
Nato il 22 settembre 1958 a Lajatico nella campagna toscana. A sei anni
gi prendeva gli studi del pianoforte su cui le sue piccole mani. Non
contento, si mette anche a suonare flauto e sassofono, alla ricerca di
un'espressione sempre pi profonda della musica. Finito il liceo, si iscrive a
giurisprudenza all'Universit di Pisa dove si laurea, sempre attento per a non
dimenticare gli studi di canto. Poi cominci prendere lezioni da un mostro
sacro del Novecento, quel Franco Corelli che l'idolo tenorile di molti amanti
dell'Opera. Tuttavia vivere di musica al giorno d'oggi quasi impossibile e
Bocelli non disdegna di cimentarsi talvolta anche nel pi prosaico piano-bar.
E' in questo periodo che incontra Enrica, che diventer sua moglie e che gli
dar due figli: Amos e Matteo.
Tornando alla musica, l'inizio "ufficiale" della sua carriera di cantante
casuale. Si fa avanti per un'audizione che il gi celebre Zucchero tiene nel
1992 per realizzare un provino di "Miserere", pensata per Luciano Pavarotti e
da realizzare proprio con il fantastico tenore modenese. E qui accade il "coup
de teatre". Pavarotti, infatti, ascoltando la registrazione, commenter: "Grazie
per la splendida canzone, ma lascia che sia Andrea a cantarla. Nessuno pi
adatto di lui."
Luciano Pavarotti, com' noto, in seguito registrer comunque la
canzone, ma nella tourne europea di Zucchero, sar proprio Andrea Bocelli a
sostituirlo sul palco.
67
Copyright & A K-C
Nel 1994 dunque invitato a partecipare al Festival di Sanremo dov
ant la canzone "Il mare calmo della sera". Il suo primo album (che porta il
titolo della canzone) ebbe un gran sucesso: in poche settimane ottiene il primo
disco di platino. A Sanremo l'anno successivo interpret "Con te partir", che
viene inserita nell'album "Bocelli" e che in Italia ottiene un doppio disco di
platino.
Nello stesso anno, ha participato nella tourne europea alla quale
partecipano i cantanti celebri. Il successo planetario immediato.
In Francia il singolo rimarr in testa alle classifiche per sei settimane,
registr tre dische doro; in Belgio sar numero uno per 12 settimane: il pi
grande sucesso di tutti tempi. Sar tuttuvia lalbum successo Romanza a
raggiungere nel 1996 un successo internazionale. Solo dopo poche settimane,
il CD era gi disco di platino in quasi tutti i paesi nei quali era uscito, e la
stampa internazionale riconosceva al tenore toscano una popolarit degna di
Enrico Caruso.
Ma sulla spinta del fenomeno montante gi nel 1995 Bocelli aveva
offerto il suo tributo alla tradizione del tenore italiano, pubblicando il CD
"Viaggio Italiano", ispirato agli emigranti e agli artisti che hanno reso
popolare l'opera italiana nel mondo. Cos nel 1998, con il debutto
internazionale del disco classico "Aria", si ritrover a dominare le classifiche
di musica classica.
Intanto, parallelamente alle tourne, fioccano ormai anche proposte per
l'interpretazione di opere liriche, un'aspirazione coltivata fin da bambino e che
finalmente il tenore riuscito a realizzare.
Uno dei suoi pi bei lavori proprio l'incisione della temibile "Tosca"
di Giacomo Puccini, un capolavoro che il timido cantante toscano sa rendere
con classe e gusto del fraseggio sopraffini.
Baritoni
L'inizio del Novecento e stato contrassegnato dall'apparizione delle
eccellenti voci baritonali quail Titta Ruffo con moltissime capacit, Giuseppe
de Luca, con grande talento d'attore, Riccardo Stracciari con timbro pastoso e
bellissimi acuti, Carlo Galeffi con voce potente e sonora. Pi tardi apparvero i
baritoni Sesto Bruscantini, Gino Becchi e Tito Gobbi, un baritono unico, e
altri.
68
Copyright & A K-C
Carlo Galeffi
Carlo Galeffi (18821961) ha cantato alla Scala 18 stagioni con 32
opere e pi di 500 recite. Galeffi nato nel 1882. Egli esord nel 1903 a 19
anni al teatro Quirinale di Roma con la "Lucia di Lamermoor" di Donizetti,
cant in provincia fino al 1908, e cominci ad affermarsi nei grandi teatri tra il
1909 e 1910. Carlo Galeffi matur quindi in un periodo, un cui la scuola
vocale italiana era ormai dominate dal gusto verista. Dovrebbe essere appunto
questo periodo, in cui Titta Ruffo, riferendosi a Galeffi, avrebbe pronunciato
la frase: "Quel ragazzo mi fa paura". Nella carriera di Galeffi possiamo
distinguere due diversi periodi.
Il primo, che parte dall'esordio e giunge all'inizio degli anni venti,
coincide con una potenza vocale che pu essere definita come eccezionale; il
secondo periodo dagli anni trenta fino alla fine della sua carriera. Nel 1913,
quando s'apr la stagione d'autunno della Scala, dedicate interamente a Verdi,
Galeffi fu protagonista del "Nabucco" e "Amonasro"; la stampa milanese fu
larga di riferimenti al suo vigore vocale e lo defini "una delle voci pi potenti
e sonore sulle nostre scene". Poi Galeffi con enorme successo cant Rigoletto,
Simon Boccanegra, Jago, Germont, Di Luna, ecc. e divenne "un baritono
verdiano di livello storico".
Nella sua lunghissima carriera, durata quasi mezzo secolo, Carlo Galeffi
interpret una sessantina di ruoli con ricchezza di accenti drammatici, chiara
dizione e grande morbidezza di voce.
Sesto Bruscantini, baritono e basso comico italiano, nacque a Porto
Civitanova il 10 dicembre 1919. Egli ha studiato canto a Roma e per un anno
alla scuola del Teatro dell'Opera. Nel 1947 ha vinto un concorso della RAI1 e
nel 1949 ha esordito in teatro come Don Geronimo nel "Matrimonio segreto"
di Cimarosa alla Scala di Milano.
Fra le sue migliori interpretazioni sono: "Cosi fan tutte" di Mozart (Don
Alfonso e Guglielmo), "La Cenerentola" di Rossini, "Il Barbiere di Siviglia" di
Rossini e di Paisiello, "Don Pasquale" di Donizetti, "Don Giovanni" di Mozart
(Leporello e Masetto), ecc. Nonostante che era voce poco timbrata, e diventato
per la sua musicalit non comune, la dizione chiara e brillante, il senso del
69
Copyright & A K-C
teatro comico (nella migliore tradizione italiana), un raffinato specialista nell
'opera buffa, assai ricercato in campo internazionale.
Si affermato soprattutto nei ruoli comici e brillanti con eccellenti doti
di attore.
Gino Becchi
famoso baritono italiano, nato a Firenze nel 1913. A 17 anni cominci
a studiare il canto con Raul Frazzi, fu poi alla scuola di perfezionamento di
Alessandria. Esord nella "Traviata".Nell'estate di 1939 si afferm
decisamente a Roma, alle Terme di Caracalla in "I Pagliacci" di Leoncavallo
e "Aida" di Verdi. Il successo gli schiuse, a partire dal 194041, le porte della
Scala, dove, specie in "Un ballo in maschera" di Verdi e nel "Barbiere di
Siviglia" di Rossini, mostr un complesso di qualit eccezionali, e subito
passo agevolente dalla "Zaza" al1' "Ernani", dalla "Forza del destino" al
"Rigoletto". Il giovane Becchi aveva la voce di vibrante metallo, gli acuti
(specie tra il fa e il la bemolle) di rara potenza e fermezza, la figura
prestigiosa; stato uno dei pi popolari cantanti nel dopoguerra, il suo
successo era enorm.
Tito Gobbi
Tito Gobbi (Bassano del Grappa, 24 ottobre 1913 Roma 5 marzo
1984) stato un celebre baritono italiano, fra i pi famosi del suo tempo.
Notevole per il sottile modo in cui ha agito con la sua voce e l'incisivit
dell'accento, si dedicato intensamente alla sua formazione musicale, ebbe la
sua tecnica vocale e il bagaglio culturale richiesti per una carriera lirica
internazionale. Famoso non solo per essere stato un cantante, ma anche attore,
regista,designatore, insegnante e costumista.
Il giovane Tito studi giurisprudenza all'Universit di Padova. Durante
lo studio, il suo talento viene scoperto da un amico di famiglia, appassionato
musicista, che, gli ha sentito cantare una canzone, gli disse che aveva una
bella voce di baritono e cos gli sugger di studiare canto lirico. E cos, nel
1932, si trasfer a Roma per studiare cantare con celebre tenore italiano di
questa et.
70
Copyright & A K-C
Ad accompagnarlo al pianoforte alla prima audizione fu Tilde de Rensis
che nel 1937 divenne sua moglie. Dal matrimonio nacque un'unica figlia,
Cecilia, che si occupa dell'"Associazione Tito Gobbi", un sito per onorare la
memoria del grande baritono scomparso.
La prima esperienza per Tito Gobbi su un palcoscenico fu nel 1935, ha
interpretato il Conte Rodolfo in La sonnambula di Vincenzo Bellini.
Successivamente vinse il Concorso Internazionale di Canto a Vienna, a cui
segu il primo dei suoi 26 film, e una borsa di studio al Teatro alla Scala di
Milano.
Nel 1937 debutt a Roma. Prepar molti ruoli, fra cui alcuni furono stati
fondamentali per la sua carriera, come Scarpia (Tosca). Nel 1942, sempre alla
Scala, fu protagonista della prima italiana del Wozzeck di Alban Berg (nel
ruolo del titolo), uno dei suoi capolavori, che in seguito canter ancora a
Napoli e a Vienna, alla Scala; la sua ultima recita di Wozzeck sar registrata
per la Radio Italiana a Roma nel 1954.
Fra qualchi anni, il suo repertorio cominci a diventare molto vasto,
fino ebbe 110 ruoli in 136 opere liriche di epoche diverse, da Claudio
Monteverdi ai contemporanei, poi anche i personaggi di Verdi e dei
compositori veristi (i suoi cavalli di battaglia), sia in teatri italiani sia in quelli
esteri. Nel 1947 torner alla Scala per cantare La dannazione di Faust di
Hector Berlioz in lingua italiana. Sempre nello stesso anno, con Rigoletto a
Stoccolma cominci la grande carriera internazionale, che lo port in tutto il
mondo.Cant molte recite di Tosca , due in studio e molte dal vivo.La sua
voce divenne, verso gli anni '50, pi sicura e potente.
Il suo repertorio comprendeva anche la musica barocca, e canzoni
napoletane. Cant poi musica del classicismo. Si present al Teatro dell'Opera
di Roma per cantare i suoi ruoli celebri. Da giovane, Tito Gobbi, fu anche
Figaro in Le nozze di Figaro
Ma il ruolo da lui pi frequentato stato quello del Barone Scarpia
(circa 900 recite) nella Tosca di Giacomo Puccini.
Ma oltre che Scarpia, fu molto acclamato dal pubblico come Rigoletto
nel Rigoletto di Verdi (pi di 400 recite). Poich, fin da ragazzo, fu
appassionato di quest'opera, ma il vero debutto da protagonista fu a Pisa nel
1945, dove ottenne un grandissimo successo.
71
Copyright & A K-C
Un altro ruolo che lo ha reso famoso Jago nell'Otello di Verdi (circa
500 recite). Questi tre ruoli furono i pi grandi cavalli di battaglia di Tito
Gobbi, e di essi fu considerato da molti il massimo interprete-cantante.
Tito Gobbi stato apprezzato e amato in tutto il mondo: una
straordinaria personalit di interprete gli faceva mette sempre la voce al
servizio della musica e del teatro, lo rend uno dei pi famosi e grandi baritoni
della storia dell'opera, vero "cantante-attore" come Verdi comanda. Egli
lavor duramente per avere il successo che poi ottenne dalla maggior parte del
pubblico mondiale, e continu a lungo la sua carriera (come pochi).
Come tutti i grandi cantanti ha suscitato lodi, entusiasmi, simpatie e
critiche, non solo dalla maggior parte del pubblico italiano, ma anche (e
soprattutto) dal pubblico di Chicago e di Londra, dove ricordato come il pi
grande interpretante di Scarpia della storia. Il suo canto duttile cercava sempre
il "colore" o, meglio, la gamma di colori propri di quel personaggio: niente era
mai lasciato al caso, le sue interpretazioni si adattavano all'insieme e si
evolvevano con la sua maturazione umana e culturale. Tutto questo spiega la
rara abilit nel dare vita a personaggi brillanti, cos come drammatici, nel bene
e nel male: da Figaro a Jago, da Scarpia a Simone, ecc.
Il suo ultimo ruolo in teatro stato il Narratore in Le Villi di Puccini
nel 1979, (incisione che ha vinto il Grammy Award). Il suo ultimo debutto in
quanto alla regia stato di Ernani, a Napoli nel 1982. Scrisse anche due
libri: My life (1979) ("La mia vita", 1985) e Tito Gobbi La sua vita nella
opera italiana (1984). Fra i suoi hobby, il disegno e la pittura, coi soggetti e le
tecniche pi vari: unendo questa abilit a un fine senso dell'umorismo, faceva
anche divertenti caricature; amava la cucina, le automobili e gli animali: fra i
suoi "animaletti da compagnia" ci fu anche un leone.
Terme di Caracalla ( 235 . . .),
, .
2
Alan Berg XX , .
3
Grammy Award
( ).
72
Copyright & A K-C
LARTE LIRICA SOVIETICHA E RUSSA
Fedor Ivanovic Saljapin
(18731938)
Fedor Ivanovic Saljapin fu un grande artista lirico e la pi potente voce
di basso. Nessun cantante del suo tempo seppe come lui entrare nello spirito
del personaggio che interpretava, perch nessuno lo studi con maggiore
penetrazione e maggiore tenacia.Saljapin nacque il primo febbraio 1873 a
Kazan nella famiglia di un piccolo impiegato (uno scrivano). Gi da bambino
Fedor ebbe una bellissima voce bianca, amava ascoltare le canzoni popolari
russe, cantava spesso con la madre. Studiava diversi mestieri e fu apprendista
calzolaio,legatore dei libri, tornitore, ecc.
A dodici anni si appassiono al teatro e fu comparsa nella compagnia
operistica che era in tourne a Kazan'. Nel 1890, a diciassette anni, senza un
regolare studio vocale, divenne corista nella compagnia di Semenov-Samarskij
a Ufa. Nel dicembre dello stesso anno esord nella parte di Stol' nik nell'opera
"Halka" di Moniuszko. Dal 1891 gir con la compagnia teatrale ucraina per le
citt della Russia. Nel 1829 giunse a Tbilisi, dove ebbe per un tempo a
maestro di canto D. A. Usatov, cantante lirico. Proprio in quella citt cominci
la sua carriera operistica. F. Saljapin fu scritturato al teatro lirico statale di
Tbilisi, e il 28 settembre 1893 vi esord nella parte di Ramfis nell' "Aida" di
Verdi.
Durante la stagione del 189318994 vi cant le parti di Mefistofele
"(Faust" di Gounod), mugnaio ("Undina" di Dargomyzskij), Gremin
("Eugenio Oneghin" di Cajkovskij), Tonio ("I pagliacci" di Leoncavallo) e
altre.
Nel 1895 F. Saljapin esord nel Teatro lirico Mariinskij a Pietroburgo
nelle vesti di Mefistofele. Ma il successo pi grande venne nel 1896, quando si
esib al teatro lirico privato di S. G. Mamontov a Mosca, dove cant tre anni e
creo delle immagini salienti nelle opere russe.
L'atmosfera del Teatro lirico di Mamontov favoriva lo sviluppo del
talento di Saljapin. In quel teatro vi lavoravano i pittori Polenov, Vasnecov,
Vrubel', Korovin e il giovane S. V. Rachmaninov vi cominciava a svolgere
l'attivita di direttore d'orchestra.
73
Copyright & A K-C
F. Saljapin prepar con S. Rachmaninov alcune parti, fra le quali Boris
Godunov e Mefistofele (dal "Mefistofele" di A. Boito).
Studiando la parte del Boris dal punto di vista musicale, egli volle
conoscerne i caratteri storici. Aveva letto Puskin e Karamzin, ma non gli
bastava. Per mezzo di amici fece la conoscenza di V.I.Klucevski, uno dei pi
grandi storici russi che abitava a Jaroslavl e lo preg di parlargli di Boris
Godunov.
Entusiasta del Boris Godunov, Saljapin non si ferm allo studio della
sua parte, ma impar tutta lopera dal principio alla fine. Si accorse, poi,
quanto fosse utile la conoscenza delle opera per interno. Osserv anche che
quasi nessuna parte gli si rivelava tutta da principio.
Nella stessa parte Saljapin esord al Teatro Boloj con sucesse enorme
il 24 settembre 1899 e nel 1901 alla Scala di Milano si esib trionfalmente
pure nella parte di Mefistifele a fianco di Caruso (Faust). Le tournes
successive di Saljapin a Roma, Berlino, Parigi, Londra ecc. negli anni 1904
1914, affermarano la fama mondiale del cantante russo.
Saljapin fu il cantante pi popolare del tempo, celebre esponente della
scuola vocale russa; possedeva una bellissima voce di basso cantante, con una
estensione enorme, da una straordinaria flessibilit, intensit despressione e
bellezza di timbro.Alla potenza eccenzionale della sue voce di estensione
insolita Saljapin univa grandi doti sceniche, la sua capacit di immedesimarsi
con il personaggio. Diceva del suo lavoro al teatro: Ho vissuto im molteplici
vite. Sono morto pi volte sulla scena risorgere sempre in nuovi personaggi.
F. Saljapin aveva nel suo repertorio quasi 70 parti. Le immagini create
da Saljapin sono impareggiabili per la loro verit storica e artistica. Fra la sue
interpretazioni migliori sono: il leggendario Boris Godunov e Ivan il Terribile,
Salieri, Demonio, Mefistofele, Don Basilio, Don Quichote, Leporello, Filippo
II e altri, ma la le creazioni pi famose erano; imaggino di Boris Godunov e
di Mefistofele.
Leonid Vital'evic Sobinov
(18721934)
L'arte di canto di Leonid Sobinov, come quella di Fedor Saljapin era
legata strettamente all'arte drammatica: Sobinov diede una nuova
74
Copyright & A K-C
interpretazione di molte opere classiche. L'immagine di Lenskij, creata da Sobinov, divent un modello clasico per i giovani cantanti russi.
Leonid Vital'evic Sobinov nacque nel 1872 a Jaroslavl', nella famiglia di
un commesso. Nella sua famiglia cantavano tutti: nonno, padre, fratello
minore e fratello maggiore. L. Sobinov si appassionava al canto fino
dall'infanzia, la sua voce suscitava rammirazione di tutti. Nel 1890 Sobinov si
iscrisse alla facolt di giurisprudenza nell'Universit di Mosca. Studiando
all'Universita, cantava anche nel coro degli studenti. Quando faceva il terzo
anno di studi, fu ammesso nel Liceo musicale e drammatico della Societa
Filarmonica di Mosca, dove studio canto.
Si laure in legge nel 1894 e l'anno seguente cominci a lavorare, fece
l'avvocato fino al 1898. Terminati gli studi al Liceo Filarmonico di Mosca nel
1897, esord sul palcoscenico del Teatro Bolsoj nella parte di Sinodal dall
'opera "Demon" di Rubinstein con successo trionfale.
Dalle prime stagioni L. Sobinov cant al Bolsoj le parti principali dal
repertorio di tenore lirico, fra cui Lenskij, Faust (opera omonima di Gounod),
duca ("Rigoletto" di Verdi), Nadir ("Cacciatori delle perle" di Bizet),
"Werther" (opera omonima di Massenet), Romeo ("Romeo e Giulietta" di
Gounod), Vladimir Igorevic ("Il principe Igor" di Borodin), Alfredo ("La
Traviata" di Verdi), ecc. Le esibizioni di L. Sobinov nei pi importanti teatri
d'Europa (19041911) gli portarono la fama mondiale. Nel 19041906 cant
con trionfo alla Scala le parti di Ernesto, Alfredo, Fra Diavolo e Des Grieux. I
critici italiani ammiravano la bellissima voce di Sobinov, la sua tecnica, la sua
perfetta pronuncia italiana. Il debutto alla Scala avvenne il 21 dicembre 1904
nella parte di Ernesto nel "Don Pasquale" di Donizetti. Il "Corriere della sera"
ne scriveva il 22.XII.1904: "... Eccellente il tenore Sobinoff che cantava ieri
sera per la prima volta in un teatro italiano. un bel giovane assai colto che
canta con una grazia, una dolcezza e una facilita che gli cattivarono fin dalla
prima sua scena tutto il favore del pubblico. La sua voce di un timbro
purissimo, uguale ed insinuante: una voce rara e preziosa e che egli modula e
governa con arte perfetta, con intelligenza e con gusto". La comparsa di L.
Sobinov alla Scala nella parte di Alfredo nella "Traviata" venne cos descritta
nella "Rassegna melodrammatica lirica" il 31 gennaio 1906: "Il Sobinoff
esegu la parte di Alfredo, tenore elegante, cantante squisitissimo... Egli ebbe
un successo sincero, spontaneo fin dal primo atto... Alla maga del canto, alla
75
Copyright & A K-C
maestra di attore, Sobinoff unisce il dono naturale di una figura splendida.
Dopo la Rivoluzione d'Ottobre 1917 oltre alle esibizioni negli spettacoli al
Teatro Bolsoj, L. V. Sobinov svolse una grande attivit pubblica. Negli anni
19171918 e nel 1921 fu eletto dalla compagna del Teatro il primo direttore
del Bolsoj, nel periodo complesso L. Sobinov rimase in carica, cercando di
consolidare lo spirito creativo e la disciplina della compagna. Il suo lavoro fu
apprezzato altamente da A. V. Lunacarskij. (Nei 1923 a L. Sobinov fu
conferito il titolo di artista del popolo della R.S.F.STR. Pi tardi L. V. Sobinov
fu direttore artistico dello Studio d'opera di K. S. Stanislavskij (1934),
consultando la messa in scena delle opere "Don Pasquale" e "Carmen".
Si spense a Mosca nel 1934. Il Conservatorio di Saratov e il liceo
musicale di Jaroslavl' portano il suo nome. L. V. Sobinov fu il pi grande
rappresentante della scuola vocale classica russa. Una voce incantevole, dal
timbro brillante, inconfondibile, musicalit e grandi doti sceniche, grazia e
figura attraente, tutto si univa armonicamente in questo cantante. Uomo di
grande cultura, L. V. Sobinov cantava di solito in lingua del pease, dove si
esibiva. Parlava benissimo italiano, studiava il tedesco e l'ucraino. Interpretava
in una maniera innovatrice molte parti, fra le quali in primo luogo quella di
Lenskij, cui Sobinov confer un grande fascino della poesia puskiniana. L. V.
Sobinov fu anche un famoso interprete delle romanze di M. Glinka, P.
Cajkovskij, S. Rachmaninov.
Elena Obrastzova
In Italia hanno notato il suo timbro appassionato e la sua tecnica
eccezionale. In Spagna hanno scritto che nella sua interpretazione il
personaggio operistico incomincia a vibrare di vita propria, affascinando il
partner e il pubblico.
Elena Obrastzova, premio Lenin, artista del popolo dell'URSS, e una
delle cantanti dal pi brillante ingegno dei nostri tempi. Per definire le cause
del successo che ha accompagnato ogni sua apparizione sul palcoscenico, si
pu trovare tre parole: talento, professionalit, lavoro. Il talento si manifest
molto presto. I suoi genitori non erano musicisti di professione (intellettuali di
professione tecnica), pero il padre suonava il violino e cantava. Elena
cominci a cantare dall'infanzia e fu ammessa al Conservatorio di Leningrado.
76
Copyright & A K-C
Il primo successo venne prestissimo: al terzo anno di Conservatorio nel
1962 vinse la medaglia d'oro al concorso internazionale di canto a Helsinki.
Lo stesso anno Elena ricevette la sua seconda medaglia d'oro al concorso
nazionale "Glinka". Nel settembre del 1963 Obrastzova fu invitata per una
audizione al Bolscioj. La sala si riempi di pubblico: solisti del teatro, direttori
d'orchestra e registi, coristi, musicisti erano venuti per ascoltare la studentessa
di Leningrado. Elena scelse una scena dell'"Aida" (la parte di Amneris).
Attacco, e nell'aria risuono una voce di rara bellezza. Per trasmettere le
sfumature del personaggio verdiano, Elena non ricorse a nessun effetto
scenico, affidandosi interamente all'intonazione, al timbro e al carattere del
suono. Quella studentessa cantava come un'artista di professione. L'audizione
fu coronata dagli applausi di tutti i presenti, compresi i professori d'orchestra,
critici pi severi. "Ammessa!" In questa parola c'era felicit, gioia, ma anche
ansia. Inizio la sua prima stagione teatrale durante il suo ultimo anno di studio.
Per sopportare la tensione delle lezioni a Leningrado e gli spettacoli a Mosca,
il solo talento non poteva bastare: ci voleva volonta e capacit di lavoro.
Dopo il Conservatorio ricevette la medaglia d'oro al Concorso
internazionale "Ciajkovskij", il Gran Prix e la medaglia d'oro al concorso di
canto a Barcellona, "la Penna d'oro" della critica per I'interpretazione della
parte di Amneris al Festival lirico internazionale a Wiesbaden (RFT) e infine
la medaglia d'oro del Premio di stato" e del Premio Lenin. La gloria non ha
cambiato la cantante che diveniva sempre piu esigente a se stessa.
La Obrastzova esegue splendidamente il repertorio lirico russo. Elena
Obrastzova si esibisce spesso negli spettacoli di teatri stranieri.
Dei suoi personaggi ella parla come di donne vere e vive. Esse vivono
nella musica e nel canto, e Obrastzova ne sa ritrovare in ogni parte lo stato
emotivo pi caratteristico. Nel repertorio di Obrastzova Carmen ha occupato
un posto speciale, la sua Carmen e sempre di versa. "A seconda degli
spettacoli, dice poi la Obrastzova, la mia eroina vive, ama e soffre in modi
diversi, perch ogni volta accanto a lei vi sono diversi Jos, Escamiglio,
Michaelle".
Ogni personaggio per Elena Obrastzova una persona viva con tutte le
passioni che la agitano.
77
Copyright & A K-C
Anna Netrebko
Anna Netrebko inizia a lavorare pulendo i pavimenti del Teatro
Mariinskij (allora Opera Kirov) di San Pietroburgo per pagarsi gli studi di
canto. La sua carriera inizi quando venne notata dal direttore Valery Gergiev,
che divenne il suo mentore. Sotto la sua guida, fece il suo debutto nel ruolo di
Susanna in Le nozze di Figaro nel 1994. La sua ascesa vera e propria inizi
l'anno successivo, quando la Compagnia del Teatro fece una tourne a San
Francisco. La sua interpretazione di Lyudmila in Ruslan e Lyudmila di
Michail Ivanovi Glinka ottenne ottime critiche.
Da allora, ha interpretato numerosi ruoli, tra cui Donna Anna nel Don
Giovanni di Mozart, Adina in L'elisir d'amore e Lucia nella Lucia di
Lammermoor di Donizetti, Gilda in Rigoletto di Verdi, e cantato nei
maggiori teatri del mondo, come il Metropolitan, la Royal Opera House
Covent Garden, l'Opra di Parigi e il Festival di Salisburgo.
La stampa e la televisione iniziano a creare l'immagine di "diva" che
mancava al mondo della lirica dai tempi di Anna Moffo. Nel 2003 la
Netrebko pubblica il suo primo album di studio Opera Arias , uno dei
maggiori successi commerciali nel settore della musica classica. Il secondo
album, Sempre libera , esce nel 2004. Data la sua avvenenza, anche il
cinema inizia a corteggiarla.
Nel 2005 interpreta Giulietta in Romeo e Giulietta di Charles Gounod
nello stesso anno, riscuote uno strepitoso successo di pubblico e di critica nel
ruolo di Violetta Valry in La traviata di Verdi al Festival di Salisburgo.
Nel 2005 ha ricevuto il Premio di Stato russo massimo riconoscimento
del paese nel campo delle arti e letteratura dal Presidente Vladimir Putin.
Nel marzo 2006 ha chiesto la cittadinanza austriaca, che le stata
concessa il 25 luglio
2006. Questo le ha attirato varie critiche dalla Russia. Nello stesso anno
uscito il terzo album della cantante, The Russian Album, in cui
accompagnata dall'orchestra del Teatro
Mariinskij diretta da Valery Gergiev: in Germania il disco entrato
nella Top 10 della classifica degli album pop pi venduti. Nel marzo 2007
uscito Duets , assieme a Rolando Villazn.
78
Copyright & A K-C
Sempre nel 2007, entrata a far parte della lista TIME 100 diventando
cos la prima cantante dopera in assoluto ad essere nominata tra le persone
pi influenti al mondo.
Nel 2008 ha duettato con Andrea Bocelli, nella trasmissione televisiva
della BBC dei Classical BRIT Awards (4), nella celebre aria della Traviata
Libiamo ne' lieti calici .
Nello stesso anno le stato conferito dal Presidente russo il titolo di
Artista del Popolo della Russia.
A novembre ha lanciato il suo quarto album di studio Souvenirs una
raccolta di arie d'operetta.
Dopo una pausa di cinque mesi dovuta alla nascita il 5 settembre 2008
a Vienna del suo primo figlio, Tiago Aru, avuto dal baritono uruguaiano
Erwin Schrott, la Netrebko ha ripreso, nel gennaio del 2009, a calcare i
palcoscenici pi prestigiosi del mondo trionfando al Metropolitan Opera di
New York e alla Staatsoper di Vienna nella Lucia di Lammermoor .
protagonista del film La Bohme , colossal da cinque milioni di
dollari diretto dal regista Robert Dornhelm.
La stagione 2009-2010 la vedr impegnata, oltre che in una serie di
concerti, nella Traviata alla Staatsoper di Vienna, alla San Francisco Opera
e nel suo debutto con la Opernhaus di Zurigo. Far ritorno alla Royal Opera
House a Londra per Giulietta in I Capuleti e i Montecchi accanto al
mezzosoprano Elina Garana, canter Mim ne La Bohme alla Staatsoper
di Monaco di Baviera, Adina in L'elisir d'amore all'Opra di Parigi e
Antonia in Les contes dHoffmann al Metropolitan di New York.
Impegnata fino al 2013, nessun teatro italiano in agenda, per le ragioni
che lei stessa ha esposto in un'intervista risalente al 2005: Ho cantato cinque
anni fa alla Scala in "Guerra e Pace". In Italia ci sono due problemi: mi
chiamano troppo tardi e mi offrono ruoli russi. Io sono proiettata verso il
belcanto e il repertorio francese.
Si appreso per, da dichiarazioni e rumors pi o meno recenti, che per
il 2011 previsto il suo debutto vero e proprio al Teatro alla Scala di Milano,
nella Lucia di Lammermoor .
_______________________________________________________________
1
Festival di Salisburgo
(. ).
79
Copyright & A K-C
Anna Moffo ,
.
3
Rolando Villazon ,
(, ).
4
Classical DRIT Awards
.
Evghenij Nesterenko
Evghenij Nesterenko, un basso famoso, solista del Teatro Bolscioj,
premio Lenin, artista del popolo dell'URSS, possiede una voce bellissima,
esatta per stile e espressivit, dotato di una grande musicalit. nato a Mosca
nel 1938; dall'infanzia cantava e amava molto la musica. Dopo essersi laureato
in ingegneria e diplomato nel Conservatorio di Leningrado, ha scelto la via del
canto, studiando con il maestro Vassilij Lukanin. Ancora studente, fu gi
invitato a cantare al Teatro lirico "Maly" di Leningrado nell'opera "L'amore
delle tre melarance" di Serghej Prokofiev. In quel teatro ha cantato anche le
parti di Colline ("La Boheme"), Ferrando ("Il Trovatore"), il mugnaio
("Undina"), Korabliov ("Due capitani" di Sciantyr).
Nel 1967 ricevette il premio al concorso dei giovani cantanti a Sofia e fu
invitato al Teatro d'opera e di balletto"Kirov" di Leningrado, dove in qualche
anno di lavoro esegui una ventina di parti, fra le quali Konciak ("Il principe
Igor"), Kociubei ("Mazeppa"), Gremin ("Evghenij Oneghin"), Don Basilio ("Il
barbiere di Siviglia"), Raimondo ("Lucia di Lammermoor"), Mefistofele
("Faust").
Nel 1970 Nesterenko diventa vincitore al IV Concorso internazionale
"Ciajkovskij" e solista del Teatro Bolscioj di Mosca, uno dei pi famosi
cantanti lirici in URSS e all'estero. "La sua straordinaria tecnica vocale ha
fatto di lui il migliore interprete di Musorgskij", scrive "l'Unita". Nesterenko
ha cantato nei pi grandi teatri del mondo, dal Bolscioj alla Scala, al
Metropolitan. Le sue opere predilette, in cui ha riscosso molto successo, sono
state: il "Don Carlos", il "Boris Godunov", "La Boheme", il "Mos", "Oedipus
Rex".
Nesterenko molto stimato anche come interprete di musiche da
camera; egli ha eseguito con gran successo la Suite per basso e pianoforte di
80
Copyright & A K-C
Dmitrij Sciostakovich sulle "Rime" di Michelangelo Buonarroti in URSS e in
Italia, al teatro alla Scala di Milano.
Capace di approfondire il testo poetico dei drammi musicali, Nesterenko
riesce bene a integrare nell'opera con la sua voce bellissima e profonda.
Nesterenko dedica molto tempo anche all'insegnamento del canto al
Conservatorio "Ciajkovskij" di Mosca, dove egli sta a capo della cattedra di
canto. "La voce di questo cantante, scrive "l'Unita", degna della grande
tradizione russa, sostenuta da una pronuncia limpidissima, da una chiarezza di
fraseggio davvero esemplare. Toni cos morbidi e forti insieme, suoni gravi
cos facili non si ascoltano troppo spesso".
In occasione del bicentenario del Teatro alla Scala nel 1978 Evghenij
Nesterenko si esibito a Milano nella parte di Filippo II, re di Spagna, in
mondovisione del "Don Carlos" di Verdi (per la TV) insieme a Elena
Obrastzova (Eboli). I due cantanti sovietici hanno avuto un successo trionfale
in quel la recita.
Nel 1981 a Vercelli Nesterenko era a capo della giura internazionale
nella sezione del canto e fu decorato della medaglia il "Viotti d'oro" per la
lirica "quale interprete insuperabile delle musiche di compositori russi e per la
sua magistrate interpretazione del "Boris" nei pi famosi teatri del mondo". "Il
pubblico che gremiva il salone Dugentesco, ha festeggiato a lungo il cantante
russo Eugenio Nesterenko che ha offerto ai vercellisi un recital di canti russi e
di brani lirici, mandando in visibilio il pubblico.
81
Copyright & A K-C
Duetto di Euridice e di Orfeo
dallopera Euridice
Musica di J.Peri
Euridice:
Quella son io,
Per cui piangeste
Sgombare ogni timore,
Donzelle amate
E spiro e vivo anchio
Mirate, donne, il mio crin,
E del bel volto mio.
Orfeo:
Gioite al canto mio,
Selve frondose
Gioite, amati colli,
E dogni intorno
Eco rimbombi
Da le valli ascose.
Aria di Orfeo
dallopera Orfeo di C. Monteverdi
Tu semorta, semorta mia vita
Ed io respiro,
Tu seda me partita,
Per mai pi, mai pi tornare
Ed io rimango: no, no,
Che se i versi,
Alcuna cosa ponno,
Nandr sicuro
A pi profondi abbassi
E intenerito il cor
Del Re de lombre
Meco trarotti a riveder le stele
O se ci negherammi empio destino
Rimarr teco in compagna di morte
Addio terra, addio cielo e sole, addio!
Arietta
Alessando Scarlatti (16601725)
Sento nel core
Certo dolore,
Che la mia pace
Turbando va.
Splende una face
Che lalma accende
Se non amore,
Amor sar
82
Copyright & A K-C
Aria di Rosaura
dallopera Rosaura di A. Scarlatti
Qual mia colpa, o sventura
Mha rapito il mio ben
Lidlo mio?
Dimmi, o caro infidel,
Che tho fattio?
Se delitto ladorarti,
Io son rea dun grande error.
Tu, signor de miei voleri
E tiranno di pensieri
Altra colpa che lamarti
Non ritrovo nel mio cor.
Aria di Rosina
Dallopera Il barbiere di Siviglia di G. Piasello
Gi riede primavera
Col suo fiorito aspetto
Gi il grato zeffiretto
Scherza fra lerbe e i fior. Tornan le
fronde agli alberi,
Lerbette al prato tornano,
Ma non ritorna a me
La pace del mio cor
Io piango afflitta e sola
Misera pastorella
Non la perduta agnella,
Ma il pastoral Londor
Aria
G. Piasello
Nel cor pi non mi sento
Nel cor pi non mi sento
Brillar la giovent
Cagion del mio tormento
Amor,sei colpa tu.
Mi pizzichi, mi struzzichi,
Mi pungichi, mi mastichi
Che cosa questo, ahim?
Piet,piet, piet!
Amore un certo che
Disperar mi fa!
Duetto di Carolina e di Paolino
dallopera Il matrimonio segreto di D. Cimarosa
Carolina:
Io ti lascio perch uniti
Carolina:
No, non viene
83
Copyright & A K-C
Che ci trovi non sta bene.
Ah tu sai chio vivo in pene
Se non sono vicina a te.
Paolino:
Vanne, s vane non prudenza
Di lasciarci trovar soli.
Ah, tu sai che il cor minvoli
Quando vai lontan da me.
Paolino:
S, s adesso
Carolina:
Dammi un altro amplesso,
Non vienne,
Ah, pietade troveremo
Se il ciel barbaro non .
Aria di Migacle
dallopera Olimpiade di N. Piccinni
Se cerca, se dice:
Lamico dov?
Lamico infelice
Rispondi, mor.
Ah, no! s gran duolo
Non darle per me:
Rispondi, ma solo,
Piangendo, part.
Che abisso di pene
Lasciare il suo bene.
Lasciarlo per sempre,
Lasciarlo cos.
Aria di Dircea
dallopera Demafoonte di L. Cherubini
In te spero, o sposo amato;
Fido a te la sorte mia;
E per te, qualunque sia,
Sempre cara a me sar.
Pur che a me nel morir mio
Il piacer non sia negato
Di vantar che tua son io
Il morir mi piacer.
Cavatina di Almaviva
dallopera Il barbiere di Seviglia di G. Rossini
Se il mio nome saper vio bramate
Dal mio labbro il mio nome ascoltate,
Io son Lindoro, che fido vadoro
Che sposa vi bramo che a nome
Lamoroso e sincero Lindoro
Non pu darvi, mia cara, un tesoro,
Ricco non sono, ma un core vi dono.
Unanima amante che fida e
84
Copyright & A K-C
Vi chiamo
Di voi sempre parlando cos,
Dallaurora al tramonro del d.
costante,
Per voi se la sospira cos,
Dallaurora al tramonto del d.
Aria di Elvira
dallopera Puritani d V. Bellini
Qui la voce sua soave
Mi chiamava e poi spar.
Qui giurava esser fedele,
E poi, crudele, e mi fugg!
Ah! Mai pi qui assorti insieme
Nella gioia desospir
Ah! Rendentemi la speme, } Bis
O! lasciatemi morir
Duetto di Elvira et di Arturo
dallopera I Puritani di V. Bellini
Elvira: Dunque mami, mio Arturo?
S?
Arturo: Vieni fra queste braccia,
Amor, delizia e vita,
Vieni, non mi sarai rapita.
Fimch ti stringo al cor
Ad ogni instante ansante
Ti chiamo a te sol bramo
Ah, vieni, mi ripeti; io tamo
dimmenso amore.
Elvira: Caro, non ho parola
Chesprima il mio contento:
Lalma elevar, mi sento in estasi
damor.
Ad ogni instante asante
Te chiamo, e te sol bramo ah
Caro, vieni,tel ripeto,tamo
Tamo dimmenso amore, s
Tel ripeto,sentilo Artur, dal mio cor
Dunque mami, mio Artur?
Cavatina di Rosina
dallopera Il barbiere di Siviglia di G. Rossinni
Una voce poco fa
Qui nel cor mi risuon
Il mio cor ferito gi
E Lindor fu che il piag.
S Lindoro mio sar
Lo giurai,lo vincer
Il tutor ricuser
Io lingegno aguzzer,
Alla fin s accheter
E contenta io rester
S, Lindoro mio sar
Lo giurai, lo vincer.
85
Copyright & A K-C
Aria di Otello
dallopera Otello di GVerdi
Niun mi tema
Sanco armato mi vede. Ecco la fine
del mio cammin
Oh! Gloria! Otello fu.
E tu come sei pallida!
E stanca, e muta, e bella,
Pa creatura, nata sotto maligna
stella.
Fredda, come la casta tua vita, e in
cielo assorta.
Desdemona! Desdemona!
Ah! morta! morta!
Morta!
Pra ducciderti sposa
Ti baciai, oh morendo
Nellombra ovio giacio
Un bacio, un bacio ancora
Un altro bacio
Aria di Eboli
dallopera Don Carlos di G. Verdi
O don fatale, o don crudel
Che in suo furor mi fece il cielo!
Tu che ci fai si vane, altere, ti
maledico,
Ti maledico, o mia belt
Versar, versar sol posso il pianto,
Speme non ho, soffrir dovr!
Il mio delitto orribil tanto
Che cancellar mai nol potr
Ti maledico, o mia belt!
O mia Regina, io timmolai al folle
error di questo cor.
Sono in un chiostro al mondo
Ormai dovr celar il mio dolor
Ohim, ohim!
O mia Regina, solo in un chiostro al
mondo
Ormai dovr celar il mio dolore!
Oh ciel! E Carlo? A morte domain
Gran Dio! A morte andar vedr!
Ah! Un di mi resta, le speme
marride, sia benedetto il ciel!
Lo salver! Un di mi resta, ah sia
benedetto il ciel!
Lo salver!
86
Copyright & A K-C
Aria di Rodolfo
dallopera La Bohme de G. Puccini
Che gelida manina,
Se la lasci riscaldar.
Cercar che giova?
Al buio non si trova.
Ma per fortuna
E una notte di luna,
E qui la luna
Labbiamo vicina.
Aspetti, signorina,
Le dir con due parole
Chi son, che faccio e come vivo.
Vuole?
Chi son? Sono un poeta.
Che cosa faccio? Scrivo.
E come vivo? Vivo.
In povert mia lieta
Scialo da gran signore
Rime ed inni damore.
Per sogni, per chimere
E per castelli in aria
Lanima ho milionaria.
Talor dal mio forziere
Ruban tutti i gioelli
Due lardi: gli occhi belli,
Ventar col voi pur ora
Ed i miei sogni usati
Tosto son dileguati.
Ma il furto non maccora
Poich vha preso stanza
Una dolce speranza.
Or che mi conoscete
Parlate voi. Chi siete?
Vi piace dirlo?
Arioso di Canio
Dallopera I Pagliacci di R. Leoncavallo
Vesti la giubba e la faccia infarina.
Le gente paga e rider vuole qua.
E se Arlecchin tinvola Colombina,
Ridi, Pagliaccio e ognun applaudir!
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il
pianto;
In una smorfia il singhiozzo el
dolor
Ah!... Ridi, Pagliaccio sul tuo amore
infranto!
Ridi del duol che tavvelena il cor!
87
Copyright & A K-C
Romanza di de Grieux
dallopera Manon Lescaut di G. Puccini
Donna non vidi mai simile a questa
A dirle! Io tamo
A nuova vita lalma mia si desta.
Manon Lescaut mi chiamo!
Coma queste parole profumate
Mi vagan nello spirito,
E ascose fibre vanno a carezzare.
O sussuro gentil,deh! Non cessare!...
Manon Lesacut mi chiamo!
Sussuro gentil, deh! Non cessare!
avatina di Norma
dallopera Norma di V. Bellini
Dormondo entrambi
Non vedran la mano che li percuote!
Non pentirti, o core: viver non
ponno
Qui supplizio, e in Roma
obbrobrio avran peggior supplizio
assai
Schiavi duna matrigna
Ah, no: giamai, muioano,s!
Non posso avvicinarmi, un gel mi
prende e in fronte mi si solleva il crin
I figli uccido!
Teneri figli, essi, pur dianzi, delizia
mia
Essi, nel cui sorriso il perdono del
ciel mirar credei!
Ed io li svener!
Di che son rei!
Di Pollion son figli:ecco il diletto;
essi per me morti, muoian per lui, e
non si pena anche la sua somigli.
Feriam
Ah, no!
Son miei figli!
Aria di Giulietta
dallopera I Capuleti e Montecchi di V. Bellini
Eccomi in lieta vesta
Eccomi adorna come vittima allara.
In qual terra taggiri?
Dove inviarti i miei sospiri?
88
Copyright & A K-C
Oh! Almen potessi qual vittima
Cader dellara al piede!
O nuzialli tede,abborrite cos,
Cos fatali per me faci ferali!
Ardo, una vampa, un foco
Tutta mi strugge,
Un refrigerio al venti
Io chiedo invano
Ove sei Romeo?
Oh quante volte ti chiedo
Al ciel piangendo,
Con quale ardor tattendo
E inganno il mio desir!
Raggio del tuo sembiante
Oh parmi il brillar del giorno,
Oh,laura che spira intorno
Mi sembra un tuo sospir.
Romanza del dottore Malatesta
dallopera Don Pasquale di G. Donizetti
Bella siccome un angelo
In terra pellegrina,
Fresca siccome il giglio
Che sapre sul mattino,
Occhio che parla e ride
Sguardo che il cor conquide,
Chioma che vince lbano,
Sorriso incantator.
Alma innocente ingenua,
Che s medesma ignora,
Modestia imparreggiabile
Bont che vinnamora.
Ai miseri pietosa,
Gentil, dolce amarosa,
Il ciel lha fatta nascere
Per far beato un cor
Arietta di Pollione
Dallopera Norma di V. Bellini
Va, crudele, al Dio spietato
Offri in dono il sangue mio;
Tutto, ah, tutto ei sia versato,
Ma lasciarti non possio,
No, non posso.
Sol promessa al Dio tu fosti,
Ma il tuo core a me si diede.
Ah, non sai quell che mi costi
Perchio mai rinunzi a te
89
Copyright & A K-C
Scena ed aria di Violetta
dallopera la Traviata di G. Verdi
E strano! E strano! In core scolpiti ho
quegli accenti!
Sara per me sventura un serio
amore?
Che risolvi, o turbata anima mia?
Nulluomo ancora taccendeva
O gioia chio non conobbi,
esser amata amabdo!
E sdegnarla possio per laride folle
del viver mio?
Ah fors lui che lanima, solinga
netumulti, godea sovente
pingere de suoi colori occulti
Lui, che modesto e vigile allegre
soglie ascese e nuova
febbre accese destandomi allamor!
A quellamor ch palpito
delluniverso interno, misterioso,
altero, croce e delizia al cor. Folle!
Folle!
Delirio vano questo! Povera donna,
sola, abbandonata in questo
popoloso deserto che appelano
Parigi, che spero pi?
che far deggio Gioire di volutt
ne vortici,
Di volutt perir! Gioir! Gioir!
Sempre libera deggio follegiare di
gioia in gioia,
voche scorra il viver mio pei
sentieri del piacer.
Nasca il giorno, o il giorno muoia,
sempre lieta ne ritrovi,
a diletti sempre nuovi dee volare il
mio pensier.
Aria di Violetta
dallopera La Traviata di G. Verdi
Violetta legge la lettera:
Teneste la promessa La disfida
ebbe luogo
Il Barone fu ferito, per migliora
Alfredo in stranio suolo.
Il vostro sagrifizio io stesso gli ho
svelato.
Egli a voi torner pel suo perdono
Oh, come son mutata! Ma il Dottore
a sperar pure mesorta!
Ah, con tal morbo ogni speranza
morta!
Addio del passato bei sogni ridenti;
Le rose del volto gi sono pallenti
Lamore dAlfredo perfino mi
manca, conforto,
90
Copyright & A K-C
io pur verr
Curatevi meritate un avvenir
migliore Giorgio Germont.
E tardi Attendo, attendo n a me
giungon mai!
Sostegno dellanima stanca,
conforto, sostegno, ah,
della traviata, sorridi al deso, a lei
deh, perdona,
Tu accoglila, o Dio! Ah, tutto fini!
Canzonetta del duca
dallopera Rigoletto di G. Verdi
La donna mobile,qual piuma al E sempre misero, chi a lei saffida,
Chi le confida mal cauto il core!
vento,
Pur mai non sentesi felice appieno
Muta daccento e di pensiero
Chi sul quell seno non liba amore.
Sempre un amabile leggiardo viso,
La donna mobil, qual piuma al
In pianto o in riso, menzognero.
La donna mobile, qual piuma al vento,
Muta daccento e di pensier!
vento,
Muta daccento e di pensier!
Recitativo e aria di Alfredo
dallopera La Traviata di G. Verdi
Lunge da lei per me non vha diletto.
Volaron gi tre lune dacch la mia
Violetta
agi per me lasci, dovizie, amori
e le pompose feste ovagli omaggi
avvezza,
vedea schiavo ciascun di sua
bellezza.
Ed or contenta in questi ameni
luoghi
tutto scorda per me
Qui presso a lei io rinascermi sento,
E dal soffio damor rogenerato
scordo
Neguadi suoi tutto il passato!
Demiei bollenti spiriti
Il giovanile ardore ella tempr
Col placido sorriso dellamor.
Dal di che disse: Vivere io voglio a
te fedel.
delluniverso immemore io vivo
Quasi in ciel!
91
Copyright & A K-C
Aria di Don Carlo
dallopera Ernani di G. Verdi
Oh, sommo Carlo, pi del tuo nome
le tue virtudi aver vogliio
sar, lo guiro a te ed a Dio,
delle tue gesta imitator.
Perdono a tutti.
(Mie brame ho dome).
Sposi voi siate, vamate ognor.
A Carlo Magno sia Gloria ed onor.
Sar, lo guiro a tee d a Dio
delle tue gesta imitator.
A Carlo Magno gloria e onor!
Aria di Renato
dallopera Un ballo in maschera di G. Verdi
Alla vita che tarride
Si speranze e gaudio piena,
Daltre mille, e mille vite
Il destino sincatena!
Te perduto, ov la patria
Col suo splendido avvenir?
E sar dovunque, sempre chiuso il varco
Alle ferrite, perch scudo del tuo petto
del popolo laffetto?
Dellamor pi desto lodio
le sue vittime a colpir.
Te perduto, ov la patria
col suo splendido avvenir?
Dell amor pi desto lodio
le sue vittime a colpir.
Te perduto, ov la patria
col suo splendido avvenir?
Cantabile di Gilda
dallopera Rigoletto di G. Verdi
Ciel, dammi corragio!
Tutte le feste al tempio,
mentre pregava Iddio,
bello e fatale un giovane
offriasi al guardo mio
Se i labbri nostril tacquero,
dagli occhi il cor parl.
Furtivo fra le tenebre
sol ieri a me giungeva
Sono studente, povero
commosso mi diceva
e con ardente palpito
amor mi protest
Part, il mio core aprivasi
a speme pi gradita,
quando improvvisi apparvero
color, che mhanno rapita,
e a forza qui maddussero
nellansia piu crudel.
92
Copyright & A K-C
Santa Lucia
(musica di Teodoro Cottrau)
1. Sul mare luccica
Lastro dargento
Placida londa
Prospero il vento
Venite all agile
barchetta mia,
Santa Lucia
Santa Lucia
2. In fra le tende
Bandir la cena
In una sera
Cos serena
Chi non domanda?
Chi non des`ia?
Santa Lucia
Santa Lucia
3. O bella Napoli
O suol beato
Ove sorridere
Volle il creato
Tu sei limpero
Dell`armon`ia
Santa Lucia
Santa Lucia
4. Con questo zeffiro
Cos soave
O, com`e bello,
star sulla nave
5. Mare si placido
Vento si caro
Scordar fa i triboli
6. Or che tardate
Bella la sera
spira unauretta
fresca e leggiera
7. Su,passeggieri
Venita via
Santa Lucia
Santa Lucia al marinaro
8. E va grindando
Con allegria,
Santa Lucia
Santa Lucia
9. Venite allagile
Barchetta mia,
Santa Lucia
Santa Lucia
Aria del conte di Luna
dallopera Il trovatore
Tutto desetro; n per laura ancora
suona
Lusato carme.
In tempo io giungo!
Ardita, e qual furente amore ed irritato
93
Ah, no, non fia daltri Leonora!
Leonora mia!
Il balen del suo sorriso
duna stella vince il raggio,
il fulgor del suo bel viso
Copyright & A K-C
Orgoglio chiesero a me.
Spento il rival, caduto ogni ostacol
sembrava
A miei desire;
Novello e pi possente ella ne appresta
laltare!
novo infonde a me corragio.
Ah! Lamore, ondardo, le favelli in
mio favor,
Sperde il sole dun suo sguardo
La tempesta del mio cor.
Cavatina di Figaro
dallopera Il barbiere di Siviglia di Rossini
Largo al factotum della citt
Presto a bottega, che lalba e gi.
Ah che bel vivere,
Che bel piacere
Per un barbiere di qualit.
Ah bravo Figaro, bravo bravissimo
Fortunatissimo, per verit.
Pronto a far tutto la notte e il giorno
Sempre dintorno in giro sta.
Miglior cuccagna per un barbiere,
Vita pi nobile,no, non si da.
Rasori e pettini, lancette e forbici,
Al mio commando tutto qui sta.
V la risorsa poi del mestiere
Colla donnetta, col cavaliere.
Ah che bel vivere, che bel piacere
Per un barbiere di qualit.
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono,
Donne, ragazzi, vecchi, fanciulle,
Qua la parrucca presto la barba
Qua la sanguina Figaro Figaro
presto il biglietto
Ahim, che furia, chef folla,
Uno alla volta, per carit.
Figaro son qua, Figaro l, Figaro
su, Figaro gi
pronto, prontissimo, son come il
fulmine,
sono
bravo
Figaro,
bravo,
bravissimo.
A te firtuna non mancher!
Sono il factotum della citt!
Duetto di Santuzza e di Turiddu
dalla Cavaleria rusticana di Mascagni
Turiddu Tu qui, Santurza?
Santuzza Qui taspettavo
Santuzza No, non mentire, ti vidi
volgere gi dal sentier
94
Copyright & A K-C
Turiddu E Pasqua, in chiesa non vai?
Santuzza Non vo. Debbo parlati.
Turiddu Mamma cercavo
Santuzza Debbo parlati.
Tiruddu Qui no.
Santuzza Dove sei stato?
Turiddu Che vuoi tu dire? A
Francoforte.
Santuzza No, non ver.
Turiddu Santuzza, credemi.
E stamattina thanno scorto presso
luscio di Lola.
Tuiddu Ah, mi ha spiato.
Santuzza No, te lo guiro, a noi lha
reccontato compare Alfio, il marito,
poco fa
Tiruddu Cos ricambi lamor che ti
porto? Vuoi che muccida?
Santuzza Oh, questo non lo dire.
Turiddu Lasciami dunque,
lasciami .
Romanza di Santuzza
dalla Cavaleria rusticana
Voi lo sapete, o mamma,
Prima dandar soldato,
Turridu aveva a lola
Eterna fegiurato.
Torn, la seppe sposa;
e con un nuovo amore
volle spegner la fiamma
che gli bruciava il core
mam, lamai
Quellinvida dogni delizia mia,
Del suo sposo dimentica,
Arse di gelosia
Me lha rapito,
Priva dellonor mio,
dellonor mio rimango;
Lola e Turridu samano
Io piango.
Duetto di Almaviva e di Bartolo
dallopera Il barbiere di Siviglia di Rossini
Conte. Pace e gioia sia con voi
Bartolo -Mille grazie, non sincomodi.
Conte Gioia e pace per millanni!
Bartolo Obbligato in verit.
Conte Pace e gioia sia con voi.
Bartolo Mille grazie, non
sincomodi.
Ma che barbara giornata! Tutti quanti
a me davanti! Che crudel fatalit!
Conte Il vecchion non mi conosce:
oh mia sorte fortunata!
Ah, mio ben! Fra pochi istanti
parlerem con libert!
Bartolo Insomma, mio signore, chi
95
Copyright & A K-C
Conte Gioia e pace per millanni.
Bartolo Obbligato in verit (Questo
volto non m ignoto, non ravviso, non
ricordo ma quell volto, non capisco
chi sar).
Conte (Ah se un colpo andato a
vuoto; gabbar questo balordo un novel
travestimento pi propizio a me sara).
Gioia e pace, pace e gioia!
Bartolo Ho capito. (Oh ciel, che
noia!)
Conte Gioia e pace, ben di core!
Bartolo Basta, basta, per piet. (Ma
che perfido destino!)
lei, si pu sapere?
Conte Don Alonso, professore di
musica ed allievo di Don Basilio.
Bartolo Ebbene?
Conte Don Basilio, sta male il
poverino, ed in sua vece
Bortolo Sta mal? Corro a vederlo.
Conte Piano, piano. Non mal cos
grave.
Bartolo (Di costui non mi fido).
Andiamo, andiamo.
Duetto di Gilda e di Rigoletto (Alto)
dall'opera Rigoletto di G. Verdi
Rigoletto Figlia!
Gilda Mio padre!
Rigoletto A te dappresso trova sol
gioia il oppresso.
Gilda Oh quanto amore.
Rigoletto Mia vita sei! Senza te in
terra qual bene avrei?
Gilda Oh quant'amore! Padre mio!
Rigoletto O figlia mia!
Gilda Voi sospirate! Che v'ange
tanto? Lo dite a questa povera figlia.
Se v'ha mistero, per lei sia franto,
ch'ella conosca la sua famiglia.
Rigoletto Tu non ne hai.
Gilda Qual nome avete?
Rigoletto A te che importa?
Gilda Se non volete di voi
parlarmi.
Gilda. II nome vostro ditemi, il
duol che s v'attrista.
Rigoletto. A che nomarmi,
inutile! Padre ti sono, e basti. Me
forse al mondo temono, d'alcuno ho
forse gli asti, altri mi maledicono.
Gilda. Patria, parenti, amici, voi
dunque non avete?
Rigoletto. Patria, parenti, amici!
Culto, famiglia, la patria, il mio
universo in te.
Gilda. Ah se pu lieto rendervi,
gioia la vita a me. Gi da tre lune
son qui venuta, n la cittade ho ancor
veduta, se il concedete, farlo or
potrei.
Rigoletto. Mai, mai! Uscita,
dimmi, unqua sei?
Gilda. No.
96
Copyright & A K-C
Rigoletto Non uscir mai.
Rigoletto. Guai!
Gilda Non vo'che al tempio.
Gilda. Ah, che dissi!
Rigoletto -Oh ben tu fai!
Ben te ne guarda! Potran
Gilda Se non di voi, almen chi sia, seguirla, rapirla ancora! Qui dun
buffone si disonora la figlia e se ne
fate ch'io sappia la madre mia.
ride.
Rigoletto Deh non parlare al
Orror! Ol!
misero del suo perduto bene. Ella
senta, quell'angelo, piet delle mie
pene. Solo, difforme, povero, per
compassion mi am.Ah, mora, le
zolle cprano lievi quel capo
amato.Sola or tu tu resti al misero.
Dio,sii ringraziato.
Aria di don Basilio
(Atto I)
dall'opera II barbiere di Siviglia di G. Rossin
La calunnia un venticello
un'auretta assai gentile
che insensibile, sottile,
leggermente, dolcemente
incomincia a sussurrar.
Piano piano, terra terra,
sotto voce sibilando,
va scorrendo, va scorrendo,
va ronzando, va ronzando;
nell'orecchio della gente
s'introduce destramente,
e le teste ed i cervelli
fa stordire e fa gonfiar.
Dalla bocca fuori uscendo
lo schiamazzo va crescendo
prende forza a poco a poco,
vola gi di loco in loco,
sembra il tuono, la tempesta
che nel sen della foresta
va fischiando, brontolando,
e ti fa d'orror gelar.
Alla fin trabocca e scoppia,
si propaga, si raddoppia
e produce un'esplosione,
come un colpo di cannone,
un tremuoto,
un temporale
che fa l'aria rimbombar.
E il meschino calunniato,
avvilito, calpestato
soto il pubbilco flagello
per gran sorte va a crepar!
97
Copyright & A K-C
Serenata di Ernesto
dall'opera Don Pasquale di G. Donizetti
Com' gentil
la notte a mezzo april!
E azzurro il ciel!
la luna senza vel;
Tutto languor pace, mistero, amor.
Ben mio, perch ancor non vieni a me?
Sembra che l'aura
Formi sospiri e accenti;
Del rio nel murmure
Carezze e bad senti;
Il tuo fedel si strugge di desir;
Nina crudel mi vuoi veder morir!!
Poi quando sar morto piangerai,
Ma ritornarmi in vita non potrai.
1. . . .
(Italiano contemporaneo esercizi per la lingua parlata). .: ,
2008. 445 .
2. ., . . .:
, 2006. 688 .
3. . . . .: ,
2006. 496 .
4. ., . . ., 2005.
5. . . . .
- . , 2010.
6. . 2 . Litaliano corso
intermedio. .: - , 2010.
7. . . .: - , 2010.
8. .. . Litaliano pratico.
Corso avanzato. .: , 2008.
9. .-., .
. .: - , , 2008.
10. Internet. Yandex. Wikipedia, Mht, LEnciclopedia libera. 2009.
98
Copyright & A K-C
1. . ! .: , . 2008.
2. Berlitz . . . .:
- , 2006.
3. .-. . : Living Laguage.
Random House Company, 2005.
4. . . . - , 2010.
5. ., P., .
. - , , 2009.
6. . . . . . , 2007.
7. . . 100 . .: - , , 2008.
8. . . . .: , , 2008.
9. . BellItalia:
. .: - , 2006.
1.
2.
3.
4.
5.
.. - . .: ,
2008.
.. - (70 . ). .: -
, 2008.
.. . .: - 2008.
. . -, - . .: , , 2007.
Yandex.www.multitran.ru, .
99
Copyright & A K-C
1
A
Adriana Lecouvreur (F. Cilea)
Africana (G. Mayerbeer)
Aida (G. Verdi)
Alzira (G. Verdi)
Amleto (F. Faccio)
Andrea Chenier (U. Giordano)
Angelo (m) di fuoco (S. Prokopief)
Anna Bolena (G. Donizetti)
Arabella (R. Strauss)
Astuzie (f, pl) femminili )
(D. Cimarosa)
Attila (G. Verdi)
B
Barbiere di Siviglia (G. Verdi, G. Rossini)
Barbiere di Siviglia ovvero
la precuazione inutile (G. Paisiello)
Bataglia di Legnano (G. Verdi)
Boheme (G. Puccini)
C
Carmen (G. Bizet)
Caterina Cornara (G. Donizetti)
Cavalleria rusticana (P. Mascagni)
Capuletti e Montecchi (V. Bellini)
Cerentola (G. Rossini)
Cesare Borgia (L. Leoncavallo)
Chatterton (L. Leoncavallo)
Clemenza di Tito (A. Scarlatti)
Clorinda (C. Monteverdi)
Corsaro (G. Verdi)
100
Copyright & A K-C
D
Don Carlos (G. Verdi)
Don Pasquale (G. Donizetti)
Don Sebastiano (G. Donizetti)
Due Foscari (G. Verdi)
Edgar (G. Puccini)
Elisir (m) damore (G. Donizetti)
Ernani (G. Verdi)
Fanciulla del West (G. Puccini)
Favorita (G. Donizetti)
Faust (C. Gounod)
Fedora (U. Giordano)
Finta principessa (L. Cherubini)
Figlia del regimento (G. Donizetti)
Forza del destino (G. Verdi)
Gelose (N. Puccini)
Gazza ladra (G. Rossini)
Gioconda (A. Ponchielli)
Giasone (F. Cavalli)
Giovanna dArco (G. Verdi)
Gianni Schicchi (G. Puccini)
Gloria (F. Cilea)
-
I
Ifigenia inAulide (L. Cherubini)
Inconoronazione (m) di Poppea
(C. Monteverdi)
Italiana in Algeri (G. Rossini)
Ivan Susanin (M. Glinka)
La bella molinara (G. Paisiello)
La finta principessa (L. Cherubini)
Le astuzie femmimile (D. Cimarosa)
Le gelose (N. Piccini)
Linda di Chamounix (G. Donozetti)
101
Copyright & A K-C
Lohegrin (R. Wagner)
Lombardi (G. Verdi)
Luisa Miller (G. Verdi)
Lucia di Lammermoor (G. Donizetti)
Lucrezia Borgia (G. Donizetti)
Machbeth (G. Verdi)
Madam Butterfly (G. Puccini)
Maja (Rimskii Korsarov)
Manon Lescaut (G. Puccini)
Masnadieri (G. Verdi)
Matrimonio segreto (D. Cimarosa)
Medea (L. Cherubini)
Mois in Egitto (G. Rossini)
Molinara (G. Puccini)
Mondo di luna (N. Piccini)
Nabucco (G. Verdi)
Nina, o la pazza per amore
(G. Paisiello)
Norma (V. Bellini)
Nozze di Figaro (W. Mozart)
,
O
Olandese volante (R. Wagner)
Orfeo (C. Monteverdi)
Otello (G. Verdi, G. Rossini)
Pagliacci (R. Leoncavallo)
Pescatori di perle (G. Bizet)
Prigioniere superbo (G. Pegolesi)
Puritani (V. Bellini)
Rigoletto (G. Verdi)
Ritorno di Ulisse in patria
(C. Monteverdi)
Roberto, o il Diavolo
(G. Meyerbeer)
,
102
Copyright & A K-C
S
Salome (R. Strauss)
Scala di Seta (G. Rossini)
Savonarola (R. Leoncavallo)
Semiramide (G. Rossini)
Serva-Padrona (G. Paisiello)
Simon Boccanegra (G. Verdi)
Sposa venduta (B. Smetana)
Soeur Angelica (G. Puccini)
Sonnambula (V. Bellini)
Stravaganze del conte
-
T
Tabarro (G. Puccini)
Tahnhuser (R. Wagner)
Tancredi (G. Rossini)
Tilda (F. Cilea)
Torquato Tasso (G. Donizetti)
Tosca (G. Puccini)
Traviata (G. Verdi)
Tristano e Isolda (R. Wagner)
Trionfo delonore (A. Scarlatti)
Turandot (G. Puccini)
Ugnotti (G. Mayerbeer)
Vespri Siciliani (G. Verdi)
Vestale (G. Spontini)
Villi (G. Puccini)
Wally (A. Catalani)
Wozzeck (A. Berg)
, -
Z
Zaza (R. Leoncavallo)
Quinto Fabio (L. Cherubini)
103
Copyright & A K-C
A
Abbellimento, m
Abilit, m
Abisso, m
Accendere
Accentare
Accenti, m, pl
Accento, m
Acchetarsi
Acuti, m, pl
Addurre
Agilit, f
Agitare
Agitazione, f
Aguzzare
Aggredire le note
Alma, f
Altero
Ameno
Amplesso, m
Ampiezza, f
Apprezzare
()
1. , ;
2.
1. , ;
2.
Appassionato, m
Ara, f
Argomento, m
Arguzia, f
Aria, f di sortita
Aria, f tripartite
Arietta, f
Arrichirsi
Arridere
Arioso, m
Arte, f scenica
Artifizio, m
Ascesa, f
Assumere il nome
Attaccare
Audacia, f
Aura, f
Autodidata, f
Avere parte la
musica
Avvento, m
Avvilito
( )
(
)
B
Baleno, m
Balordo, m
Baritono, m
Baritono, m alto
Baritono, m
commune
Bel canto, m
104
(
,
Copyright & A K-C
Barocco
1. ,
;
2.
Basso, m
Basso, m buffo
Basso, m cantante
Basso, m nobile
Basso, m profundo
1. ;
Battere
2.
Bemolle, m
Biglietto, m
Brama, f
Bramare
Brano, m
Brontolare
Bocciatura, f
Bravura, f
(.) ;
C
Cadenza, f
Caff-concerto, m
Cagione, m
Cammino, m
Canoro
Cantilena, f
Canto, m
Canto, m lugubre
Canto, m monodico
Canzone, f
Canzoniere, m
Carme, m
Capacit, f
(A) capella, f
Capo, m
(Col da) capo
aritatevole
Carme, m
(In) carne e ossa
Castello, m in aria
Casto
Cattivare
Cavalleresco
Cavallo, m di
bataglia
Cello, m
Cemballo, m
Chiarezza, f
Cigno, m
Colore, m
Colpa, f
Colpire
Compagnia, f
Comparsa, f
Complessit, m
Complesso, m
dellopera
Condiscepolo, m
(In) consequenza
Contendere il primate
Contapunto, m
Contralto, m
(
)
Conquidere
Coral, m
Corda, f
Corde, f, pl vocali
onferire
Contribuire
,
Conoro
,
Corale, m
,
Core, m
Corteggiare
Costringere
Crepare
Cresciuto, m
105
Copyright & A K-C
D
Dare sfogo
Debutare
Decollo, m
Dedicare
Delirio, m
Delitto, m
Delusione, f
Destarsi
Destino, m
Desto
Diesis, m
Dileguare
Disfida, f
Disperare
Dissolvimento, m
Diva, f
Dolore, m
Domare
Donatore, m
Donnare
Dotare
Dote, f
Dovizia, f
Duolo, m
Duttilit, f
1. ;
2.
E
Eccitare
lentusiasmo
Efficacia, f di
accento
Efficacia, f di
azione
Egro
Eloquenza, f
Eminente
Emissione, f
Emissione, f
della voce
Empio
Esaltare
Esibizione, m
Esecutore, m
Esecuzione, f
Esecuzione, f di
concerto
Eseguire
Esibirsi
Esigente
Esordire
Esordio, m
Esprimere
Esprimere dote
Essere dintorno in
giro sta
Essere portare
Estensione, m
Estinto
F
Face, f
Facolt, f
Factotum, m
Fama, f
Fibra, f
Fidare
Fido (fidele)
Figura, f
106
Copyright & A K-C
Famoso
Fare qualche
apparizione
Fare fiasco
Fare parte
Fare sparire
Fare stordire
Favellare
Ferale
Fermata, f
Fianco
Fiato, m
(
)
Figuratio, m
Filato, m
(A) fior di labbra
Flagello, m
Flessibile
Fioritura, f
Fonte, m
Forziere, m
Fragile
Frassegio, m
Frenesia, f
Funebro
Fuoco, m
Furente
Furioso
(.) ,
G
Gabbare
Genere (m)
Giacere
Giocoso
Gioiello (m)
Giro (m) artistico
,
,
Giubba, f
Giurare
Giusto
Glissare
Gloria, f
Gorgheggio, m
Grandioso
Gusto, m
; ,
I
Icatenarsi
Iddio, m
Imagine, f
Immedesinarsi
Immolare
Impadronirsi
Impegno, m
Imperiare
Impetto, m
Imposato
,
,
,
()
107
Infondere
Infranto
Ingegno, m
(Al) inizio
Insegnamento, m
Insieme, m
Insinuante
Insuperabile
Internire
Interpretare
Copyright & A K-C
Improvviso
Inadatto
Incantevole
Incarnare
Incidere
Incisione, f
Indole
Infarinare la faccia
Infernale
Inflessione, m
,
;
Interpretazione, m ,
Interprete, m
Introduzione, m
Ispirazione, m
Ispessimento, m
Involare
L
Lagrima, f
Lamento, m
Languire
Languore
Largo
Laurarsi
Lazzo, m
Legare
Legato, m
Leggiardo
Leggio, m
Libare
Lieta vesta, f
Limitato
Limpido
Lirica, f
Livello, m artistico
Liuto, m
Lodo, m
Luce, m della ribalta
Lugubre
Luminoso
M
Maggiore
Magistrale
Maledire
Maligno, m
Malinconia, f
Malizioso
Malleabilit, f
Marcare
Martellato, m
Massa, f
Melodrama, f
Mettere in scena
(A) mezza voce, f
Minore, m
Misterioso
Mobile
Moderato
Monodia, f
Morbido
Morbo, m
Mormore
(mormorio), m
Moto, m
108
Copyright & A K-C
Messa, f in scena
Mesto
Mezza forte
Mezzo piano
Mezzo, m
Mezzo soprano, m
(
)
Motteto, m
Movimento, m
Musica, f da camera
Musica, f da chiesa
Musica, f sacra
N
Narrante
Nascere
Nascita, f
Negheramare
Ninna-nanna, f
Nota, f
Nota, f acuta
Noto
Note, f, pl di petto
Note, f, pl di testa
Nume
O
Obbrobrio, m
Offrirsi
Offucarsi
(In) onda
Ondata, f vivificatrice
Onorificenza, f
Opera, m seria
Opera, m semiseria
Orgoglio, m
Ospitare
Ostacolo, m
Ostinato
P
Pace, f
Padronanza, f
Palcoscenico, m
Paradise
Parlanti, m, pl
Patrimonio, m
Partita, f vinta
Passione, f
Pellegrino
Pentirsi
Picchiettare
, Piet, m
Pietra, f di paragone
Pio
Pizzicare
Poderoso
Portentoso
Possente
Potenza, f
(.)
Potenza f, di suono
Prece, f
109
Copyright & A K-C
Perdere limportanza, f
Perfezionamento, m
Pesante
Pregio, m
Perizia, f
Percuotere
Pezzo, m
Pezzo, m dinsieme
Pezzo, m di musica
(A) piacere
Pianto, m
(A) piena voce, f
Prediletto
Pregare
Prendere stanza
Procurare
Proibirare
Proseguire
Protagonista, m
Protestare
Prova, f
Prudenza, f
Pungicchiare
(pungire)
Puntare
Q
Quardi di massa, m, pl
Quasi
,
Quarta, f
Quinta, f
Quinte, f, pl
R
Rallentare
Rapire
Rappresentare
Rappresentazione
Ravvisare
Recita, f
Recitare
Recitare cantando
Recitativo, m secco
,
,
Regia, f
Registrazione, f
Reo
,
Ricambiare
Ricercato
Riconoscimento, m
Rigore, m
Rima, f
Rime, f, pl
Rinforzare
110
Rinunzare
Rio, m
Ripetere
Ripetizione, f
Ripresa, f
Risalere
Riscuotere sucesso
Risorgimento, m
Risorsa, f
Ritardare
Robusto
Ritornello, m
Rivelare
Riuscire
Riuscita, f
Romanzo, f
Ronzare
Rubato, m
1. ;
2.
,
Copyright & A K-C
S
Sacro
Saggio, m
Scala, f
Schiamazzo, m
Scialare
Scritturare
,
,
Scorrare
Scuro
Scherzare
Sdegnare
,
(In) seguito
Serio
Sfoggiare
Sfumatura, f
Sincero
Sinfonia, f dapertuta
Singhiozzo, m
Singolo, m
Sinistro
Sirere
Smorfia, f
Smorzare
Snello
,
Soave
,
Sodalizio, m
Soggetto, m
Sognare
Sogno, m
Solingo
Sollecitare
Sollevare
, ,
Sonoro
Sontuoso
Sopracuta, f
Sopportare la tensione
Soprano, m
Soprano, m leggiero
Soprano, m lirico
Sorte, f
Sostenuire
Sostituire
Sparire
Specie in forza di
Spegnersi
Speme, f
Sperdere
Spettare il merito
Spianato
Spinta, f
Spirito, m
Splendere
Squillo, m
Staccato
Stentarea
Strappare le lagrime
Strascinare
Stravincere
Strepitoso
Stringere
Strillone, m
Struggere
Strumentale, m
Stuzzicare
Sucesso, m
Supplizio, m
Suscitare
Sussare
Sussuro, m
Svelare
Svenare
111
-
,
,
,
Copyright & A K-C
T
Teda, f
Telasticit, f
Tempestoso
Tendere
Tenebroso
,
Tenore, m
Tenore, m
drammatico
Tenore, m di grazia
Tenore, m di forza
Tenore, m lirico
Tenero
Tenuto
,
Tessitura, f
Timbrato
Tono, m
Tormento, m
Tourne, m
Trama, f
Tramonto, m
Transfigurazione, m
Trattare
Trattazione, f
Tratto, m
Tremuoto, m
Trillo, m
Trionfare
Trionfo, m
Truccatura, f
Tumulto, m
, ,
U
Uguale
Unirsi
Urlo, m
, ,
Usanza, f
Usato
V
Vagamente
Vagare
Voce, f bianca
Valore, m
Vampa, f
(In) vece di
Veloce
Venerazione, m
Venticello, m
Versare il pianto
Veta, f suprema
Via
Vigoroso
Vincitore, m
Zeppo
Virile
Visione, m
Vivace
Vocalizzo, m
(Sotto) voce, f
Voce, f trivalente
(A) voce, f bassa
(A) piena voce, f
Volume, m
Vollut, f
Volta, m
(Uno alla) volta
Votrice, m
112
Copyright & A K-C
Infinito
Presente
Indicativo
accogliere
accolgo
() accogli
accoglle
accorgersi
()
andare
()
Futuro
semplice
accoglier
mi accorgo mi accorger
vado
vai
va
andiamo
andate
vanno
apparire
appaio
() (
apparisco)
andr
apparir
Imperfetto
accoglievo
Passato remoto
accolsi
accogliesti
accolse...
Participio
passato
accolto
(c avere)
mi accorgevo mi accorsi
ti accorgesti...
andavo
andai
andasti
ando
andammo
andaste
andarono
accorto(mi)
(c essere)
andato
(c essere)
apparivo
apparso
(c essere)
apparii
apparsi
apparvi
appartenere appartengo apparterr
(
)
appartenevo appartenni
appartenesti
appartenne...
appartenuto
(c essere)
aprire
r
()
aprir
aprivo
aprii
( apersi)
aperto
(c avere)
ardere
(,
)
ardo
arder
ardevo
arsi ardesti
arse...
arso
(c avere
essere)
attendere
()
attendo
attender
attendevo
attesi attendesti atteso
attese...
(c avere)
avere
()
ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno
avr
avrai
avr
avremo
avrete
avranno
avevo avevi
avevamo
avevate
avevano
ebbi avesti
avemmo
aveste
ebbero
113
avuto
(c avere)
Copyright & A K-C
Infinito
avvenire
()
Presente
Indicativo
Futuro
semplice
Imperfetto
avviene
avverr (3 .) Avveniva
(3 .)
(3 .)
avvengono
(3 .)
Passato remoto
Participio
passato
avvenne (3 .) avvenuto
avvennero (3 .) (c essere)
benedire
be-nedico
()
benedir
benedicevo
benedissi
benedicesti
benedisse...
bere
()
bevo bevi
beve
berr
berrai
berra
bevevo
bevvi
bevuto
bevesti bevve... (c avere)
cadere
()
cado
cadr
cadrai
cadra
cadevo
caddi
cadesti
cadde...
caduto
(c essere)
chiedere
chiedo
(,
)
chieder
chiedevo
chiesi
chiedesti
chiese...
chiesto
(c avere)
chiudere
chiudo
()
chiuder
chiudevo
chiusi
chiudesti
chiuse...
chiuso
(c avere)
cogliere
()
coglier
coglievo
colsi
cogliesti
colse...
colto
(c avere)
colgo
benedetto
(c avere)
commuovere commuovo commuover
()
commuovevo commossi
commuovesti
commosse...
commosso
(c avere)
comparire
compaio
()
comparivo
comparii
comparvi
comparsi
comparso
(c essere)
compiere
compio
compir
compire
(compisco)
(,
)
compivo
compii
compisti
compi...
compiuto
compito
(c avere)
comporre
()
componevo
composi
componesti
compose...
composto
(c avere)
compongo
componi
compone
comparir
comporr
comprendere comprendo comprender
(,
)
comprendevo compresi
comprendesti
comprese...
114
compreso
(c avere)
Copyright & A K-C
Infinito
Presente
Indicativo
Futuro
semplice
Imperfetto
Passato remoto
Participio
passato
concludere concludo
()
concluder
concludevo
conclusi
concludesti
concluse...
concluso
(c avere)
condurre
()
conduco
conduci
conduce
condurr
conducevo
condussi
conducesti
condusse...
condotto
(c avere)
conoscere
()
conosco
conosci
conosce
conoscer
conoscevo
conobbi
conoscesti
conobbc...
conosciuto
(c avere)
confondere confondo
(,
)
confonder
confondevo
confusi
confondesti
confuse...
confuso
(c avere)
convincere
()
convincer
convincevo
convinsi
convincesti
convinse...
convinto
(c avere)
coprire
()
coprir
coprivo
coprif (copersi) coperto
copristi
(c avere)
copri
(coperse...)
correggere
correggo
()
corregger
correggevo
corressi
correggesti
corresse...
corretto
(c avere)
correre
()
corro
correr
correvo
corsi
corresti
corse...
corso
(c avere)
costringere
()
costringo
costringer
costringevo
costrinsi
costringesti
costrinse...
costretto
(c avere)
crescere
()
cresco
crescer
crescevo
crebbi
crescesti
crebbe...
cresciuto
(c essere)
dare
()
do
dai
da
diamo
date
danno
dar
davo
diedi
desti
diede
demmo
deste
diedero
dato
(c avere)
convinco
115
Copyright & A K-C
Presente
Indicativo
Infinito
decidere
()
decido
Futuro
semplice
Imperfetto
Passato remoto
Participio
passato
decider
decidevo
decisi
decidesti
decise...
deciso
(c avere)
difendere
difendo
()
difender
difendevo
difesi
difendesti
difese...
difeso
(c avere)
diffondere
()
diffondo
diffonder
diffondevo
diffusi
diffondesti
diffuse...
diffuso
(c avere)
dire
(
-)
dico
dici
dice
diciamo
dite
dicono
dir
dirai
dir
diremo
direte
diranno
dicevo
dicevi
diceva
dicevamo
dicevate
diccvano
dissi
dicesti
disse
dicemmo
diceste
dissero
detto
(c avere)
dirigere
dirigo
(,
)
diriger
dirigevo
diressi
dirigesti
diresse...
diretto
(c avere)
di scutere
discuto
()
discuter
discutevo
discussi
discutesti
discusse...
discusso
(c avere)
disporre
()
dispongo
disponi
dispone
disporr
disporrai
disporr
disponevo
disposi
disponesti
dispose...
disposto
(c avere)
escludere
escludo
escluder
escludevo
esclusi
escludesti
cscluse...
espressi
esprimesti
espresse...
escluso
()
esprimere
esprimo
esprimer
esprimevo
()
(c avere)
espresso
(c avere)
essere
sono
sar
fui
stato
()
sei
sarai
eri
fosti
(c essere)
sar
era
fu
siamo
saremo
eravamo
fummo
siete
sarete
eravate
foste
116
Copyright & A K-C
Infinito
Presente
Indicativo
Futuro
semplice
Imperfetto
Passato remoto
Participio
passato
fare
faccio
far
facevo
feci
fatto
()
fai
farai
facevi
facesti
(c avere)
fa
far
faceva
fece
facciamo
faremo
facevamo
facemmo
fate
giungo
farete
giunger
facevate
giungevo
faceste
giunsi
giunto
giungesti
(c essere)
giungere
()
giunse...
incidere
incisi
inciso
(;
incidesti
(c avere)
incise...
includere
incido
includo
incider
includer
incidevo
includevo
()
intendere
intendo
intender
intendevo
()
introdurre
introduco
introdurr
introducevo
()
leggere
leggo
legger
leggevo
()
inclusi
incluso
includesti
incluse...
(c avere)
Intesi
Inteso
intendesti
(c avere)
introdussi
introducesti
introdotto
lessi
letto
leggesti
(c avere)
(c avere)
lesse...
mettere
()
metto
metter
mettevo
morire
()
muoio
muori
muore
moriamo
morite
muoiono
morr
morrai
morr
morremo
morrete
morranno
morivo
morivi
moriva
morivamo
morivate
morivano
117
misi
mettesti
mise...
morii
moristi
mori
morimmo
moriste
morirono
messo
(c avere)
morto
(c essere)
Copyright & A K-C
Infinito
muovere
()
Presente
Indicativo
muovo
muovi
muove
moviamo
movete
muovono
Futuro
semplice
Imperfetto
Passato remoto
Participio
passato
mover
moverai
mover
moveremo
moverete
moveranno
movevo
movevi
moveva
movevamo
movevate
movevano
mossi
movesti
mosse
movemmo
moveste
mossero
nascere
nasco
() nasci
nascer
nascevo
nacqui nascesti nato
nacque...
(c essere)
nascondere
()
nasconder
nascondevo
nascosi
nascondesti
nascose...
nascosto
(c avere)
offendere
offendo
()
offender
offendev
offesi
offendesti
offese..
offeso
(c avere)
offrire
offro
()
offrir
offrivo
offrii
(offersi)
offristi
offr
(offerse)
offerto
(c avere)
parere
()
paio
pari
pare
pariamo
parete
paiono
parr
parrai
parr
parremo
parrete
parrnno
parevo
parvi
(parsi)
paresti
parve
(parse)
paremmo
pareste
parvero
(parsero)
parso
( essere)
perdere
()
perdo
perder
perdevo
persi
perdesti
perse...
perso
(c avere)
permettere
pormetto
()
permetter
permettevo
permisi
permettesii
permise...
permesso
(c avere)
piacere
piaccio
() piaci
piace
piacciamo
piacete
piacciono
piacero
piacevo
piacqui
piacesti
piacque
piacemmo
piaceste
piacquero
piaciuto
(c essere
v. i)
nascondo
118
osso
(c avere)
Copyright & A K-C
Infinito
Presente
Indicativo
Futuro
semplice
Imperfetto
Passato remoto
Participio
passato
piangere
()
piango
pianger
piangevo
Piansi
piangesti
pianse...
pianto
(c avere)
rr
()
pongo
poni
pone
poniamo
ponete
pongono
porr
porrai
porr
porremo
porrete
porranno
ponevo
ponevi
poneva
ponevamo
ponevate
ponevano
posi
ponesti
pose
posto
(c avere)
potere
()
posso
puoi
puo
possiamo
potetc
possono
potr
potevo
potei
potesti
pote
potemmo
potestc
poterono
potuto
(c avere)
prendere
()
prendo
prender
prendevo
pres pren pre
preso
promettere
()
prometto
prometter
promettevo
promisi
promettesti
promise...
promesso
(c avere)
produrre
()
produco
produci
produce
produrr
producevo
produssi
producesti
produsse
prodotto
(c avere)
proporre
propongo
proporr
() proponi
propone
proponiamo
proponete
propongono
proponevo
proposi
proponesti
propose
proponemmo
proponeste
proposero
proposto
(c avere)
proteggere
()
proteggo
protegger
proteggevo
protessi
proteggesti
protesse...
protetto
(c avere)
raggiungere
()
raggiungo
raggiunger
raggiungevo raggiunsi
raggiungesti
raggiunse...
raggiunto
(c avere)
ridere
()
rido
rider
ridevo
riso
(c avere)
119
risi
ridesti
rise...
Copyright & A K-C
Infinito
Presente
Indicativo
Futuro
semplice
Imperfetto
Passato remoto
Participio
passato
rimanere
rimango
() rimani
rimane
rimaniamo
rimanete
rimangono
rimarr
rimanevo
rimasi
rimanesti
rimase
rimanemmo
rimaneste
rimasero
rimasto
(c essere)
rispondere
()
rispondo
risponder
rispondevo
risposi
rispondesti
rispose...
risposto
(c avere)
rompere
()
rompo
romper
rompevo
ruppi
rompesti
ruppe...
rotto
(c avere)
salire
()
salgo
sali
sale
saliamo
salite
salgono
salir
salivo
salii
salisti
sali
salimmo
saliste
salirono
salito
(c essere
avere)
sapere
()
so
sai
sa
sappiamo
sapete
sanno
sapr
sapevo
seppi sapesti
saputo
seppe sapemmo (c avere)
sapeste seppero
scegliere
()
scelgo
scegli
sceglie
scegliamo
scegliete
scelgono
sceglier
sceglievo
scelsi
scegli est i
scelse
scegliemmo
sceglieste
scelsero
Scelto
(c avere)
scendere
scendo
()
scender
scendevo
scesi
scendesti
scese...
sceso
(c essere
avere)
scrivere
()
scriver
scrivevo
scrissi
scrivesti
scrisse...
scritto
(c avere)
scrivo
120
Copyright & A K-C
Infinito
sedere
()
seguire
()
Presente
Indicativo
siedo
(seggo)
siedi
siede
sediamo
sedete
siedono
(seggono)
Futuro
semplice
sieder
(sedero)
siederai
sieder
siederemo
siederete
siederanno
seguo segui seguir
segue
smettere
()
Imperfetto
sedevo
sedevi
sedeva
sedevamo
sedevate
sedevano
seguivo
come
mettere
soffrire
()
soffro
soffrir
soffrivo
spegnere
()
spengo
spegni
spegne
spegniamo
spegnete
spengono
spingo
spegner
spegnevo
spinger
spingevo
stare (, sto
) stai
sta
stiamo
state
stanno
star
starai
star
stareme
starete
staranno
stavo
stavi
stava
stavamo
stavate
stavano
stringere
()
stringo
stringer
succedere
(,
)
succedo
succeed
(3 )
succeder
succeder
(3 )
spingere
()
Passato remoto
Participio
passato
sedetti (sedei)
sedesti
sedette (sede)
sedemmo
sedeste
sedettero
(sederono)
seduto
(c avere)
seguii
seguisti
segui...
seguito
(c avere)
smesso
(c avere)
soffrii
(soffersi)
soffristi
soffri
(sofferse)
spensi
spegnesti
spense
spegnemmo
spegneste
spensero
spinsi
spingesti
spinse...
stetti
stesti
stetti
stemmo
steste
stettero
sofferto
(c avere)
stringevo
strinsi
stringesti
strinse...
stretto
succedevo
succedeva
(3 )
successi
succed
successo
succeduto
(c essere)
121
spento
(c avere)
spin to
(c avere)
stete
( essere)
Copyright & A K-C
Infinito
tacere
()
Presente
Indicativo
Imperfetto
tacer
tacevo
terr
tenevo
tradurre
traduco
() traduci
(traducere) traduce
traducia
traducono
uccidere
uccido
()
tradurr
udire
()
Passato remoto
Participio
passato
tacqui
tacesti
tacque
tacemmo
taceste
tacquero
tenni
tenesti
tenne
tenemmo
teneste
tennero
taciuto
(c avere)
traducevo
tradussi
traducesti
tradusse
tradussero
tradotto
(c avere)
uccider
uccidevo
ucciso
(c avere)
odo
odi
ode
udiamo
udite
odono
udr
udivo
uccisi
uccidesti
uccise
udii
udisti
udi
udimmo
udiste
udirono
uscire
()
esco
esci
esce
usciamo
uscite
escono
uscir
uscivo
uscii
uscisti
usci
uscimmo
usciste
uscirono
uscito
(c essere)
vedere
()
vedo
(veggo)
vedr
vedevo
vidi
vedesti
vide...
visto
veduto
(c avere)
verr
venivo
venni
venisti
venne
venimmo
veniste
vennero
venuto
(c essere)
tenere
()
taccio
taci
tace
taciamo
tacete
tacciono
tengo
tieni
tiene
teniamo
tenete
tengono
Futuro
semplice
venire
vengo
() vieni
viene
veniamo
venite
vengono
(udir)
122
tenuto
( avere)
udito
(c avere)
Copyright & A K-C
Infinito
Presente
Indicativo
Futuro
semplice
Imperfetto
Passato remoto
Participio
passato
vincere
vinco vinci vincer
() vince
vincevo
vinsi
vinto
vincesti vinse... (c avere)
Volere
()
volevo
voleva
volevamo
volevate
volevano
volli
voile
volemmo
voleste
vollero
voglio
vuoi
vuole
vogliamo
volete
vogliono
vogliamo
volete
vogliono
vorro
vorra
vorremo
vorrete
vorranno
123
Voluto
(c avere)
Copyright & A K-C
. .
22.02.2011. 60841/16. .
. .-. . 5,6. . . . 7,9.
300 . 256
___________________________________________________________
: 650029, . ,
. , 19. . 73-45-83.
E-mail: izdat@kemguki.ru
124
Вам также может понравиться
- Л Акопян Музыка Xx Века СловарьДокумент855 страницЛ Акопян Музыка Xx Века Словарьolesya75% (4)
- Майкапар С. Годы ученияДокумент144 страницыМайкапар С. Годы ученияViktorОценок пока нет
- Женские партии в операх Дж. ВердиДокумент15 страницЖенские партии в операх Дж. ВердиДарья ЛитвяковаОценок пока нет
- ДИССЕРТАЦИЯ ЛогуноваДокумент333 страницыДИССЕРТАЦИЯ ЛогуноваДуховный ДругОценок пока нет
- Вайнкоп Ю.Я. - Что надо знать об опере PDFДокумент163 страницыВайнкоп Ю.Я. - Что надо знать об опере PDFMikluhoОценок пока нет
- итальянская музыкаДокумент10 страницитальянская музыкагаляОценок пока нет
- Bogoyavlenskiy S Ital Yanskaya Muzyka Pervoy Poloviny XX Vek PDFДокумент144 страницыBogoyavlenskiy S Ital Yanskaya Muzyka Pervoy Poloviny XX Vek PDFАна АнаОценок пока нет
- творчество вДокумент107 страництворчество вАлександр ВольскийОценок пока нет
- Автореферат Логунова оперы Верди финалДокумент22 страницыАвтореферат Логунова оперы Верди финалТатьянаОценок пока нет
- Верди Риголетто сцена из 2 действияДокумент11 страницВерди Риголетто сцена из 2 действияAlex ShtapuraОценок пока нет
- Зарубежные вокальные школыДокумент32 страницыЗарубежные вокальные школыМарианнаОценок пока нет